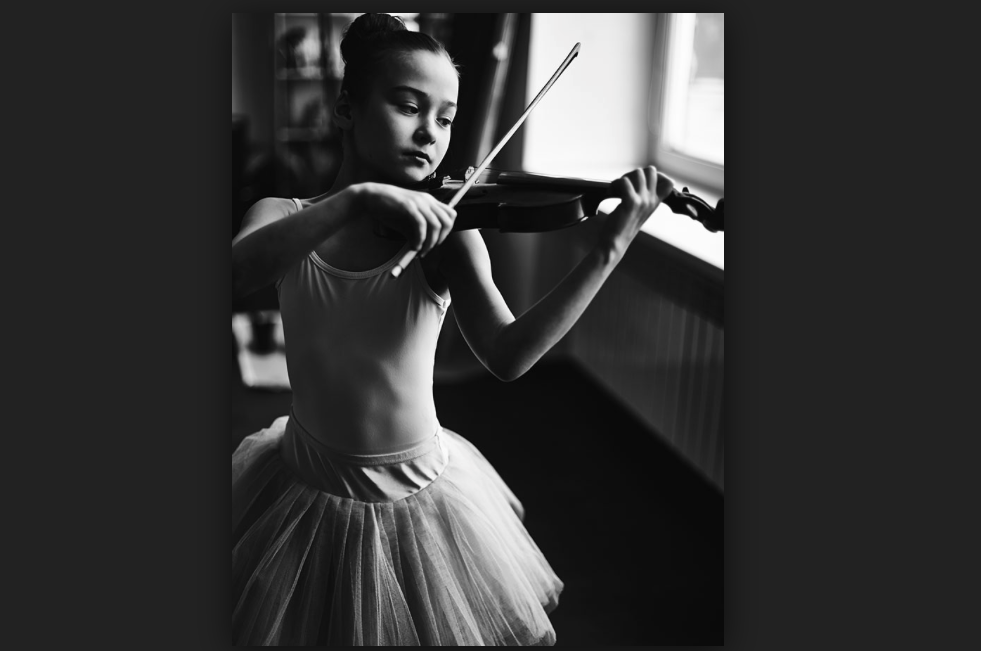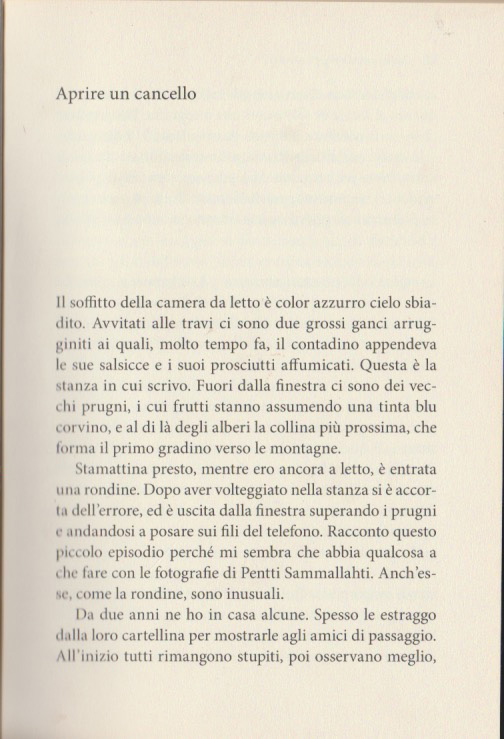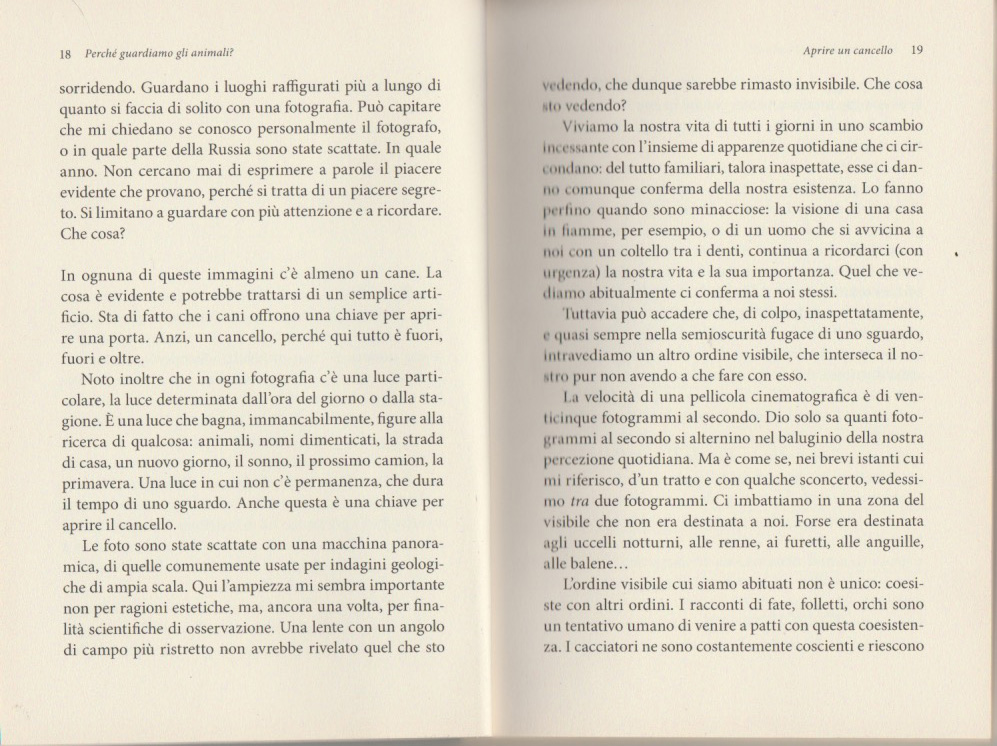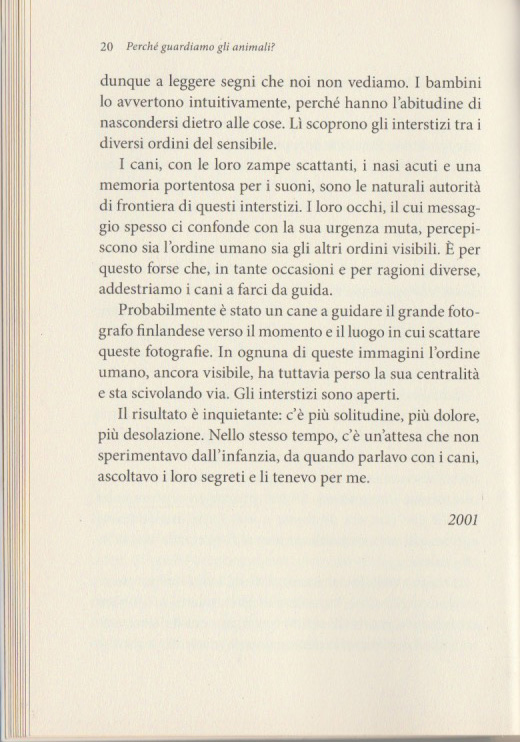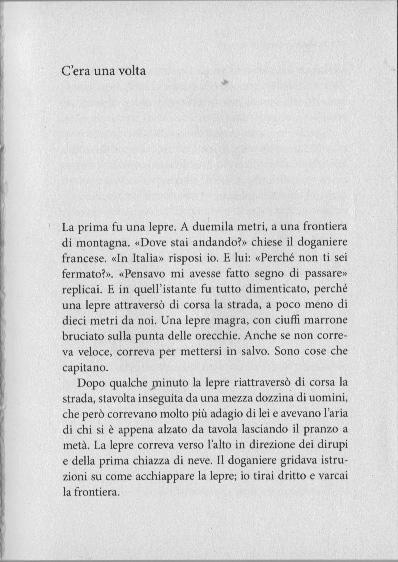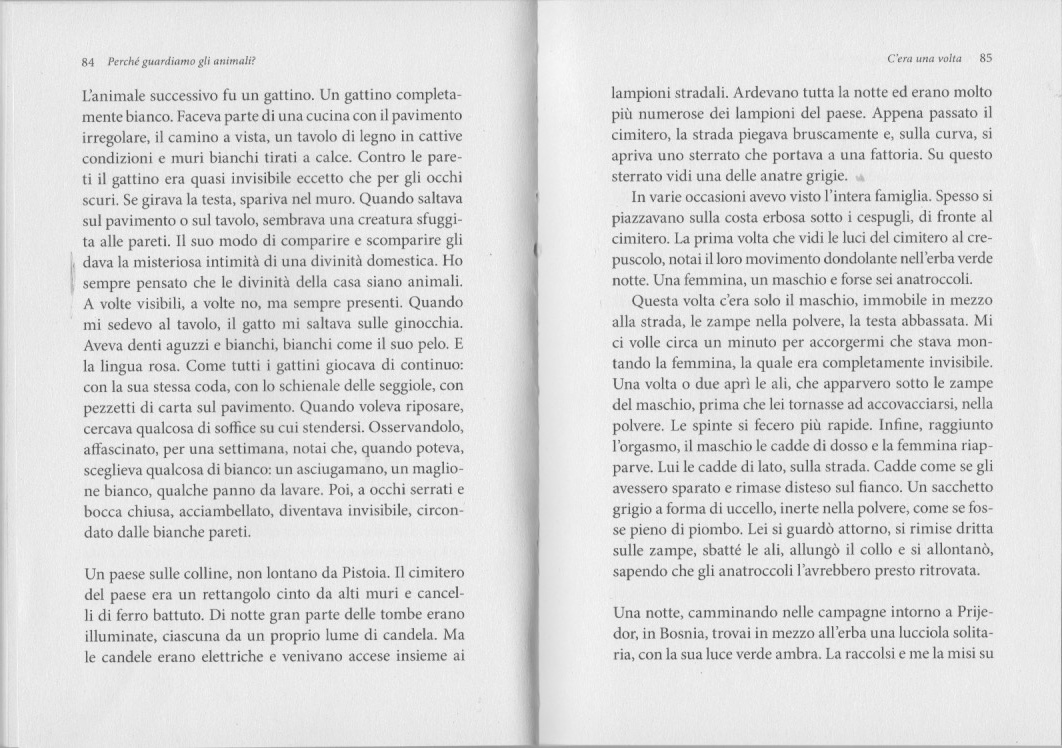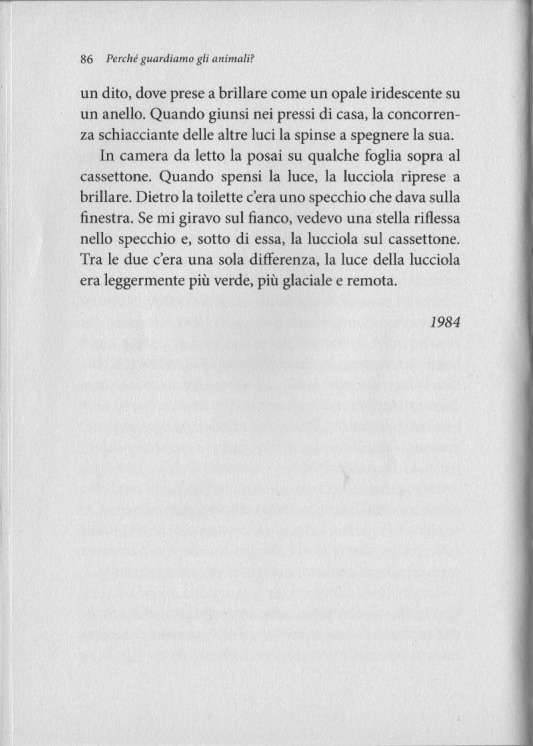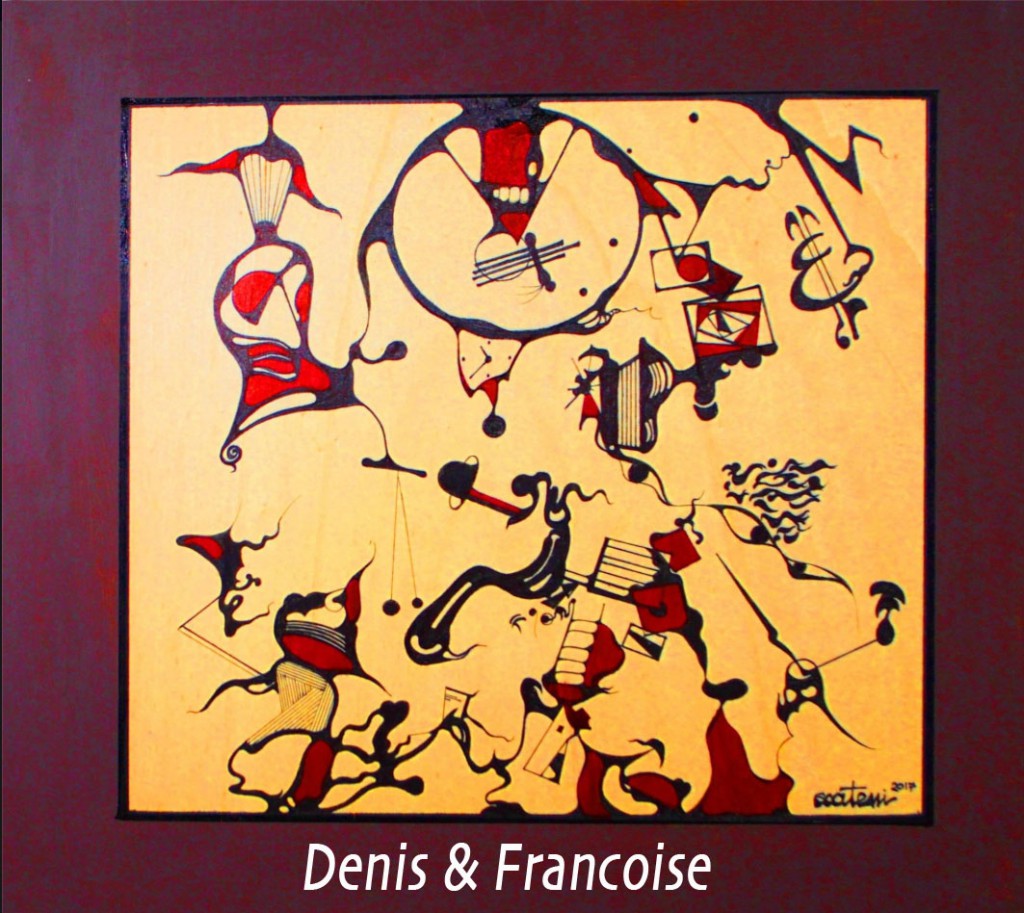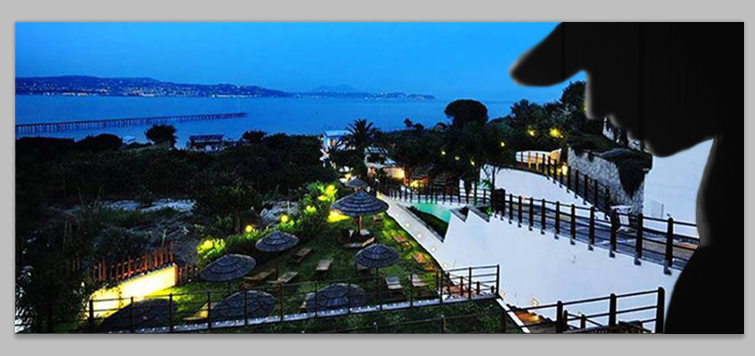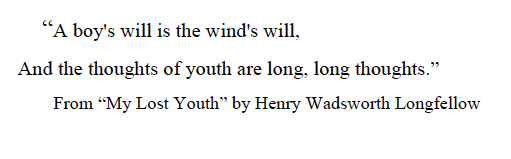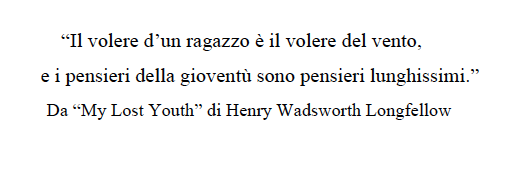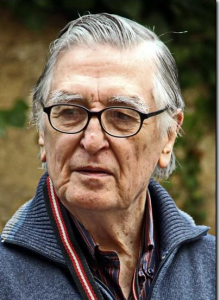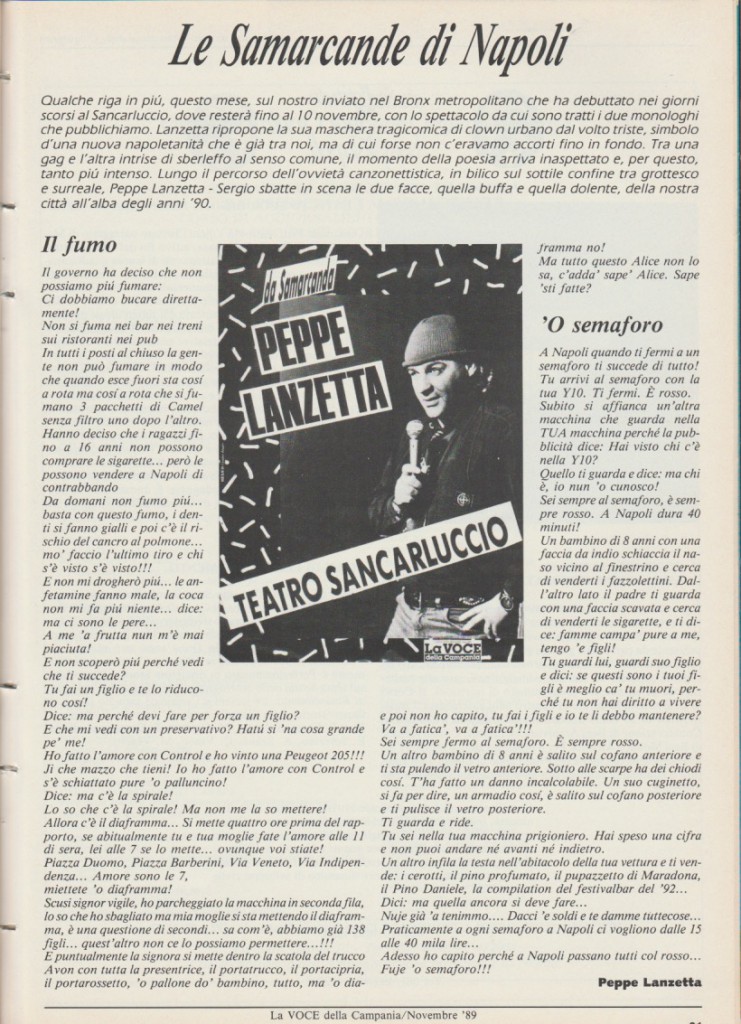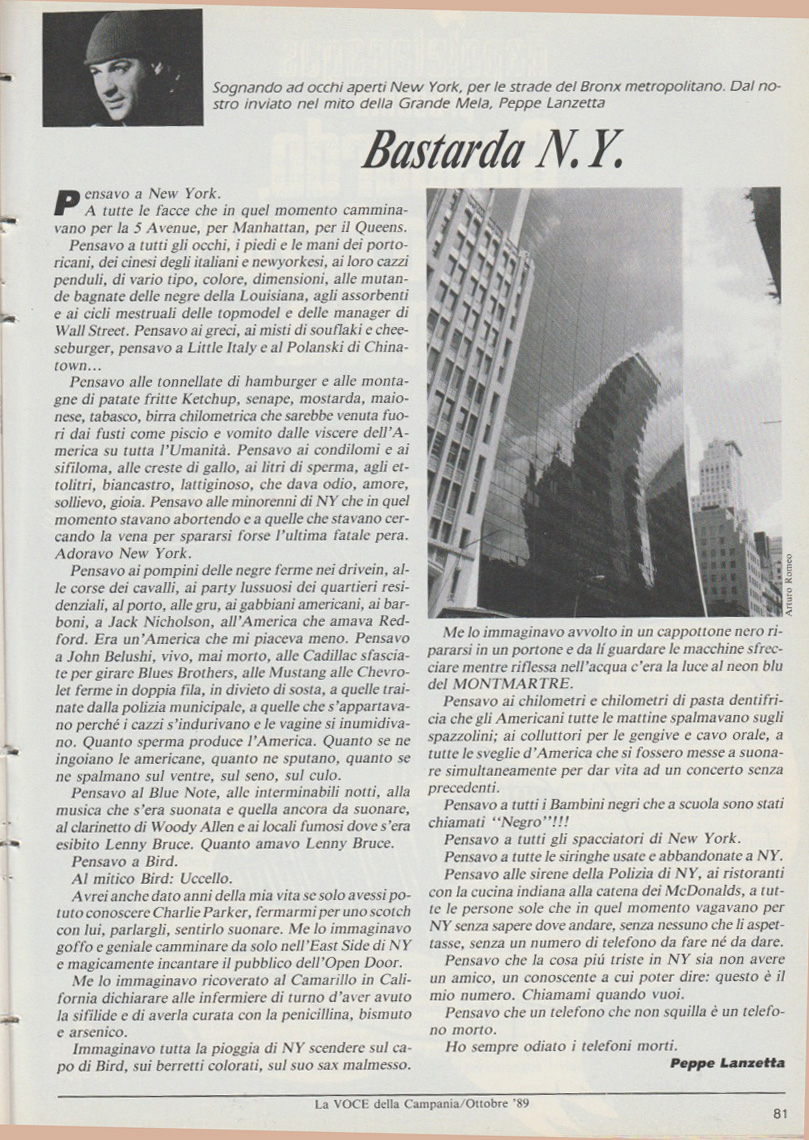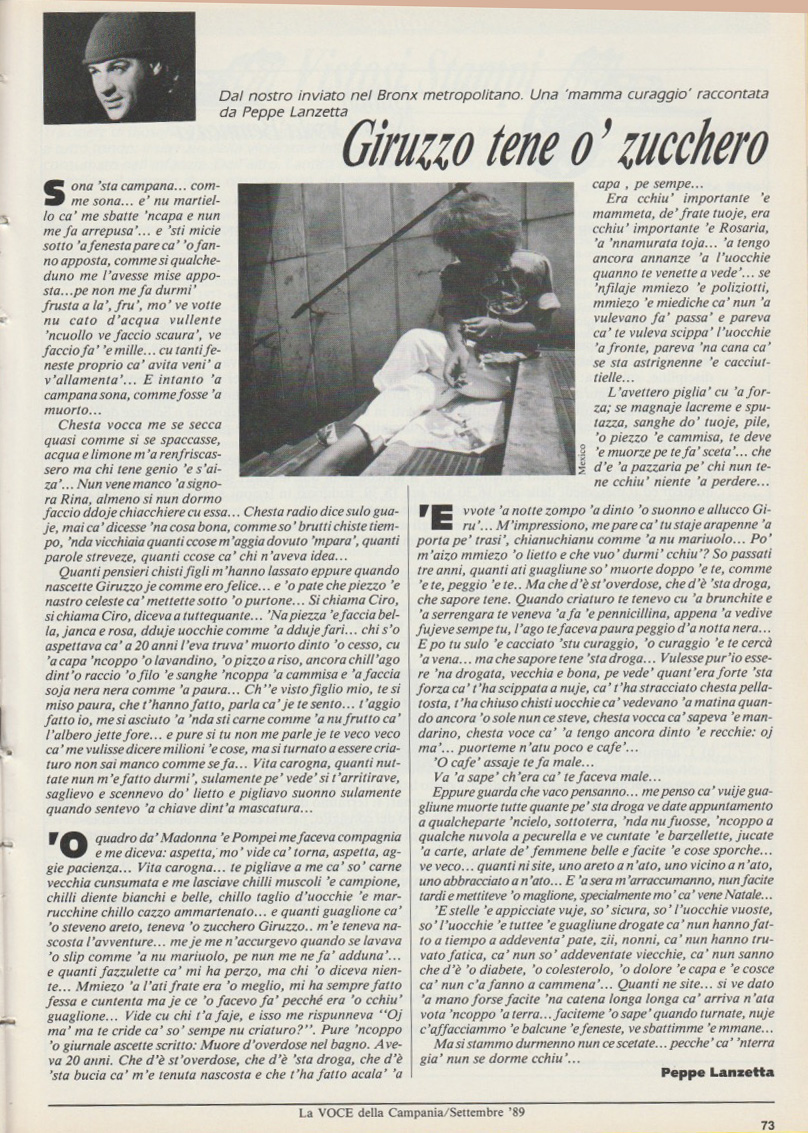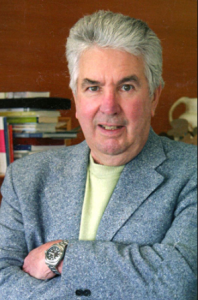Il Racconto di Domenica 31 dicembre 2017
Io invidio, tu invidi, egli invidia: noi invidiamo
di Luciano Scateni
L’invidia ti può nascere dentro con tre gradi di virulenza: bassa, media, massima.
Esserne esenti è cosa rara e da millenni è insita nella natura dell’intera umanità, con ammirevoli, ma rare eccezioni. La storia, in equilibrato mix con la leggenda, racconta la società dei cavernicoli, di boss dell’era trogloditica molto simili ai capibastone del nostro tempo: palestrati, per naturale esercizio muscolare richiesto dal mors tua vita mea dell’epoca e armati di potenti clave, vivevano di privilegi conquistati a randellate. Godevano delle migliori caverne, delle più prosperose femmine dell’area di loro dominio e risparmiavano le energie richieste dalla caccia, con l’imposizione della “decima”, cioè del diritto a un decimo delle prede altrui. I sottomessi mugugnavano, obbedivano e coltivavano un sano, deciso sentimento di invidia per i potenti.
Con un balzo millenario nel tempo eccoci ai tempi postbellici di metà novecento. Due bambini di pari età provano con il gioco a dimenticare la paura, il misero cibo di giorni e giorni, mesi, anni, gli stenti, i salti mortali di padri e madri cacciatori disperati di generi alimentari spariti dai negozi del settore. A Nino, figlio privilegiato di un gaudente immobiliarista, non fanno difetto i giocattoli, gli manca solo con chi condividerli. Lucio, coetaneo di un piano più su nello stesso edificio, è il rampollo ancora lontano dalla pubertà di un operaio disoccupato e di una madre tutta casa e chiesa, di ceto sociale dignitoso, ma povero. Nino, sfida la “filippica” di un padre classista e invita Lucio nella sua “casa dei giocattoli”. Lo accoglie nella sua stanza, spalanca per il piccolo ospite le ante di un capace armadio stracolmo di macchinine in miniatura, giochi da tavolo ancora avvolti nella carta regalo, altri aperti e sparpagliati, in pieno caos, migliaia di mattoncini da comporre in puzzle di legno, biglie, libri di favole, armi giocattolo. “Lucio lascia perdere tutto, montiamo la ‘‘ferrovia’”. Con collaudata abilità, incastra i binari, precisamente uno nell’altro, sistema la stazione di partenza, attiva i comandi elettrici e preme il tasto sul telecomando. La motrice trascina i vagoni alla massima velocità, Lucio entra stupito nel mondo dell’irreale così simile a quello vero e conosce per la prima volta il disagio di provare invidia. Gli rimane dentro per anni, insieme ad autocommiserazione, rabbia, frustrazione.
Secondo step, l’invidia maligna. Dall’asilo al master in biotecnologia, l’esemplare percorso di apprendimento di Francesca, terzogenita di una modesta famiglia di impiegati, ha coniugato intelligenza e razionalità e il miglior profitto che ne ha tratto non ha impedito un equilibrato rapporto con la condizione di giovane moderna dagli interessi molteplici. Compiuti i diciotto anni, acquisita la maturità classica, ha chiesto e ottenuto da un amico inglese, conosciuto in estate in Calabria, di trovarle un’occupazione part time a Londra per finanziare la frequentazione della facoltà di medicina Queen Mary, University of London. Il poi è laurea, specializzazione in cardiochirurgia, pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste di settore. La cerca e l’assume il Great Ormond Street Hospital, che nel breve volgere di cinque anni le affida la direzione del centro di cardiochirurgia. Nel reparto, che ospita casi di pazienti disperati, respinti da altre strutture perché non operabili, Elisabeth Cornely, erede di una famiglia di famosi medici londinesi, ha coltivato per anni l’ambizione di dirigere il reparto assegnato a Francesca. Giorno dopo giorno, montano in lei delusione, rabbia, invidia. Emerge con crescente evidenza il background familiare, che coniuga nazionalismo e xenofobia, alimentati dalla convinzione di aver subito un torto, responsabile l’“italiana”. Elisabeth non è donna da arrendersi e l’intenzione di vendicarsi diventa un progetto, da mettere in essere con ogni mezzo. Il complotto ha inizio con crescenti allusioni a motivi extra professionali che avrebbero favorito la rivale, fino a insinuare che non si sia fatta scrupolo di influenzare il presidente del consiglio di amministrazione dell’ospedale, con la sua avvenenza e la disponibilità a rapporti sessuali. Le voci maligne non hanno l’effetto sperato. Il presidente dell’ospedale è un uomo rispettabile, noto per serietà e onestà intellettuale, oltre che per essere felicemente fedele alla moglie e Francesca è considerata assolutamente irreprensibile. Theresa non demorde. Sottrae dalla farmacia di reparto dieci fiale di morfina con la chiave in possesso esclusivo della responsabile del reparto, lasciata per distrazione sulla sua scrivania. Quando si scopre la mancanza delle dieci dosi, Theresa fa in modo che il sospetto ricada su Francesca. L’indagine interna, seppure a malincuore, si conclude con l’accusa alla responsabile della cardiochirurgia: sospensione dall’incarico, in attesa di concludere gli accertamenti.
Terzo step. Piccoli nuclei in luoghi remoti della terra, preservati dai veleni delle società che si ritengono emancipate, vivono di una felice serenità, protetta da norme di comportamento solidale e molto dalla completa condivisione delle risorse che offre la natura. A sconvolgere ritmi di vita millenari provvedono abili esploratori, nella migliore delle ipotesi. Della minaccia più aggressiva, a tribù mai contagiate dal peggio della modernità, sono imputati i colossi dell’industria che rapinano i tesori energetici della terra, uno per tutti il petrolio e massacrano la foresta amazzonica sottraendo gigantesche e aree di alberi secolari a una delle più grandi oasi verdi del mondo.
La quota di umanità più consapevole della rapina in danno degli sfruttati, culminata con l’epoca delle colonizzazioni, maschera il pentimento con la presunzione di esportare progresso e civiltà. Con strategie aggressive, responsabili i Paesi industrializzati, le popolazioni sottomesse sono indotte a identificare il benessere del mondo “civilizzato” con la rappresentazione accattivante di show televisivi e documentari sul benessere materiale di chi li sfrutta. Paradossalmente, razzismo e xenofobia si alimentano con la consapevolezza della supremazia di valori delle popolazioni primitive, esenti dalle patologie di comportamento comuni tra i “socializzati”, da egoismi, prevaricazioni, violenze accaparratrici. Il sentimento d’invidia è reciproco: gli aborigeni sono abbagliati dal luccichio di grattacieli, sfarzo e agi dei ricchi, dalla tecnologia applicata, i privilegiati delle società del benessere rimpiangono la semplicità della vita a tu per tu con la natura. Nel tempo delle grandi incognite sul futuro dell’umanità, la quota più avveduta è attratta dal vivere antistress degli eredi di “quel che è mio è tuo”, regola istitutiva delle comunità tribali e sogna il ritorno alla condizione di primordiale compatibilità tra esseri viventi, del rispetto per cielo, mare e terra.
Gli abitanti di luoghi appena esplorati confrontano la spartanità millenaria del loro vissuto con le meraviglie del progresso compiuto dagli umani del nostro tempo. Crea disorientamento la percezione delle diversità tra chi detiene il controllo sulla ricchezza del petrolio e di altri generi primari in regime di monopolo e chi ne è espropriato. Comunque di invidia si tratta e l’antagonismo confluisce nel magma incandescente di opposti estremismi che si toccano.
Appendice. Un particolare e diffuso genere di invidia invade grandi moltitudini di ottimisti, che dopo razionali ritrosie a tentare la fortuna con lotterie milionarie (“ma figurati, si vendono milioni di biglietti, vuoi che vinca proprio io?”), decidono in extremis (“Perché non io?”) di comprare il biglietto della speranza. Spulciati con delusione i numeri vincenti, si scopre che ad Abbiategrasso il signor Mario Rossi, con un ticket da cinque euro, ha vinto cinque milioni. Dopo aver completato l’azione antidepressiva di mangiucchiarsi le dita, i perdenti evitano un imponente travaso di bile da invidia con l’augurio al vincitore di investire i milioni in fondi bancari tossici.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 17 dicembre 2017
Il cibo racconta Napoli
di Luciano Scateni
A pranzo, nell’intimità di un tete à tete, o nella collettività chic di un ristorante “3 Forchette”, si può scommettere su conversazioni a senso unico: “Come faceva la braciola mia madre…” “E la genovese di zì Carmela? la minestra maritata di ‘o Russo? L’appassionante dialogo su dieta mediterranea e obesità asseconda la libido culinaria del commensale, che ordina antipasto montagna, due “assaggi” di primi, salsicce e friarielli, una porzione di parmigiana, frutta di stagione, tiramisu, coppa di gelato Grom, caffè e ammazzacaffé. Peggio di così…C’è di peggio, compensato dalla scienza di settore interpretati da illustri sacerdoti dei fornelli e della letteratura di settore.
Lo dice chi sa e ha competenza per essersi applicato full time a impadronirsi della materia: gli incontinenti, soggetti privi di autocontrollo e succubi di scariche intempestive di acido cloridrico, assecondano i trilli della sveglia gastronomica del pranzo con parsimonia, spinti dal terrorismo del dietologo televisivo che omologa ogni chilo superfluo registrato dalla bilancia a una tappa del pericolo “patologia cardiovascolare”. Fanno squillare allarmi gli statistici del due più due fa quattro: esibiscono gli impressionanti numeri di italiani della categoria obesi e le frequenti indagini post mortem improvvisa dei disattenti a qualità e quantità di cibarie ingerite. Di conseguenza le cautele rispettate al tempo del primo pasto sono un’apprezzabile isola di disciplina culinaria e compensano il deficit cognitivo sull’importanza di una sostanziosa colazione del mattino. Infatti, il protagonista dell’incontrollato saliscendi dietetico, per antica trasgressione al consiglio di nutrizionisti, ingurgita solo uno yogurt al Kiwi, propedeutico di mattutina regolarità intestinale. Fosse l’unica disobbedienza ai fondamentali della buona alimentazione, passi. C’è di più: che alla metà di una mattinata con tassi elevati di umidità, le ossa diano segni di malessere da incipiente artrosi e che l’intolleranza al dolore si affronti con anti infiammatori che il bugiardino comanda di assumere “a stomaco pieno”. L’anta aperta del frigorifero provvede generosamente soddisfare l’emergenza. E passi. Aggravante di non poco conto è il crampo da fame fasullo, cioè inventato, delle ore 15. Con precisione quasi svizzera, a quell’ora il cervello non educato invia al soggetto in questione un messaggio coercitivo, con il convincente obiettivo di non consentire ai succhi gastrici di aggredire i delicati tessuti dello stomaco. Eh sì, nello sportello c’è una tavoletta di cioccolato fondente in stand by per diventare ingrediente di torta caprese. Pazienza si può riacquistare e lo stomaco lo reclama. A sera meglio ingurgitare poco e rispettare il fioretto della cena carboidrati. Sale alle stelle l’autostima e accompagnerebbe sogni di gloria, se a serata inoltrata il frigo non facesse un ammaliante occhiolino con una porzione abbondante di parmigiana di melanzane destinata alla sera successiva. Mangiarla fredda? Che fa, è comunque una leccornìa, esaltata da un favoloso aglianico del Taburno.
La premessa dice di una profonda incultura dell’alimentazione, vissuta di pari passo con la vergogna di ignorare se per la più semplice delle frittate si usa dell’uovo solo il tuorlo // in aggiunta ad altre gaffe alimentari nell’approccio alla cucina in tempi di emergenza per la moglie brava cuoca a letto con l’influenza. La crisi d’identità, a confronto con l’abissale distanza dai mitici scienziati del cibo quali sono i Vissani, Cracco e l’irresistibile Cannavacciuolo, diventa umiliazione permanente in fase di zapping televisivo che da mane a sera sconsiglia il nervoso pigiare sui tasti del telecomando nella speranza di incrociare qualcosa di dissimile da un miriade di studi televisivi con installazioni assortite di fornelli e pentole, ingredienti a gogò e dunque farina, formaggi, olio, pomodori, verdure, frutta di stagione, spezie note e sconosciute trasformati in diretta in succulenti, invitanti piatti.
Come contrastare lo stato di depressione da somaro dell’ultimo banco, che non distingue il burro dalla margarina, la scarola dalla lattuga, un’orata da un pesce bandiera? Come uscire dal tunnel buio infilato per eredità del padre che escludeva dai pasti ogni ben di dio del pescato? E’ un bel mangiare il rifiuto di capire se l’aragosta è bocconi prelibati o vezzo culinario da commensali snob? L’ostinata ripulsa di quanto offre il mare, con il trascorrere del tempo si è moltiplicata per tre. Indotto a salpare in notturna con un barcone da pesca, assisto atterrito al rito del pesce azzurro addentato crudo dai gitanti, che fa tanto isola dei famosi. Secondo round. I proprietari di una boutique del gusto nuova di zecca la promuovono all’esordio con inviti a sperimentare le chance di un giovane cuoco. Egli reduce da un corso intensivo di nouvelle cousine, ci spiattella senza alternative un malloppone di pesce crudo alla giapponese, che solo a guardarlo con occhio critico fa vomitare. La terza fase del rigetto si deve a un tour televisivo da Nord a Sud del Paese per indagare che effetto avesse prodotto nell’80 il via alla legge Basaglia che aboliva l’istituzione manicomiale. Il teleoperatore al seguito tifoso certificato del mangiare di lusso a spese della Rai, punta diritto al San Domenico di Imola dove un impeccabile cameriere, in un piatto con circonferenza esagerata, ci propina giusto al centro una rosetta sette centimetri per sette di spigola, manco a dirlo cruda ma ingentilita con decorazioni artistiche di erbe profumate e salsette indecifrabili.
Intreccio le dita a forma di x e giuro: “Il pesce? Buono per i gatti”. Si capisce che quella definitiva rinuncia abbatte per sempre la mia reputazione di buongustaio, traviato da un infanzia tutta a cotolette e patate fritte. Vivo in età post matrimoniale l’esperienza antitetica di consulente per un encomiabile editore napoletano che giudica maturi i tempi per assecondare la dilagante invasione di exploit gastronomici televisivi e un interesse di massa per la cucina bella e buona. Con i suoi tipi sforniamo non meno di dieci libri-saggio sullo scibile culinario. Ne resto folgorato, ma rimango a debita distanza dal condividerli nel quotidiano desinare e confermo il rozzo approccio a pranzi e cene. Scopro però che l’argomento è ben altro rispetto al tradizionale ricettario della nonna e ad alcuni caposaldi di settore, ma specialmente mi erudisco nel territorio specifico della cucina di casa nostra che svetta nella classifica italiana, complessivamente da Nobel. Una giravolta critica si impone in quanto globetrotter inviato Rai, allorché mi è dato di confrontare la genovese con gli spaghetti scotti, mollicci, che fumano su alcune tavole di ristoranti inglesi come contorno di altre diavolerie locali, o la parmigiana di melenzane con un mix di insetti croccanti rimasti nel piatto di un’accorsata trattoria indonesiana o la caprese tricolore che sposa la mozzarella di bufala doc a pomodori del Vesuvio e basilico di orti napoletani, con l’insipida feta di Corfù. Meno male, ignoro Mac Donald’s per non incorrere in reprimenda di amici e parenti. Sono nel giusto i trattati che esaltano la dieta mediterranea e hanno ragione i soci del club “Vogliamo saperne di più di storia, letteratura, rigore scientifico delle cibarie made in Naples.
Il garbato invito di Yvonne Carbonaro a tagliare con lei il nastro inaugurale di un suo prezioso spaziare letterario sul tema, concede nuove opportunità per liberarmi del mio misero e sprovveduto approccio ai piaceri della tavola. Per fortuna, in età da capelli candidi, come recita un vecchio saggio “non è mai troppo tardi”. L’impresa non ha un percorso propriamente agevole. Come ogni capitolo del vasto sapere, anche al “Cibo racconta Napoli” di Yvonne non è concesso dedicare frammenti di tempo o superficiale attenzione. L’arco spaziale della colta investigazione ha origini antiche, si arricchisce di tappe, ciascuna significativa per sistemare a dovere le tessere di un sontuoso mosaico, quasi un’enciclopedia di genere, una summa di ricerche, informazioni e commenti su Partenope. Allora appare banale l’orgia pubblicistica mondiale su pizza, spaghetti e caffè, ridotti a semplici corollari di un abecedario che invece, in uno degli indici analitici del libro di cui parliamo, include la bellezza di duecento ingredienti: dalla A di “Acqua” alla Z di “Zuppa di pesce” e attraversa i secoli, esplora usi e costumi alimentari di Osci, Greci e Romani, a seguire l’evoluzione della prescrizione di dosi e istruzioni per preparare ricette medievali, poi il buon stare alla tavola della Napoli vicereale e dei Borboni. Ciascuna di queste fasi è propedeutica dell’approccio alla cucina del nostro tempo nel pieno e saggio rispetto della tradizione: impegno per nulla lieve ma contributo essenziale per competere con chance di primato nell’universo agguerrito dei concorrenti di ogni latitudine, costretti con le debite eccezioni, a importare il meglio della nostra cucina e indotti a colpevole plagio di eccellenze nostrane. La mozzarella da qualche tempo è prodotto autoctono perfino della Gran Bretagna. Nei mercati di mezzo mondo, Italia inclusa, arrivano in container cinesi prodotti tipici del Bel Paese, l’invasione di pomodori è clamorosa, diffusa la truffa di false etichette e la pizza surgelata è pane quotidiano a tutte le latitudini.
A difesa del prestigio di una città attrezzata a inglobare nei secoli culture, usi e costumi di storiche preesistenze e dominazioni eterogenee, Yvonne è tenace e attenta antagonista di letture malevole di Napoli, che ignorano i suoi mille primati nel vasto territorio dell’arte, della scienza, dell’economia, poi usurpata.
Verissimo, il Cibo, lo dice a ragione il titolo, racconta Napoli. L’autorevolezza della voce narrante dell’autrice confluisce con rara competenza nel filone delle verità nascoste, che rendono merito alla sirena del golfo dominato dal Vesuvio e invitano orgogliosamente a conoscere più da vicino il mito della sua inimitabile cucina.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 10 dicembre 2017
Il regionale delle sei e quarantatré
di Luciano Scateni
Su giornalisti, scrittori e critici, intellettuali a vario titolo, piombano a cascata richieste di promuovere con chiacchere più o meno appropriate relazioni-riflessioni. E passi se il materiale letterario sottoposto a commento è di eccelsa levatura. Non di rado la richiesta di relazionare propone invece parole in successione che dovrebbero rimanere serrate nel cassetto dei sogni di chi osa trasferirle su carta tipografica per edonismo da cittadino di un’Italia di naviganti, poeti e scrittori. Il compito di recensire in pubblico opere d’ingegno è però piacevole applicazione se la partitura del libro è sontuosa come raccontano le pagine di “Il regionale delle sei e quarantatré” firmato dal critico e scrittore Marcello Carlino, istigatore di un breve racconto sul tema.
Qualche anno fa, in trasferimento ferroviario per motivi televisivi, mi è capitata la sventura di viaggiare su un treno di pendolari nel percorso tra Catanzaro Lido e Catanzaro città, che com’è noto domina il litorale dall’alto: il treno, una specie di littorina che farebbe la fortuna del museo di Pietrarsa, dove sono esposti i cimeli del settore, si è mosso arrancando come fosse affetto da asma bronchiale con ventisette minuti di ritardo e per superare il dislivello tra mare e collina ha dovuto intaccare seriamente le residue energie della sua quarta età. Schiena a pezzi su sedili da old terza classe e nessun refrigerio per l’afa precoce di Luglio. Per carità, pretendere il sollievo dell’aria condizionata? Neanche a pensarci, ma porca miseria, l’aggravante del finestrino bloccato no, e neppure il fetido corollario di un dirimpettaio nemico giurato della doccia. Ho imprecato per complessivi 180 secondi: trenta alla partenza ritardata, trenta aprendo e richiudendo in rapida successione la porta del cesso immondo con la menzognera etichetta di “Toilette”, i residui trenta all’arrivo, con la scoperta che il soggetto da intervistare, indignato e indisposto ad assoggettarsi alle disfunzioni della ferrovia locale, si era legittimamente dedicato ad altro e lontano da Catanzaro. Tre minuti di incazzatura sono niente, lo ammetto, ma ne giustifico la pochezza con l’immersione totale nella lettura del testo abbozzato, filo conduttore del programma tv in corso d’opera.
Il compito ricevuto da Annella Prisco, dell’omonima fondazione nata in ricordo del padre Michele, eccelso letterato, era di chiacchierare con Marcello Carlino, critico di chiara fama e cultore raffinato della nostra lingua, autore del romanzo “Regionale delle sei e quarantatré”. Il piacere di consumare senza indugi le trecentocinquanta pagine del libro, ha dissacrato la fede coltivata da tempo nel principio universale che non è più frequente imbattersi in un modello di scrittura inedito, dopo secoli e secoli di nobili scriba, come li definisce Clerici, stimatissimo recensore di sfide tennistiche. Carlino ha compiuto il miracolo di inventare una dinamica delle parole che ricorda la genialità di Joyce, ma con un sua avvincente peculiarità. Dovessi risolvere con due sole parole l’alternativa al felicissimo titolo del romanzo proporrei la sintesi postmoderna di “Rap letterario” e non è una proposta senza fondamento. Superate di slancio e con non poca attenzione le prime ventotto pagine, su cui a fine lettura del libro conviene riposizionarsi per una più avveduta rivisitazione, si finisce in un vortice affascinante di contemporaneità senza pause tra pensiero e parola. Un esempio è la descrizione dell’approccio alla biglietteria del fatidico treno delle 6 e 43, classico regionale da pendolari: “Si dirige alla macchinetta obliteratrice di sinistra nell’atrio della stazione. La macchinetta obliteratrice è fuori servizio. La seconda macchinetta accende e spegne una spia rossa, è fuori servizio. Si dirige alla terza macchinetta, si sente uno scatto. L’uomo ritira il biglietto. Accosta il biglietto obliterato ai suoi occhi, gira il biglietto fra le mani, prende gli occhiali dal taschino della giacca, li inforca, accosta il biglietto agli occhi, torna a girare il biglietto fra le mani, s’avvia alla biglietteria, torna indietro, rivà verso la biglietteria, si ferma un metro dalla linea gialla. La biglietteria non ha nessun viaggiatore allo sportello. Torna indietro”. Come dicevo, un rap.
Il Marcello Carlino, voce narrante del romanzo, vittima di un calvario ferroviario, finisce prigioniero di cinici Ponzio Pilato che si coalizzano per trasformare la normalità di un viaggio nelle carrozze degli abitudinari della pendolarità, in gironi concentrici di un inferno su binari.
Per cominciare. Immaginate che le sette latrine dei sette vagoni abbiano siglato un patto di ferro: tutte e sette inutilizzabili. Chiunque esploderebbe in eccessi vocali di ira contro le ferrovie, il governo ladro e chissà, contro i gatti neri che ti tagliano la strada il venerdì 17 di un anno bisestile. Altro è il funambolismo descrittivo di Marcello Carlino. L’accessorio principe dei gabinetti? Ovvio, il water, in volgare i cessi. “Tondi, ovali, rettangolari, quadrati, esagonali, di un esagono irregolare e schiacciato oblungo, sagomati con depressione e come un taglio innanzi all’occupante quando seduto, a goccia, a bolla di sapone, dritti, dritti per un cubo perfetto che ti mette nella sala una scatola di ceramica trentacinque per trentacinque per trentacinque, inclinati che sembrano un proteggi orecchie per cani seviziati dalla moda. Da terra, che fanno imbuto liscio, liscio con il pavimento in cui sono inchiavati, strombati come una gorgiera d’antan che manco Maria Stuarda, sospesi a parete a quarantacinque centimetri, che ti mettono con le spalle al muro e a vederli sembrano ascendere e levitare asettici solo vedendoli, ad allocazione centrale che ci giri tutto intorno e hanno un vaculo circolare ingoiatore, da gabinetto alla turca solo estroflesso, in aggetto, liberty, con cornice un poco bombata che disegna un sotto sedile accogliente bene bene il copri-water, beige, bianco-candidi, rosati, marrone, neri, bicolori, leopardati , con topolino alla disney disegnato per evacuatori infanti in apposito bagno riservato in miniatura. Accosti al tramezzo così che non ti rubano più di quaranta centimetri, ché lo sciacquone è internato, con lo sciacquone facente le veci di uno schienale a doppia gittata, a scomparsa come da brevetto recente, ma se ne vedono solo sui cataloghi. Stile razionalista, che economizzano superficie in uno stanzino dove la decenza è quanto si dice basti, dorati, damascati, iridati, corinzi, tipo missoni, di cristallo con cariello di cristallo (meglio cariello, nobilissimo che carello, lui pure), d’acciaio con guarnizioni verdi come nelle toilette un metro e mezzo per un metro degli aerei e dei treni, piccoli volumi per un denso raccoglimento stanziale…”
Il narrante dialoga con il capotreno, inconsistente conductor del regionale e sa che il treno delle 76 e 43, ammesso che parta dopo acconcia riparazione tecnica, farà soste non contemplate in stazioni provviste di cessi per consentire deiezioni ed evacuazioni a donne incinte e bimbetti incontinenti, ma ancor più a iperprostatici. Prostata? Il tema, senza la minima reticenza o eccessi di nozioni medico-fantasiose è un proluvie di aggettivi e allusioni a corollari dell’afflizione prostatica. Una ventina di pagine scoppiettanti, impudiche, spregiudicate quanto basta per stupire. Come dicevo, un rap letterario. Annientato dalle venti pagine che ruotano sull’oggetto water per un minuzioso, affascinante e mai ripetitivo racconto, ho provato a emulare gli effetti del parco giochi in cui si muove l’autore, con veloci, ritmici cambi di marcia da prestigiatore e funambolo, saltando dalla giostra dei cavalli alle montagne russe, dal tiro al bersaglio all’autoscontro. E ho scoperto la precisione chirurgica nello scansare le trappole della ripetitività con lampi di pura, ingegnosa creatività, pensieri che in seguono le parole che inseguono i pensieri. Appunto, rap letterario.
Nella trama fitta della narrazione si susseguono mille pretesti per veloci e pungenti incursioni nel mondo che incombe sulle nostre teste, che sia l’Isis, il governo ladro, le diseguaglianze sociali, che motivano il pessimismo della ragione. L’acme del disorientamento personale alimentato da stupore, incanto e perché no, invidia, è nella fantasmagorica dissertazione, non disgiunta dalla scritta closed dei cessi sul Regionale delle sei e quarantatré, su prostata, prostectomia e danni da maligna ipertrofia. “E meno male che la prostata me la sono operata. Conoscevo tutte le toilettes nel raggio di un chilometro, allora. Avevo in tsca una mappa dei luoghi con toilettes, segnate con tante bandierine…Avevo di che rispondere ai caprici incontrollabili, alle collecitazioni escretorie di un adenoma noccioluto di severa estensione… Correvo, correvo e che correvo a fare? Per una goccia e spesso manco per quella…La prostectomia non è cosa da lamentarsi, la qualità della vita ne guadagna.
Coinvolto nel labirinto del disagio da ardua minzione dei passeggeri per full closed toilettes, il lettore cerca disperatamente il filo di Arianna per uscirne, ma desiste, attirato nella trappola di eleganti arzigogoli sul tema.
L’efficacia del narrare sposa il raffinato strategemma della scansione del tempo, scandita a voce alta dall’autore, un esercizio mentale estraneo ai più che consumano ogni pensiero in una frazione di un istante. Per Marcello Carlino tanti secondi per un caffè al volo, tanti per lasciare casa, tanti per coprire il percorso in direzione ferrovia, tanti per capire che non è giornata da pendolari, che il treno è in ritardo e non parte. Ogni tappa rimuginata, elaborata, raccontata, diventa un consapevole trascorrere di minuti. Il tempo di attesa della partenza del regionale delle 6 e 43, quello delle soste non programmate per guasti, altri, per consentire agli incontinenti di evacuare vescica e intestino con stop illegali in stazioni dotate di cessi.
Kafka fa capolino tra queste pagine rivolte a menti predisposte ad apprezzare l’inedito, evidente nel disegnare l’identikit del capotreno, pupazzo di gomma in grado di assorbire, senza deformarsi, proteste e insulti del pendolarismo umiliato da razzismo ferroviario. Ancor più kafkiano è il particolarismo masochista del narrante che ingoia pillole amare. E’ destinato a fallire il tentativo di antagonizzare la iattura di pendolare seriale. La micro tessitura del disagio è scandita minuziosamente, quasi a toccare il fondo, che più fondo non si può. L’utopia è che una volta raggiunto, si possa uscirne con l’idea ottimista di un Regionale delle sei e quarantatré puntuale, con toilette profumate, capotreno decisionista e perché no, avvenenti hostess che offrono caffè di miscela arabica, cornetti caldi e quotidiani appena partoriti dalle rotative. Prima di immettersi nel diario segreto dell’autore, per scoprire se questo è il sogno ricorrente nel dormiveglia di pendolare quotidiano, è tutta da godere la scrittura colta, piacevolmente inconsueta delle trecentocinquanta pagine firmate da Marcello Carlino: un lungo, appassionato crucifige del sistema, dalla parte di chiunque abbia la sfortuna di appuntamenti quotidiani con ogni regionale del mondo delle sei e quarantatré, o giù di lì.
Alla fine della lettura assale il dubbio, fondato, che il Treno delle sei e quarantatré sia la metafora delle difficoltà in cui ci dibattiamo, vittime del pericoloso caos politico e sociale, di inadempienze, discriminazioni, diseguaglianze e marginalità, dell’inefficacia di chi contesta tutto questo in modo disorganico. Forse è l’invito a selezionare quanto ti accade secondo dopo secondo per vivere i dettagli e indagare il sé e gli altri. Non meno, il gusto concesso a pochi eletti di giocare pazientemente con l’eleganza delle parole in perfetta sintonia con i pensieri. E allora buona lettura con il “Regionale delle 6 e 43”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 3 dicembre 2017
Ah, che bellu ccafè
di Luciano Scateni
Nella casa di un napoletano verace possono mancare per distrazione latte, zucchero e sale, mai il caffè. Al mattino il suo aroma si spande dalla cucina all’intera abitazione. E’ rassicurante, dispone al meglio l’approccio al nuovo giorno, corrobora, dissipa i residui do sonni appaganti o deludenti, animati da sogni o da incubi. Un bricco di caffè è compagno di nottate prima degli esami, delle notti di guardiani notturni, conducenti di mezzi pubblici, operai pendolari, panificatori, insomma del popolo della notte. Irriducibili fan della miscela alla napoletana, in vista di vacanze all’estero, mettono in valigia il barattolo del caffè preferito, e la Moka “che dove andiamo non lo sanno fare”.
Luigi ha sputato l’anima alla prima boccata di una Dunhil che Marta gli ha imposto di fumare per non essere un “diverso” nella classe seconda B dove i maschi e qualche ragazza sono già prossimi alla dipendenza da nicotina. Assorbita la nausea del primo tiro, l’orgoglio maschile ha la meglio sulla voglia di piantare il fumo e il caffè del mattino diventa prologo per accendere una “Senior Service” senza filtro, che altro non si può concedere. Esce per tempo da casa, perché i soldi dell’autobus che collega il Vomero con il Ginnasio-Liceo Giann Battista Vico, Luigi li investe in dieci sigarette sfuse che gli passa ogni giorno don Antonio, venditore di estere di contrabbando.
Se ne ricorda mentre accende la sigaretta numero venti alle tre del pomeriggio, dopo aver bevuto il quarto caffè al bar di via Scarlatti, a due passi da casa. Fino a sera il numero di “inglesi” aspirate saranno quelle di un pacchetto e mezzo. L’ultima metà resta in riserva per le ore piccole della notte. La vita corre veloce, il lavoro stressante cammina di pari passo con la ferale dipendenza dal fumo, con il presunto rito consolatorio del caffè al trillare della sveglia, del secondo a colazione. Il terzo è d’obbligo a metà mattinata, gli altri nel dopo pranzo e a più riprese nel pomeriggio. Uno, gratificante conclude il dopo cena, un altro dà senso alla routine del thriller in Tv, l’ultimo prima poggiare la testa sul cuscino. Ogni caffè giustifica la sequenza di una sigaretta dopo l’altra. Luigi non ne ha più consapevolezza, ma la “droga” del caffè ha una ricaduta automatica sul fumo. Quando l’intossicazione è al culmine accende la sigaretta con il mozzicone fumante della precedente. Non si chiede se fa più danni la nicotina o l’eccesso di caffeina. Dopo un aggressivo “coccolone” Luigi torna a due caffè al giorno, dopo aver conservato nel cassetto delle cose proibite un pacchetto pieno a metà di english tobacco.
La disputa scientifica sugli effetti del caffè è aperta, non conclusa. Le tesi su benefici e danni si confrontano con reciproca autorevolezza. Ma il caffè, cos’è? Come ogni cosa che si è fatta largo nell’uso quotidiano di miliardi di esseri umani, a tutte le latitudini, merita l’attenzione di cultori della materia.
Edito in questi giorni, un prezioso, elegante libro esplora il ruolo d’o cafè nella città dove è un mito. Il racconto è di Lejla Mancusi Sorrentino, l’edizione in veste raffinata è firmata da Grimaldi. E’ leggenda storia, aneddoti, ricerca di fonti, percorso nel mondo fantasmagorico della Napoli che del caffè ha fatto un irresistibile e inimitato attrattore.
Racconta Lejla che caffè e monaci sono una cosa sola. E non solo per la somiglianza cromatica del marrone dell’abito francescano e dei chicchi abbrustoliti. L’apprezzata esperta di gastronomia e affini narra di monaci, che in Arabia, eremiti in montagna, allevavano capre per procurarsi latte, formaggio e lana. Queste caprette un bel dì sembra che avessero brucato foglie di arbusti particolari e che rientrate nell’ovile per il riposo notturno si siano comportate in modo irrequieto, tanto da non riuscire ad addormentarsi. Il monaco addetto alla cucina pensò allora di preparare un decotto con le erbe dell’arbusto e anche i frati non riuscirono a dormire. Era nato il caffè.
Il primo, servito al pubblico nella versione che arriva ai giorni nostri, è della metà del 600, proposto a Napoli dalla Bottega del Caffè, che com’è noto, è anche il titolo di un’opera di Goldoni. A Venezia nasce il famoso Caffè Florian che ancora si affaccia sulla piazza San Marco.
Continua la narrazione. Napoli vive molto la strada e il popolo s’ingegna, vi si adatta. Nelle vie affollate si può incontrare il caffettiere ambulante e, ancora oggi, i ragazzi di famiglie modeste, che lasciano la scuola perché costa, si arrangiano a portare il caffè ovunque, negli uffici, nelle scuole, nei negozi.
A Napoli e dintorni il costo di una tazzina è ampiamente variabile. Nelle zone popolari della città i bar offrono caffè e cornetto per un euro e mezzo. Una consumazione dell’aromatica bevanda ordinata al tavolino nella celebre piazzetta di Capri è un lusso per pochi.
 Chiedete a ogni napoletano verace dove si gusta il miglior caffè della città. Da ognuno avrete una risposta diversa. “Nessun dubbio, nel piccolo bar di piazza Trieste e Trento”. “In via della speranzella, da “’O ccafè da Giggino”, no “Al Gambrinus”, “Da Mexico”.
Chiedete a ogni napoletano verace dove si gusta il miglior caffè della città. Da ognuno avrete una risposta diversa. “Nessun dubbio, nel piccolo bar di piazza Trieste e Trento”. “In via della speranzella, da “’O ccafè da Giggino”, no “Al Gambrinus”, “Da Mexico”.
Tutto vero, il caffè non è un bene del palato uguale qua e là, ma come recita la canzone “Sulo a Napule ’o sanno fa”. Le voci dei mille presunti esperti: “Vero, dipende dall’acqua” “No è questione di miscela”. “A Milano è ‘na ciofeca”, “Eh no, adesso due giovani napoletani hanno aperto tre bar a Milano e il caffè è come da noi”, “Ma come fanno gli americani a bere quella sbobba che chiamano caffè?” “Io lo bevo amaro, solo così sento il sapore vero del caffè”. Infine, “Solo Napoli poteva inventare il caffè pagato”.
E le varietà? Lungo, macchiato, ristretto, corretto all’anice. Schiumato, shakerato, freddo, granita, in bicchierino, tazza fredda, caffè turco.
Così dissertando nasce la leggenda di Napoli, patria del caffè. Ma cos’è il caffè, che origini ha, chi sono stati i primi a coltivarlo, fa bene o fa male, storia e leggende, i famosi luoghi di degustazione e di aggregazione, le canzoni che ha ispirato. Celebri sono le più recenti, di De Andrè e Pino Daniele. E’ mitica la scena di Eduardo, che affacciato al balcone spiega a un invisibile dirimpettaio come si fa il caffè con la macchinetta napoletana, Sullo sfondo, la funzione del macinino della nonna, della padella per abbrustolire i chicchi.
Sta di fatto che l’industria del caffè diventa un affare mondiale, che è imponente l’investimento in pubblicità delle grandi marche ed emblematico il progetto di Jilly di impiantare a Tokio una catena di cento bar all’italiana. Il suo caffè, benchè l’industria sia nordista, di Trieste, è considerato tra i migliori.
Letteratura e cinematografia, consacrano il rito del caffè a letto, appena svegli, l’happy hour. La realtà boccia l’imbevibile brodaglia servita in aereo.
Poeti celebri, binomi eccellenti: Pasquale Ruocco e il caffè, Di Giacomo e il caffè.
Esclusi gli abusi, ’na tazzulella ‘e cafè che i napoletani creativi e competenti sanciscono debba essere servita con tre le “C” di comme c…o coce”, compete alla grande con la pizza in fama mondiale. La moka, poi le capsule per macchine casalinghe, hanno mandato in soffitta o in esposizione nei mercatini domenicali dell’antiquariato, la vecchia, cara macchinetta napoletana e gli accessori della nonna. Oggi l’opulento mercato di settore si consente di ingaggiare star del cinema come George Cloney per promuovere una marca nota.
Il mito non dà segni di obsolescenza e, anzi, si consolida, in concorrenza, per dire una con il tè, bevanda regina d’Oriente e, lo ha cantato De André: “Pure in carcere ’o sanno fa…”.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 26 novembre 2017
I De Marino, espulsi dalla normalità
di Luciano Scateni
Colpa di Renzi, disse il grillino Di Battista con Fico, Taverna & co. se la nostra è terra di poveri (uno su quattro italiani è a rischio secondo l’Istat). E allora? Fornire al governo la bacchetta delle maghe raccontate dalla fantasia dei favolisti, per incidere così sulla tragica statistica? In un gioco al massacro, masochista, vicino al suicidio, suggestiona la voglia di affidare a Grillo e ai suoi giovani rampanti la guida del Paese. E’ ipotesi fantapolitica che consentirebbe di scoprire per sempre l’insipienza grillina a dimensione nazionale, dopo aver assistito alla pochezza nella gestione dei pochi enti locali che li hanno imprudentemente eletti sindaco.
Meglio non provarci, ma l’asse D’Alema, Bersani, Camusso, sembra di opinione opposta. Lavora per la sconfitta del centrosinistra, il conseguente pollice verso per Renzi, del governo che lo rappresenta. Coltiva il disegno utopico di un arduo restauro dei cocci in cui è finito il vaso contenitore di residui della sinistra. E le emergenze, le povertà, i bisogni, il lavoro che non c’è, il dramma di un giovane del Sud su due senza futuro, di chi non tutela più il proprio benessere e rinuncia a curarsi, impossibilitato a comprare la salute?
 Alla via Scarlatti, cuore pulsante del compra e vendi, cioè di una diffusa rete commerciale che ha cancellato la memoria del Vomero, quartiere napoletano dei “broccoli” e delle gite della pasquetta nel bosco dei Camaldoli con colazione al sacco, in uno dei palazzi tutti uguali, una famiglia di onesti lavoratori ha condotto per oltre vent’anni la sua vita modesta, dignitosa, sobria. Maria Elena, donna da immortalare in una foto simbolo della bellezza meridionale, ha speso gli anni precedenti il matrimonio e molti altri, quelli della piena maternità, in parte negata dal lavoro di domestica full time, con la totale dedizione alla famiglia, a Gigio e Tonino, i due figli concepiti con il compagno della vita. Altiero, di quindici anni più grande si è spaccato la schiena per tenere in piedi i costi del ménage familiare, come magazziniere per una multinazionale dei trasporti. I ragazzi studiano e l’obiettivo posto dai genitori per agevolare il loro percorso scolastico è di spostare in avanti il loro futuro, agevolato dalla laurea che spiana il cammino delle professioni. Nessun cedimento intralcia il rigore di Altiero e Maria Elena nella gestione delle disponibilità assegnate con oculatezza da ragionieri alle priorità. Mai un ristorante, un cinema (“che tanto abbiamo i film della tv”) e per lo sport dei ragazzi l’iscrizione gratuita al corso di calcio promossa dall’istituto dei Salesiani con i contributo del calcio Napoli.
Alla via Scarlatti, cuore pulsante del compra e vendi, cioè di una diffusa rete commerciale che ha cancellato la memoria del Vomero, quartiere napoletano dei “broccoli” e delle gite della pasquetta nel bosco dei Camaldoli con colazione al sacco, in uno dei palazzi tutti uguali, una famiglia di onesti lavoratori ha condotto per oltre vent’anni la sua vita modesta, dignitosa, sobria. Maria Elena, donna da immortalare in una foto simbolo della bellezza meridionale, ha speso gli anni precedenti il matrimonio e molti altri, quelli della piena maternità, in parte negata dal lavoro di domestica full time, con la totale dedizione alla famiglia, a Gigio e Tonino, i due figli concepiti con il compagno della vita. Altiero, di quindici anni più grande si è spaccato la schiena per tenere in piedi i costi del ménage familiare, come magazziniere per una multinazionale dei trasporti. I ragazzi studiano e l’obiettivo posto dai genitori per agevolare il loro percorso scolastico è di spostare in avanti il loro futuro, agevolato dalla laurea che spiana il cammino delle professioni. Nessun cedimento intralcia il rigore di Altiero e Maria Elena nella gestione delle disponibilità assegnate con oculatezza da ragionieri alle priorità. Mai un ristorante, un cinema (“che tanto abbiamo i film della tv”) e per lo sport dei ragazzi l’iscrizione gratuita al corso di calcio promossa dall’istituto dei Salesiani con i contributo del calcio Napoli.
Una famiglia normale. L’imprevisto che la priva di questo attributo è brusco, gravato di concomitanze che per chi crede all’ineluttabilità del destino si abbattono con accanimento sulla testa dei De Marino e stravolgono la loro vita perché “sta scritto così nel libro, lassù”. La Transport in the world chiude deposito e filiale napoletana, Altiero si ritrova disoccupato e nell’età più critica per sperare in qualunque alternativa di reinserimento nel mondo del lavoro. Bussa a cento porte e riceve cento “Mi spiace, auguri”. Entra senza accorgersene in depressione e Maria Elena non fatica a decifrarne le cause. Il rapporto, solido per venticinque anni, si incrina e ricade in forme vicine all’isterismo litigioso sull’intera famiglia. Non è ancora il peggio.
Nel raggio d’azione di una gang di spacciatori c’è il potenziale mercato degli studenti dell’Istituto Tecnico dove Gigio è vicino al diploma. I compagni più informati raccontano di guadagni facili che alcuni coetanei mettono in tasca con poco sforzo, pusher di una cosca che recluta tra gli studenti delle scuole dove punta a incrementare lo spaccio.
“Un modo per aiutare la famiglia in seria difficoltà, ma come giustificare i soldi guadagnati così?”
Troverò qualcosa pensa Gigio e contatta un “anziano” tra i giovani spacciatori che operano nelle vicinanze della scuola. Accordo fatto, a scapito del rendimento scolastico.
Il mancato salario di Altiero mette in crisi il bilancio mensile dei De Marino e una delle immediate conseguenze è il ritardo di mesi nel pagamento del canone di affitto. La proprietà della casa, potente immobiliare milanese, dopo aver pazientato nei tempi concessi dall’ufficio recuperi, spedisce un’ingiunzione perentoria che impone il pagamento degli arretrati e della mensilità in corso entro “trenta giorni”, pena lo sfratto. I soldi di Gigio non coprono che in minima parte il debito
 Maria Elena prova a mettere insieme un po’ di euro. Vende parte del corredo di sposa mai tolto dal baule, porta al banco dei pegni il poco oro degli oggetti ricevuti da parenti e amici come doni di nozze. Non basta e Altiero bussa alla porta del fratello maggiore, vedovo da alcuni anni. “La casa non è grande ma non c’è problema, è a tua disposizione, trasferisciti quando vuoi. Staremo stretti, pazienza”. La disponibilità di Giuseppe è certamente generosa, ma anche umiliante, benché provvidenziale.
Maria Elena prova a mettere insieme un po’ di euro. Vende parte del corredo di sposa mai tolto dal baule, porta al banco dei pegni il poco oro degli oggetti ricevuti da parenti e amici come doni di nozze. Non basta e Altiero bussa alla porta del fratello maggiore, vedovo da alcuni anni. “La casa non è grande ma non c’è problema, è a tua disposizione, trasferisciti quando vuoi. Staremo stretti, pazienza”. La disponibilità di Giuseppe è certamente generosa, ma anche umiliante, benché provvidenziale.
La donna che Maria Elena ha assistito per anni muore di vecchiaia e deficit cardiaco, finisce anche il rapporto di lavoro, rimasta unica fonte di reddito dei De Marino. Disperata, contatta le poche amiche di pari livello e la risposta ripete con poche variazioni sul tema che per il lavoro di domestica anche le famiglie napoletane si rivolgono a ucraine, filippine, sudamericane: costano meno e hanno minori esigenze. Altiero incontra i compagni di lavoro licenziati, tutti nelle identiche condizioni di frustrazione.
 Una soffiata di una gang nemica spiffera ai carabinieri i nomi degli spacciatori che agiscono nei prassi dell’Istituto Tecnico e un loro blitz spazza via la rete di giovanissimi pusher. Il tribunale di minori sentenzia la detenzione di Gigio nell’Istituto di rieducazione minorile Angiulli di Santa Maria Capua Vetere. Su un altro versante la polizia mette fine allo sciacallaggio di don Alberto e alle violenze sulle vittime dell’usura inadempienti.
Una soffiata di una gang nemica spiffera ai carabinieri i nomi degli spacciatori che agiscono nei prassi dell’Istituto Tecnico e un loro blitz spazza via la rete di giovanissimi pusher. Il tribunale di minori sentenzia la detenzione di Gigio nell’Istituto di rieducazione minorile Angiulli di Santa Maria Capua Vetere. Su un altro versante la polizia mette fine allo sciacallaggio di don Alberto e alle violenze sulle vittime dell’usura inadempienti.
All’alba, quando il Vomero è ancora immerso nella quiete e le strade sono deserte, un uomo infreddolito, avvolto in un giubbotto che potrebbe contenere due corpi come il suo, passa da un contenitore di abiti usati all’altro. Sceglie cosa portare via e stipa il carrello della spesa della moglie con abiti in buone condizioni. Più tardi li consegnerà alla bancarella del mercatino rionale che offre “usato doc” a pochi euro. Ad Alteri entra in tasca il dieci per cento del venduto.
Erano una famiglia i De Marino.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 19 novembre 2017
La fatale attrazione di Hammamet
di Luciano Scateni
“…nu latitante è na foglia int’o viento / nun pò allucca nun pò dì so’ innocente / telefono a casa pe’ dì sulamente / rimane è natale, vulesse turnà / nu latitante nun tene ’a speranza, nun pò turna…”
Sono struggenti (ma solo in ambiente malavitoso) i versi di questa canzone del genere neomelodico dedicato al povero recluso nella cella di Poggioreale. E’ la vigilia di Natale e non può tornare al tepore della casa, al simbolismo dell’albero addobbato. “Nu latitante” ha vissuto momenti di grande successo discografico e radiofonico e avrà certamente toccato le corde sensibili di Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra, latitante dal 1993, il più ricercato del mondo. Ed è molto probabile che la rapida diffusione della canzone pro detenuti abbia raggiunto la sponda africana dell’Italia dove Craxi scelse di stabilire la sua latitanza, che il leader del Psi pluricondannato l’abbia ascoltata ad Hammamet, sintonizzato per caso sulle frequenze di radio napoletane. Commozione assicurata.
Lo choc di “Mani Pulite” scosse le coscienze degli italiani, terrorizzò gli affaristi truffatori, l’ampio segmento di politica corrotta e collusa con il malaffare che lucrava con l’illecito, fino al fatidico ’92 galvanizzata da certezze fondate di impunità. Il titolo “Mani Pulite” si deve alla profetica intuizione di Giorgio Amendola che in cuor suo deve aver auspicato che ne stessero fuori le istituzioni al governo del Paese: politica, sindacati governi locali, il mondo dell’imprenditoria, ma soprattutto il suo PCI. Campasse ancora, il dirigente comunista sceglierebbe l’ascetismo in un eremo non raggiunto dall’informazione e finirebbe i suoi giorni, in fase ultima di depressione, con la pietas del suicidio svizzero assistito. Eviterebbe il colpo al cuore della fase due di Tangentopoli, più estesa, dannosa per il Paese e includente tutti, nessuno escluso. Militano nelle truppe della corruzione e dell’illecito ad ampio raggio tutti i partiti, da destra a sinistra, uomini del sindacato non ne sono esenti, il mondo dell’imprenditoria è largamente coinvolto, ci sono dentro perfino alti prelati del clero, vertici e uomini delle forze dell’ordine. Un differenziale giudiziario distingue però la prima dalla seconda tangentopoli e per convincersene occorrerebbe la scienza di un accorsato uomo della statistica, in grado di convertire in numeri, territorio comprensibile a tutti, la cronaca dei processi anti corruzione conclusi con comodi patteggiamenti, prescrizioni e generose assoluzioni. I corrotti del ’92 finivano in carcere o latitanti, in accoglienti Paesi d’oltremare. Colti con le mani nel sacco, nell’atto di intascare tangenti, sono finiti in carcere notabili della politica in auge fino al mandato d’arresto del pool del Pm d’assalto, il Di Pietro implacabile giustiziere. Le conclusioni processuali di condanna, tradotte in manette, svelarono la dimensione di un bubbone fetido, con ramificazioni estese al pianeta invasivo della malavita mafiosa. Spetta agli storici l’onere di ricostruire le tappe del percorso che portò alla rimozione di tanta spazzatura, mai avvenuta alle radici, perché protetta da pigrizia investigativa e complesse complicità. Forse la chiave per risolvere l’impegnativo rebus di una fase due della corruzione, di gran lunga peggiore della prima, è iscritta nell’incredibile evento che a spese della collettività ha portato uomini politici del nostro tempo ad Hammamet con in mano un fascio di fiori da poggiare sulla tomba di Craxi. Che dire di un democratico eletto inquilino di Palazzo Marino, al secolo mister Sala, promotore dell’idea di intitolare un luogo di Milano a Craxi. Per chi non avesse a portata di memoria la vicenda del segretario socialista è di aiuto ricordare che fu condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione per la vicenda Eni-Sai e a 4 anni per l’inchiesta sulla metropolitana di Milano e che per non scontare le condanne fuggì in Tunisia. C’è di più. In parlamento, Craxi benedisse il sistema delle mazzette, delle tangenti. Qualunque collettore di tangente, di qualunque partito, sarebbe uno spergiuro se negasse di esservi implicato. In memoria del latitate leader socialista, è da incorniciare e proporre alle giovani generazioni la frase pronunciata da Berlusconi nella circostanza: “Onorato ogni volta che il mio nome viene accostato a quello di Craxi”. Bisogna capirlo, la sua fortuna di imprenditore è diretta emanazione di un sodalizio ben assortito con il segretario socialista che smascherato dai magistrati del pool, all’uscita da un albergo romano fu bombardato di monetine al grido di “Vuoi anche queste?”.
A diciassette anni dalla morte, Alfano, il nostro neo ministro degli Esteri volato in Tunisia insieme alla vedova Anna e ai figli Stefania e Bob, ha deposto fiori sulla tomba di Craxi. Nessuna sorpresa. Al tempo dei funerali il presidente del consiglio D’Alema organizzò una spedizione governativa di rappresentanza e delegò a rappresentarlo il ministro Lamberto Dini e Marco Minniti del Pd, l’attuale ministro dell’Interno. La risposta di Berlusconi, in perfetta par condicio, fu l’invio di una delegazione degli ex socialisti Frattini, Sacconi, Brunetta. Di più. Giorgio Napolitano, nella qualità di Presidente della Repubblica, nel decennale della morte inviò un messaggio ovviamente apprezzato dal figlio Bobo con cenni al revisionismo della storia e alla “sapiente politica dell’epoca di cui certamente Bettino Craxi fu protagonista”. Al coro di plausi per la trasferta tunisina di Alfano si sono associati con entusiasmo ex socialista Maurizio Sacconi (“nel segno della verità”) e Cicchitto (“visita molto importante”). C’è enfasi da riconoscenza nell’esternazione di Berlusconi alla figlia Stefania. Definisce colpo di Stato la privazione del ruolo politico di Craxi, della possibilità di vivere da uomo libero nel suo Paese…che scelse la strada dell’esilio (della latitanza, ndr) pur di non venire a patti con questo “apparato politico, mediatico, giudiziario che uccide la libertà e la democrazia”. Ha scritto, non smentito, il Fatto Quotidiano: “Resta il mistero di come mai Berlusconi, tramite il conto estero All Iberian, abbia versato sui conti di Craxi ventuno miliardi di lire come ha stabilito la sentenza di condanna in primo grado, prescritta durante i processi milanesi”. E’ così difficile collocare la tessera della “tangentopoli bis” nel puzzle dell’Italia malata di corruzione? Chiuso il capitolo Di Pietro, corrotti e corruttori hanno riaperto i tentacoli della piovra illegalità su appalti di opere pubbliche, banche, grandi Enti statali e in termini minimali su illeciti della quotidianità, del mancato rispetto delle regole, sulla fine ingloriosa dell’etica. Il contagio di ruberie, truffe e mazzettopoli ha infettato migliaia di eletti a rappresentare i cittadini nel ruolo di amministratori degli enti locali, le mafie hanno pervaso senza trovare resistenze apprezzabili ogni ambito dell’economia. La genesi di questa seconda era, che come i fiumi in piena allaga i campi fertili della residua cultura dell’onestà, ha un comune denominatore nell’auto-assoluzione di corrotti e corruttori incoraggiati dalla riabilitazione di Craxi. Il condannato leader socialista chiese ai tesorieri dei partiti di giurare in Parlamento di non essere destinatari di finanziamenti illeciti. Sembra che nessuno osò raccogliere il guanto della sfida, già allora nella convinzione che il sistema “Tangentopoli” avrebbe goduto di lunga vita. E nessuno lo raccoglierebbe in questa stagione dei corrotti che ogni giorno contribuisce a ponderosi titoli nelle pagine della cronaca e della politica. Il vortice della disonestà è cresciuto a dismisura e inghiotte di tutto: i politici (complici o estranei i rispettivi partiti), manager al vertice di banche e grandi imprese, alti gradi delle forze armate, amministratori di enti pubblici, faccendieri. La via di fuga dai rischi di pagare, ha fatto tesoro del caso che coinvolse Mario Chiesa, primo a far le spese dei magistrati di Mani Pulite. Ora punta alla lentezza dei processi, che finiscono in gran parte con la prescrizione dei reati, nel garantismo a tutti i costi a favore degli uomini colti a rubare per se e per i partiti, nell’omertà bipartisan che conta sulla memoria corta dell’opinione pubblica, investita ogni giorno di nuovi casi della Tangentopoli bis (o tris?).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 12 novembre 2017
“Dammi la mano Amina, prendi la mano Ahmed e sorriderà la vita e vita sarà”
di Luciano Scateni
Nascono di qua e di là di una linea di demarcazione che molto somiglia ai chilometri di cemento eretti a muro invalicabile Est-Ovest della Berlino ferita dalla guerra. Nei loro corpi di neonati l’impronta dell’antagonismo è scritto nel Dna, i vagiti hanno sonorità diverse, negli occhi lacrime uguali. Vengono su indotti all’odio per chi sta oltre i posti di qua e di là di separazioni garantite dalle tute mimetiche indossate da “guardiani” di confine che imbracciano armi pronte al fuoco, da dissuasori in divisa con licenza di tutelare dalla linea di demarcazione tra il popolo di Israele e la comunità palestinese. La contesa infinita si alimenta di odio, di diritti negati, di “no” al rispetto del diritto comune a essere stato, nazione, territorio.
Ne sono all’oscuro gli storici antagonisti di Israele e della Palestina, impegnati a contendersi una terra non condivisa dai due popoli che ne rivendicano la titolarità con tentativi decennali e accordi disattesi. Netanyahu, primo ministro israeliano e Maḥmūd Abbās, conosciuto come Abū Māzen , presidente dell’OLP, Autorità Nazionale Palestinese e dello Stato di Palestina, sarebbero stupiti e chissà, contrariati se per concedersi un pausa di relax scoprissero di navigare sulla stessa città galleggiante adibita allo svago dei crocieristi e in compagnia di un idillio infantile tra piccoli innamorati, a dispetto del loro passaporto che reca sul frontespizio la provenienza da Paesi in conflitto permanente.
Sull’ammiraglia di una delle compagnie di navigazione più accreditate, in differenti classi di viaggio, Amina gode del premio ricevuto dai nonni per la buona pagella al termine del primo anno scolastico successivo alle classi elementari. Ahmed si aggira disorientato nella sala giochi della nave, ancora stupito per il risultato di un progetto dell’Unicef che ha messo in palio una crociera nel Mediterraneo, assegnato al miglior tema sulla pace nell’area tormentata dove confliggono i loro due Paesi. Amina è una dolce bambina di Tel Aviv, un talento che l’ha portata alla sua tenera età a tenere concerti, solista di violino destinata a gloria e onori. La storia di Ahmed racconta di stenti, paura, tristezza senza rimedio, ogni cosa vissuta nell’inferno della striscia di Gaza.
E’ il tardo pomeriggio del secondo giorno di navigazione, il mare si offre quieto al gigante che batte bandiera norvegese. Nell’aria si avverte una certa eccitazione, in particolare tra i piccoli crocieristi. Il programma di bordo propone animazioni preserali: giocolieri, la rappresentazione di un atto unico dal titolo “Nel paese della cacao” e a seguire l’offerta di cioccolato elaborato da abili pasticceri. Mano nella mano, Amina e la mamma Noa si dirigono al ponte dov’è allestito il palco che ospiterà gli attori-animatori. Quasi si scontrano con Mayyada che accompagna il piccolo Ahmed. Le due donne si salutano con un sorriso. Noa, prova a utilizzare l’incontro per trovare compagnia alla figlioletta. “Anche voi al teatro?” Mayyada è schiva, abituata a diffidare di chiunque e risponde di sì con un cenno del capo. I bambini accoccolati in terra, in prima fila, applaudono le fasi del racconto che vede vincitore Fuffi, vivace nanetto, sul gigante Bongo. Ahmed con aria protettiva circonda con un braccio le esili spalle di Amina e ne spia le reazioni alla storia della marionette impegnate in baruffe per il possesso di una stella dorata che pende dondolando dal soffitto invisibile del teatrino. Si guardano di tanto in tanto e sono sguardi affettuosi, negli occhi il piacere di stare insieme.
Ghrete, responsabile dei passeggeri in prima classe, ascolta nel corridoio delle cabine dal 30 al 45 il suono struggente di un violino. Scopre presto a chi si deve, quando Amina esce dalla sua numero 37 con il violino ancora poggiato al collo. Il comandante Kristens, informato di ospitare una giovanissima concertista, le chiede di esibirsi nella sala che ospita abitualmente musica di ogni genere. Amina vorrebbe sottrarsi alla richiesta, ma la mamma ha la meglio sulla reticenza della bambina. Ahmed ascolta estasiato l’esecuzione del concerto di Felix Mendelssohn in E minor. Amina, concentrata per mostrare il meglio del suo talento, suona per lui. I giorni della piccola israeliana e del tenero compagno di viaggio corrono via rapidamente e in vista dell’arrivo della nave nel porto terminale, scambio di indirizzi, promesse di scriversi, il desiderio di rivedersi, si concludono con un bacio sulle guance che spinge la rispettive madri a imitarli. Insieme s’imbarcano sul jet della El Lai, in direzione Tel Aviv, aeroporto Ben Gurion. Di lì Mayyada e suo figlio raggiungeranno la striscia di Gaza con un visto israeliano concesso per i meriti di Ahmed premiati con il viaggio vacanza in crociera. Altrimenti sarebbe impossibile entrare nella Striscia di Gaza e superare il blocco aereo, marittimo e terrestre imposto da Tel Aviv. L’idea di entrare nella Striscia attraverso i tunnel scavati tra Gaza e l’Egitto, è ritenuta estremamente pericolosa, perché i cunicoli sono continuamente bombardati dagli israeliani. I territori Palestinesi, non ancora indipendenti, sono in gran parte presidiati dall’esercito di Netanyahu, compresa la frontiera con Gaza. Per raggiungerla non c’è che salire sul bus che porta alle città di Ramallah, Hebro e Nablus, parte araba di Gerusalemme, con un passaggio obbligato a Gerico. Aeroporto e porto di Gaza sono off limit e fuori gioco da molti anni. Stessa sorte per gli aeroporti di Rafah, Ramallah e Jenin-Muqeible , Katif.
Amina riprende lo studio del violino al conservatorio musicale israeliano e nel segreto della sua stanzetta scrive testi di canzoni, li musica. Il ricordo di Ahmed non l’ha mai lasciata e le parole sul diario escono dall’anima fluenti. Completati i versi non rimane che dar loro un titolo e la ragazza, ora appena oltre l’alba della gioventù, scrive di getto “Aquiloni”. L’incide su Facebook, la trasferisce su un dvd e la invia ad Ahmed. Arriva in una mattina triste, quando nel corso di una retata, soldati israeliani irrompono nella sua abitazione e portano via, ammanettato, il padre Omar, con l’accusa di aver partecipato a raid palestinesi nel cuore di Tel Aviv, in appoggio a giovani dell’Olp che assalgono gli ebrei a coltellate.
“Amina?” Ahmed apre con cura la lettera. Un paio di righe gli confidano “Non ti ho dimenticato, raccontami di te”. Il ragazzo non ha come ascoltare il dvd e corre dall’amico Jamal. Le prime parole: “Volano aquiloni, intorno al mondo per portare pace…” Ahmed non ha trascurato la scrittura e il premio che gli consentì il viaggio in crociera. Risponde “Cara Amina, mille volte ho vissuto l’emozione di ricordare i giorni del nostro viaggio in mare, la dolcezza dei tuoi occhi e quel bacio innocente, spontaneo, dell’addio che ho sperato fosse solo un arrivederci. Io sto per completare i miei studi che dovrebbero consentirmi di diventare un ricercatore e quasi certamente mi porteranno lontano da Gaza. Chissà che un giorno non accada di incontrarci in qualche luogo del mondo estraneo alla guerra che divide i nostri popoli, magari in una città del mondo dove ti esibirai con il tuo violino e dove io, forse, sarò impegnato in una ricerca. Ti abbraccio”.
Amina e Ahmed non si incontreranno mai e avrà ragione la follia di una degenerazione della disumanità segnata da morti, violenze e odio.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 5 novembre 2017
La via crucis di Ernesto e Luisella
di Luciano Scateni
Inquieta chiedersi perché la vita sia cattiva matrigna di poveri cristi, perché si accanisca contro e li martirizzi, senza provare ribrezzo per la crudeltà di persecuzioni. L’intelligenza umana, anche la più perspicace, rifiuta di collocare il mistero dell’accanimento contro i poveri, diffuso nel sistema mondo. Di Ernesto e Luisella, di uomini e donne squassati dal dramma di percorsi della vita segnati da ogni male possibile, il pianeta Terra è al tutto esaurito. Perché loro e un miliardo di predestinati a giorni di patimenti, con le mani inutilmente unite in preghiera, rivoltea al nulla del cielo…?
Davvero una bella coppia. Luisella, Ernesto, amici, poi innamorati dal tempo delle medie in viale delle Acacie, su al Vomero, quartiere cresciuto a dismisura negli anni sessanta con la turpe cementificazione delle “Mani sulla città” magistralmente raccontata da Franco Rosi. Lei asseconda il talento e conclude gli studi all’istituto d’arte, si espone al giudizio di Clelia Matania con una mostra nella Galleria Mediterranea. Ernesto, con il diploma di ragioniere, affianca il padre, libraio vecchia maniera, consigliere prezioso di clienti fedeli di cui conosce preferenze, orientamento politico, capacità di spesa.
In vista del compleanno numero venticinque, Ernesto e Lisa si sposano civilmente e celebra il vice sindaco, al secondo piano di Palazzo San Giacomo, accanto alla stanza del primo cittadino. Non avranno bambini e rifiutano di accertare il perché, di mettere sulle spalle l’uno dell’altra la “colpa” dell’infecondità.
La libreria non ha vita facile. Il costo dell’affitto è oneroso, Napoli non è certo in vetta alla classifica italiana per numero di lettori, un paio di acquisti allettanti, offerti con sconti irrinunciabili, si rivelano un disastroso investimento che immobilizza un consistente invenduto e impegna le risorse tutt’altro che rassicuranti per il pagamento di fatture pesanti. Scavalcare la fine di ogni mese con i conti in ordine diventa impresa da ansia in crescendo che dice male al futuro della libreria. Il vecchio libraio con i segni sul viso di uno stato depressivo, è costretto a licenziare lo storico dipendente che per anni ha gestito l’impegnativo equilibrio acquisti-vendite. Padre e figlio riducono progressivamente il prelievo dagli incassi al minimo, limitate a esigenze quotidiane ampiamente ridimensionate. Quando i conti non tornano più il vecchio libraio sceglie generosamente di escludersi dai costi personali e anche se con la morte nel cuore si adatta all’inattività e alle ristrettezze imposte dalle pensioni minime, sua e della moglie casalinga.
La morte, precoce, lo libera dopo solo sei mesi dal peso di una condizione penosa. Le difficoltà di salvare il salvabile diventano un calvario che Ernesto ha consapevolezza di non poter gestire a lungo. Lisa condivide il disagio del marito e rimpiange di averlo assecondato nella scelta di non cercare un lavoro, dopo aver sperimentato che dalla pittura non avrebbe tratto nessun ritorno economico in una città da mercato dell’arte vicino allo zero anche per artisti apprezzati dalla critica. Il colpo di grazia per la libreria diventa questione di mesi, forse di giorni.
Ernesto bussa alla porta del “ragioniere”, sordido usuraio che strangola chi ricorre per disperazione ai suoi finanziamenti, con tassi di interesse da cinico strozzinaggio. I soldi del “prestito” sono appena sufficienti a onorare le tratte scadute. Ernesto torna dall’usuraio e il debito tocca livelli di incompatibilità con gli incassi della libreria. Guaio porta guaio. Una lettera dello studio legale che assiste il proprietario della libreria ricorda la scadenza del contratto di affitto e avverte che il rinnovo prevede un aumento di duemila euro al mese, “prendere o lasciare”.
C’è chi ipotizza che una delle cause di alcuni tumori sia il deficit del sistema immunitario provocato da stati d’animo all’estremo di negatività senza vie d’uscita. Ernesto non ne è consapevole, non associa la diagnosi di cancro del polmone al dissesto irrimediabile della libreria. “Sei mesi” gli dice il primario del Pascale, “forse meno”. Un amico a cui ha confidato la sentenza senza appello non sa come aiutarlo ma dopo qualche giorno la memoria gli restituisce la notizia di commercianti in ginocchio come Ernesto salvati dal fallimento. Un emissario del clan delle estorsioni, a conoscenza del disastro finanziario di un commerciate, si presenta al titolare del negozio con la proposta di acquistarlo per una cifra ‘ragionevole’. “Ernesto, se vuoi ti faccio contattare”. “No grazie, provo a resistere”. E ci prova, ma i distributori delle case editrici che monopolizzano il mercato gli negano altro credito, ritirano i libri invenduti, esigono il pagamento delle fatture inevase. Alle richieste dei clienti di libri indicati tra i top nelle speciali classifiche delle vendite, Ernesto è costretto a rispondere “mi spiace, non c’è e sono sempre meno i clienti solidali con le difficoltà della libreria. Appena resuscitato da una seduta di chemioterapia, Ernesto telefona all’amico, spinto alla resa dal confluire di eventi impossibili da gestire.
Nelle nottate insonni cerca nel futuro che gli rimane da vivere una via di uscita per il tempo in cui Lisa sarà sola ad affrontare la sopravvivenza. “Almeno non le lascerò debiti in eredità”. Quando sente che la vita sta per abbandonarlo, prega chi gli è subentrato nella gestione della libreria di assumere Lisa. Se ne va Ernesto e qualche mese dopo il camorrista a cui il clan di appartenenza ha dato la gestione del negozio capisce di non averne la capacità. Lo chiude e riapre dopo i lavori di ristrutturazione per vendere scarpe di marchi famosi contraffatti, ma non riassume Luisa. I risparmi durano poco, la donna cerca un qualunque lavoro e riceve una serie di no. Il proprietario della casa che abita è persona comprensiva e non la sfratta per morosità, ma le concede due mesi di inadempienza. Lisa vende come può i mobili, il letto matrimoniale, oggetti accumulati in otto anni di matrimonio, biancheria, abiti di Ernesto e suoi e si garantisce per un paio di mesi un tetto, in un albergo due stelle. Smagrisce, non ha parenti che l’aiutino, impara giorno dopo giorno a convivere con la povertà. Esauriti i pochi soldi rimediati con la vendita dei beni di modesto valore, si assicura un posto nell’ospizio che accoglie i senza tetto. Lì conosce Eleonora, una nobile decaduta al punto di chiedere l’elemosina sui gradini della chiesa del Gesù e Alberto, ridotto in miseria dal gioco, Gilberto, per anni assoldato come comparsa per i film girati a Napoli, ma ignorato quando la vecchiaia si è presentata con acciacchi debilitanti e Clementina, ripudiata dalla famiglia per aver messo al mondo una bambina con un delinquente che ha abbandonato madre e figlia. Da questi compagni in miseria Lisa impara che per un pasto caldo ci si mette in fila a mezzogiorno in punto nel locale mensa della Caritas, che chiedendo di bar in bar si può bere un caffè pagato da un cliente generoso, e che frugando nei cassonetti dell’Asia qualcosa di utile si può trovare.
A sera, distesa sul materasso che preme sulla schiena con le molle sporgenti, Lisa non piange neppure più, come era accaduto le prime notti in ospizio. Ha finito per sopportare anche il respiro greve dei letti accanto, le frasi incoerenti dei vicini, biascicate nel sonno, i passi dei ritardatari trascinati stancamente. Ora il pensiero che ricorre a occhi chiusi è di una fine anticipata della vita, del suicidio liberatorio, ma come una condanna definitiva, ha la meglio la consapevolezza di non sapersi dare la morte e torna alla morte dei vivi, la mano tesa ai passanti, accanto a sé un cane randagio adottato, docile, che attira la generosità dei puri di spirito.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 29 ottobre 2017
Irina
di Luciano Scateni
Lasciano la terra dove sono nati, gli affetti, gli usi tramandati da generazioni. In fretta imparano l’italiano, condizione primaria per trovare lavoro, subiscono umiliazioni, costrette a mansioni improprie, a dimenticare titoli elevati di studio conseguiti nei loro Paesi. Conducono una vita al risparmio, perché i figli abbiano un futuro garantito e i genitori una vecchiaia meno sofferta. Risolvono la grande questione italiana di uno Stato che non affronta e risolve le mille marginalità sociali con strumenti appropriati del welfare per garantire l’assistenza a malati e anziani. Il giovedì, a chi è concesso, la galleria Umberto I si affolla di questi migranti non integrati. Olga racconta a Ivana di Luba, giovane donna di Kiev che si sposa con un napoletano di settantotto anni, vedovo e incapace di affrontare la solitudine. “La tragica speranza di Luba è che per quanti malanni ha, non campi a lungo.
In una notte gelida di un Febbraio inoltrato e inondato di neve, Irina trascina la valigia piena di povere cose e si infila nel pulmino Volkswagen, stretta tra i pacchi inviati dalle famiglie alle compagne emigrate in Italia che con lo stesso tramite spediscono a casa gran parte dei guadagni. Il cuore a mille, lacrime amare, angoscia per la piccola Olga affidata a genitori in età avanzata, il buio di un futuro ignoto: il viaggio spossante attraversa momenti di pericolo alle frontiere, dove Mirko, collaudato autista, evita le perquisizioni a suon di euro passati di mano in mano per comprare la complicità dei doganieri. Il calvario del viaggio si conclude nella Napoli assonnata del primo mattino, alla via Marina. Sul biglietto custodito in petto nome e indirizzo di Tatiana, la cugina emigrata da dieci anni quando ne aveva diciannove. Il numero 16 di piazza Mercato è un palazzone dormitorio malandato, per lo più abitato da africani che s’arrangiano a vendere quanto producono fabbriche clandestine di borse, orologi, cd musicali contraffatti, per conto di caporalati camorristici.
 La casa che accoglie Irina è un grande e caotico agglomerato di promiscuità. Convivono uomini e donne dell’est europeo, nigeriani, albanesi, in condizioni di sovraffollamento e privacy zero. Tatiana può offrire all’amica un posto nel suo letto a castello, una sedia, un minimo spazio nell’armadio sgangherato, quel che resta in un paio di mensole fissate sulla parete al di sopra di un fornello alimentato da bombole di gas.
La casa che accoglie Irina è un grande e caotico agglomerato di promiscuità. Convivono uomini e donne dell’est europeo, nigeriani, albanesi, in condizioni di sovraffollamento e privacy zero. Tatiana può offrire all’amica un posto nel suo letto a castello, una sedia, un minimo spazio nell’armadio sgangherato, quel che resta in un paio di mensole fissate sulla parete al di sopra di un fornello alimentato da bombole di gas.
“Irina, forse ti ho trovato un lavoro. La signora dove sto a servizio ha la mamma disabile e cerca una badante.” Dopo un paio di giorni inizia l’assistenza dell’amica a una donna dispotica, aggressiva, insolente. Prendere o lasciare. Irina non ha neppure una mezza giornata di libertà, è condizionata nel mangiare dall’unica cucina consentita, che limita quantità e qualità del cibo per assecondare le prescrizioni mediche della vecchia, afflitta da molti acciacchi e malattie. Nei pochi momenti di pausa concessi dalla velenosa assistita, la donna prova a consolarsi ripercorrendo le ragioni che l’hanno spinta a fuggire da Nezin, cittadina non distante da Kiev. I genitori se ne sono liberati sposandola a Igor, un manesco scaricatore dei mercati generali della capitale e come gran parte degli ucraini marito padrone. L’uomo semi alcolizzato, ha schiavizzato la moglie, umiliata, frustrata con un matrimonio senza amore e rispetto. L’esasperazione di Irina è montata dopo numerosi episodi di violenze subite senza nessun motivo se non la convinzione dell’energumeno di poter sfogare a suo piacimento l’istinto bestiale di picchiare la moglie. “Qui, almeno non vivo l’incubo di violenze fisiche e umiliazioni” è la modesta consolazione della giovane donna, che in Ucraina ha cercato inutilmente, per anni, di mettere a frutto il diploma della scuola d’arte di Kiev, frequentata sopportando i disagi di un scomoda pendolarità.
Si sbaglia e dovrà presto ricredersi. Di tanto in tanto compare in casa il genero della donna che Irina accudisce. Vincenzo è un omone dai modi bruschi. Dice di lui, chi lo conosce, che è un tipo poco raccomandabile. Nella fedina penale anche l’aggressione a una turista tedesca, adescata in un angolo solitario della villa comunale di Napoli, aggredita e stuprata. Irina, in un giorno come tanti di premure pretese dalla donna assistita, si rifugia nella sua stanza, un bugigattolo ricavato nel sottoscala. Si poggia sul letto e ascolta in cuffia una melodia della sua terra. Non sente entrare Vincenzo che chiude dietro di sé la porta, si avvicina al letto e le mette una mano sulla bocca. La minaccia è senza scampo: “Se gridi o ti ribelli” ti denuncio come clandestina e ti faccio rispedire di dove sei venuta”. In quegli attimi di terrore la donna pensa alla figlioletta, al lavoro che le consente di non farle mancare niente, alle brutalità subite dal marito e tace, si sente violare dal bruto e non ha un gemito, annulla il tentativo istintivo di resistere. Solo le lacrime raccontano quello che le accade, il ricatto di un vigliacco, la sua fragilità di vittima senza difesa, il ricordo di una scelta obbligata che l’ha strappata alla sua terra.
Diventa muta Irina, va in depressione, la donna che assiste la investe di rimbrotti ingiuriosi. “Che hai cretina, sei in silenzio stampa? In casa mia mummie egiziane non ne voglio”. Il rapporto della badante con la disabile si inasprisce, trascende, diventa invivibile. In un giorno cupo di Napoli, quando il sole si diverte a smentire il mito di città privilegiata dal clima, la badante strappa il permesso di assentarsi per un paio di ore. E’ davanti a Jamal, sindacalista palestinese che si occupa di migranti e si racconta. “Se ho qualcosa per te ti mando un messaggio” conclude l’incontro e Irina spera. Squilla il cellulare, Jamal le propone di lavorare in una piccola fabbrica di guanti. Il salario non è alto, ma decide per lei l’obiettivo di liberarsi della vecchia disabile e dalle brutalità del genero.
Dieci, undici ore al giorno a fare guanti per un famoso stilista, pochi gesti ripetuti all’infinito, in un piccolo vano con l’assordante ticchettio delle macchine per cucire e i sermoni della titolare dell’impresa: “Siamo una famiglia e il lavoro, qua dentro, dà a mangiare a tutti noi. Se vi chiedo di lavorare oltre l’orario di normale chiusura e perché avrà presto un ritorno. Vi offro subito un aumento di venti euro al giorno.
Irina ha la testa china sul tavolo di lavoro, gli occhi che bruciano, affaticati e iniettati di sangue, una bestemmia le sale dal profondo dell’anima, per la rabbia repressa giorno dopo giorno.
Piove stamattina, il vento entra dalle fessure della finestra con gli infissi decrepiti. La notte se n’è andata via lenta, dolente, insonne, un incubo dopo l’altro.
 Irina corre con affanno nella via principale di Nezin, inseguita da soldati russi che le gridano “alt”, l’ammanettano e la richiudono in una cella angusta, buia, ’abbandonata per giorni e giorni. L’isolamento è rotto da interrogatori e violenze senza risposta: “Chi è il terrorista che vuole uccidere il Presidente, dove lo nascondi?”
Irina corre con affanno nella via principale di Nezin, inseguita da soldati russi che le gridano “alt”, l’ammanettano e la richiudono in una cella angusta, buia, ’abbandonata per giorni e giorni. L’isolamento è rotto da interrogatori e violenze senza risposta: “Chi è il terrorista che vuole uccidere il Presidente, dove lo nascondi?”
A cacciare dalla testa l’angoscia da incubi interviene la ribellione di Irina alla schiavitù di badante. Incurante della pioggia che ha intriso i capelli e gli abiti, che riga le guance e annebbia la vista, si accascia su una panchina di via Caracciolo e resta immobile a soffrire la dolorosa rivisitazione di una vita disgraziata. S’incammina, come un automa, scavalca la ringhiera con cui si conclude lateralmente la strada, percorre con difficoltà la scogliera anti flutti e siede su un masso dove un ragazzo innamorato ha tracciato con vernice rosa “Rosa sei la mia vita. Ti amo” e si ritrova in acqua, senza averlo deciso. L’istinto di conservazione la spinge a lottare per non affogare. Si sente stringere da mani robuste, un braccio intorno al collo le tiene la testa fuori dall’acqua, avverte l’ansimare del salvatore, un ragazzo in tuta come tanti che si allenano correndo sul lungomare per prolungare la tradizione napoletana degli ori nel canottaggio. Un ispettore di polizia le chiede “Perché?” Irina lo guarda smarrita e non risponde, gli occhi bassi, spenti dalla rassegnazione.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 22 ottobre 2017
Semplicemente Alex: ritratto di Zanotelli
Incontri che riconciliano con il mondo del menefreghismo, del “basta che sia bene io”, con le mostruose storture che legano l’egoismo violento degli uomini delle caverne ai ricchi della Terra approdati al club dei potenti calpestando i diritti fondamentali dei poveri. Incontri che scalfiscono per un momento il disprezzo per la corruzione che ha omologato parte del clero ai soggetti finiti nel mirino delle tangentopoli, al peggio della depravazione con le migliaia di preti pedofili. Incontri che squarciano i veli pietosi sul clamoroso deficit di onestà e competenza della politica, di quell’ampia schiera di mestieranti che rappresentano solo se stessi. Incontri che restituiscono, purtroppo solo nella loro unicità, l’ottimismo della ragione, che abita “miracolosamente” nel pensiero e nei comportamenti di un servo di Dio comboniano.
di Luciano Scateni
Sono certo, Alessandro, Alex per il mondo che lo conosce, vorrebbe che ci parlassimo con il “tu”. Ed è così che provo a dialogare con la sua mente, la sua anima, i suoi pensieri, l’intensità, il rigore, la generosità, l’abnegazione, la coerenza, il coraggio, la saggezza, la combattività, la tenacia, la determinazione, la sua guerriglia permanente per il rispetto dei diritti umani, l’eguaglianza sociale, il riscatto delle povertà, contro i poteri forti, la violenza prevaricatrice dei privilegiati sui diseredati, i predatori di risorse altrui, i guerrafondai, gli inquinatori del mondo, il sessismo, le forme palesi o subdole di razzismo, l’omofobia, i poteri temporali della Chiesa, l’ignavia, la corruzione, la codardia di chi finge di non vedere e sentire le sofferenze dei deboli e degli oppressi.
Le note biografiche, nella sintesi dei siti internet, dicono di lui: “Ispiratore e fondatore di movimenti con l’obiettivo di creare le condizioni della pace e di una società solidale in cui gli ultimi abbiano cittadinanza”.
Cioè molto poco del percorso attraversato nell’universo delle sofferenze di cui è causa il pianeta di quanti rastrellano con ogni mezzo le ricchezze del mondo, cinicamente indifferenti alle tragedie della povertà e insultano la natura e ne traggono profitto. I comboniani e Alex lo è, sono un’isola lussureggiante nell’arcipelago della cristianità dalle mille facce, del cardinale che si insedia in un attico compatibile solo con la proprietà di un star hollywoodiana, di un emiro petroliere, di un asso plurimilionario del calcio o di sport altrettanto da nababbi e, agli antipodi, di servi di Dio che spendono energie, intelligenze e impegno di una vita intera dalla parte degli ultimi. “Spesso mi domando chi sono e mi rispondo. Sono le persone che ho incontrato” dice di sé Alex Zanotelli, prete comboniano. Non è facile iniziare il racconto dei suoi anni, quasi ottanta, vissuti con “miracolosa” intensità, ma sono certo che lui negherebbe di essere identificato per la laurea honoris causa conferita dal Dipartimento Jonico dell’Università di Bari e forse neppure per il ruolo di direttore di riviste dei non violenti.
Alex quando e dove. Otto anni in missione nel Sudan devastato dalla guerra civile, avversato del potere locale per le sue denunce di ingiustizie inflitte ai poveri, della corruzione del governo che intascava i fondi internazionali destinati allo sviluppo, per aver manifestato solidarietà al popolo Nuba, etnia emarginata. Non gli fu alleata neppure la Curia di Roma, più interessata al proselitismo di culture e religioni altre. Il Sudan, infastidito dalla sua incisiva contestazione gli nega il visto per rientrare nel Paese. Alex torna in Italia, a Verona, dov’è la Casa Madre dei comboniani e assume la direzione del mensile Nigrizia che trasforma in un atto d’accusa per affrontare i problemi dei Sud del mondo.
I suoi editoriali denunciano il coinvolgimento dell’Italia nel commercio delle armi che alimentano le guerre in Africa, il razzismo in Sudafrica, posizioni non condivisibili dei politici. Soprattutto questa inclusione nel repertorio della contestazione provoca la reazione del clero che gli contesta l’impegno politico, perché “contrario alla missione religiosa”, fino a destituirlo dalla direzione di Negrizia. Chiunque altro, non fosse stato Zanotelli, avrebbe rinunciato alla vocazione di fustigatore, ma non lui che diventa direttore di Mosaico di Pace dopo la decisione di andare in missione nel Kenia, dove opera a Korogocho, misera baraccopoli attorno alla capitale Nairobi, luogo di degrado estremo, marginalità sociale che deve confrontarsi con problemi di Aids, droga, alcolismo, criminalità. Alex riesce a mettere in piedi una cooperativa per il recupero dei rifiuti che dà lavoro a molti abitanti e a una comunità di prostitute che aiuta a cambiare vita, senza trascurare la lotta per la redistribuzione delle terre.
 C’è chi ricorda che in quel contesto disperato Zanotelli pensa e dice “Forse Dio è malato”, cioè assente. Il tempo di Nairobi si conclude e la scelta di continuare la missione a Napoli parte dal rione Sanità, territorio urbano dove vive e si propone di ridare fiducia a chi l’ha persa, perché cancellata dal degrado, dall’abbandono, dove ogni cosa è sotto opzione della malavita. Alex non perde di vista le storture della politica nazionale e si scaglia contro l’aumento delle spese militari. Una battaglia ferma, coinvolgente, lo impegna contro la privatizzazione dell’acqua, protagonista di innumerevoli iniziative. Alex urla la rabbia per le conseguenze che il bene primario sottratto alla mano pubblica finisca per far pagare anche questo ai poveri del Sud del mondo. Nel bersaglio del prete comboniano finiscono anche la Banca Mondiale, il fondo monetario, l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Alex diffonde l’idea della Rete Lilliput che impegna comunità cattoliche oltre i confini di Napoli.
C’è chi ricorda che in quel contesto disperato Zanotelli pensa e dice “Forse Dio è malato”, cioè assente. Il tempo di Nairobi si conclude e la scelta di continuare la missione a Napoli parte dal rione Sanità, territorio urbano dove vive e si propone di ridare fiducia a chi l’ha persa, perché cancellata dal degrado, dall’abbandono, dove ogni cosa è sotto opzione della malavita. Alex non perde di vista le storture della politica nazionale e si scaglia contro l’aumento delle spese militari. Una battaglia ferma, coinvolgente, lo impegna contro la privatizzazione dell’acqua, protagonista di innumerevoli iniziative. Alex urla la rabbia per le conseguenze che il bene primario sottratto alla mano pubblica finisca per far pagare anche questo ai poveri del Sud del mondo. Nel bersaglio del prete comboniano finiscono anche la Banca Mondiale, il fondo monetario, l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Alex diffonde l’idea della Rete Lilliput che impegna comunità cattoliche oltre i confini di Napoli.
Pubblica il libro dal significativo titolo di “Contro il capitale globale. Chi avesse avuto ancora dubbi sulla personalità “politica” di Zanotelli dovrebbe ricredersi e riflettere sul tema “cos’è il comunismo” che vede opposte convinzioni non facili da disegnare. Una posizione, netta, tetragona, semplicistica, contesta il marxismo, soggetto ideologico di quanto è accaduto in Unione Sovietica, con lo stalinismo e la tirannia della burocrazia statale, gli estremismi che hanno soffocato sanguinosamente le libertà. Altri definiscono la nostalgia comunista patologia da frustrazione, epoca di archeologia della politica, limite labile tra sudditanza del Pci all’Urss e passione anacronistica per una stagione irripetibile. Se c’è una terza via? Disillusi che per inerzia disconoscono l’attualità del marxismo, seppure ridisegnato in sintonia con le diversità del terzo millennio, rifiutano la tesi che le missioni di Alex Zanotelli siano la rappresentazione corretta, pulita, del comunismo praticato nella sua autentica. Scrive Alex: “L’Unione Europea è diventata una fortezza che respinge i naufraghi, il frutto di un Sistema economico dove pochi, il 20% della popolazione del mondo, consumano il 90% dei beni prodotti. Si calcola che in diciotto anni sono morti nella traversata del Mediterraneo molte decine di migranti. Un’ecatombe. E’ in atto nel Mediterraneo un genocidio di profughi e migranti. La UE non vuole accogliere questi uomini e donne, i bambini non accompagnati che fuggono da guerre, dittature, dalla miseria. L’ipocrisia dell’Europa si è manifestata platealmente quando ha deciso di sostituire Mare Nostrum (un’operazione messa in atto dal governo italiano e che ha salvato oltre 100.000 persone) con TRITON, il cui scopo non è salvare vite umane, ma proteggere i confini di Shengen, tenere i ‘barbari’ fuori dalla Fortezza Europa. Nello spirito di Papa Francesco che ha definito i migranti la carne di Cristo, nostri fratelli, cercatori di felicità e a Lampedusa ha chiesto “Avete mai pianto quando avete visto un barcone affondare”, ripeto le parole di Gad Lerner : “Quando ci protendono le mani da una zattera in mezzo a quel mare, non c’è altro gesto di umanità possibile che protendere verso di loro le nostre braccia. Non c’è altra salvezza che una salvezza comune”. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 15 ottobre 2017
Il mistero di Via Caravaggio
do you remember? Lo ricordate?
di Luciano Scateni
Non è raro. Succede che la cronaca di eventi tragici si arrenda all’ impossibilità di raccontare il finale, che rinunci a svelare i perché e i come di stragi, di omicidi finiti nel nulla, di misteri insoluti. In particolare di uno, Napoli non ha più memoria dopo quarant’anni di indagini su indagini, di una caccia all’uomo senza precedenti, di una presunta soluzione del “caso”, che ha costretto alla smentita chi ha investigato. Insomma, il dossier del “massacro” di via Caravaggio se ne sta inutilmente custodito nell’archivio dell’insoluto
“Chi l’ha visto?” Il programma degli scomparsi era ancora in fieri ed era solo futuro immaginifico la sua imitazione quotidiana della “Vita in diretta”, ma anche fossero stati contemporanei della strage di via Caravaggio, nulla avrebbero potuto aggiungere al faticoso e vano affannarsi di Polizia e Magistratura lungo l’incredibile caccia all’assassino che dopo quarant’anni si è conclusa con la bandiera bianca della resa e senza l’onore delle armi. Nell’immaginario collettivo dei napoletani rimane l’immersione piena nel buio del mistero che ha reso unica la strage di via Caravaggio. Di tanto in tanto i cronisti di nera e di giudiziaria ripropongono l’iter nebuloso e il finale clamorosamente contraddittorio che ha ostacolato una verità credibile su autore/i del triplice delitto.
E’ la notte di un giovedì, è il trenta ottobre, corre l’anno 1975. Napoli non è avvezza a scenari apocalittici di delitti che i media definiscono “efferati” e si sveglia con titoli dei quotidiani, non solo italiani, a tutta pagina.
Lui, 54 anni, venditore, ex capitano di lungo corso. Lei, 50 anni, seconda moglie, ostetrica, già insegnante, la figlia dell’uomo, 19 anni, dipendente dell’Inam: uccisi a colpi mortali sul capo, poi sgozzati. Stessa sorte per il loro cane, morto per asfissia, la testa avvolta in una coperta. Domenico Santangelo e Gemma Cennamo insieme a Dix, il loro Yorkshire, ficcati nella vasca da bagno, Angela, la figlia di Domenico, avvolta in un lenzuolo insanguinato e gettata sul letto matrimoniale.
Parte la caccia all’uomo e sembra un avvio promettente. Nella casa degli orrori si rilevano orme di scarpe nel sangue che ricopre il pavimento, impronte digitali su bottiglie di alcolici. Il “di chi sono” resterà per troppo tempo un mistero. Di sicuro si ritiene di accertare che non sono di Domenico Zarrilli, nipote della donna uccisa, figlio di un alto magistrato, fratello di un avvocato, ma Zarrilli è sospettato, arrestato e condannato all’ergastolo. E’ il 1978. Contro di lui l’ipotesi di un raptus in risposta al no della zia a una richiesta di denaro, una ferita alla mano per un morso di cane, una testimonianza e alcuni indizi. La città, nonostante la mancanza di prove certe, si divide tra colpevolisti e innocentisti. L’interesse in molti casi morboso per la vicenda rimane alto a lungo, non finirà mai in angoli remoti della memoria. Zarrilli si laurea da carcerato in legge e avoca a sé gran parte dell’impegno di dimostrare la sua innocenza o quanto meno l’infondatezza della condanna.
 Il colpo di scena si deve alla Corte di Cassazione che ribalta la sentenza, manda libero il presunto assassino e lo risarcisce dei danni morali e materiali. Giustizia è fatta? Se il mistero è avvolto nelle nebbie dell’incertezza, il pathos che la strage ha suscitato ha invece chiaro che se non esiste il delitto perfetto è anche vero che i passi in avanti delle indagini, decisivi con l’esame del Dna, avrebbero fornito agli inquirenti la prova cercata per anni. La polizia scientifica, priva a quel tempo di questo strumento decisivo, esamina i reperti prelevati nella casa della strage: un bicchiere adoperato da chi ha bevuto wiskey, mozziconi di sigaretta, perfino un asciugamano macchiato di sangue. Li giudica “incompatibili con i profili delle vittime”. E’ il 2001. Tredici anni dopo una nuova perizia e nuove analisi scientifiche, che comprendono l’esame del Dna che attribuirebbero i reperti a Zarrelli (poi assolto in via definitiva) e ad altri soggetti, tre uomini e una donna.
Il colpo di scena si deve alla Corte di Cassazione che ribalta la sentenza, manda libero il presunto assassino e lo risarcisce dei danni morali e materiali. Giustizia è fatta? Se il mistero è avvolto nelle nebbie dell’incertezza, il pathos che la strage ha suscitato ha invece chiaro che se non esiste il delitto perfetto è anche vero che i passi in avanti delle indagini, decisivi con l’esame del Dna, avrebbero fornito agli inquirenti la prova cercata per anni. La polizia scientifica, priva a quel tempo di questo strumento decisivo, esamina i reperti prelevati nella casa della strage: un bicchiere adoperato da chi ha bevuto wiskey, mozziconi di sigaretta, perfino un asciugamano macchiato di sangue. Li giudica “incompatibili con i profili delle vittime”. E’ il 2001. Tredici anni dopo una nuova perizia e nuove analisi scientifiche, che comprendono l’esame del Dna che attribuirebbero i reperti a Zarrelli (poi assolto in via definitiva) e ad altri soggetti, tre uomini e una donna.
Si apre una pagina nuova, scritta in larga parte dal legale di una donna erede di Domenico Santangelo. Questi afferma che le impronte nel sangue sul pavimento sono di più persone e così il Dna. Ipotizza che le vittime siano state prima colpite e accoltellate in un secondo momento. Nulla di tutto questo convince i magistrati a riaprire il caso.
L’orrore suscitato dal triplice delitto si è riverberato per molto tempo sul luogo della strage: l’abitazione dei crimini è rimasta sfitta per molto tempo e il mistero raccontato a tinte fosche dai media ha tenuto vivo il ricordo di via Caravaggio fino ad oggi. Forse sarebbe scemato se il fattaccio fosse accaduto in questo 2016 che racconta ogni giorno l’orrore di femminicidi, di genitori che uccidono moglie e figli e si tolgono la vita, di rapine con pestaggi brutali ai danni di anziani indifesi e guardando oltre i nostri confini, di stragi dei terroristi, esecuzioni di boia Jiadisti, di uomini, donne e bambini esposti al fuoco nemico come scudi umani.
Capita di inerpicarsi in auto lungo la via Caravaggio. All’altezza del palazzone della strage ogni volta lo sguardo cerca le finestra della casa dove la notte di quarantuno anni fa uno o più assassini hanno massacrato Domenico, Gemma, Angela e hanno infierito anche sul loro cane, quasi certamente per non farlo abbaiare. Superato il luogo del triplice omicidio, un lungo respiro, liberatorio, favorisce il ritorno alla realtà, a quella casa alla fine abitata, ma chissà, da “forestieri”, che hanno alzato le spalle in segno di indifferenza al racconto di quanto è avvenuto in quell’appartamento. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 8 ottobre 2017
Rosa
di Luciano Scateni
La media s’avvicina a uno stupro al giorno e chissà quanti sopportati in silenzio, come un martirio. Per vergogna, fragilità, paura dell’onta di chi insulta con un ignobile “La verità: ci sei stata, eh?” Il vulnus sociale sembra insanabile e in crescendo, pari alla violenza della pedofilia, di esseri ignobili, quasi sempre sessualmente repressi per il voto di castità prescritto dal cattolicesimo, in incomprensibile antagonismo al volere di Cristo, che a uomini e donne, senza nessun discrimine, ha detto “crescete e moltiplicatevi”
Le sette del mattino, quando sulle spalle hai una notte insonne pesano, come macigni. E sai che ti aspetta un’altra giornata, nove ore e più del ronzio ritmico della macchina per cucire che va, spinta sulla pedaliera con poca, costante pressione, ad assecondare i tempi che separano la cucitura di un guanto dalla successiva. Ottavio (ma chi gli ha dato questo nome incoerente?) controlla, senza darlo a vedere, che i guanti finiti, poggiati accanto alla ruota che muove il cordone in pelle della macchina, raggiungano l’altezza della pila fissata per ottimizzare il lavoro a cottimo. L’avessero chiamato Cerbero, niente da dire.
Stessi gesti all’infinito, gli occhi sui bordi dei guanti da cucire con precisione millimetrica come chiede il committente milanese fornitore delle pelli, dei contenitori firmati, perfino del filo adeguatamente resistente per le cuciture. Le dita di Rosa questa mattina hanno poca sensibilità, privata dalla pressione dell’artrosi sui nervi cervicali. La testa è altrove, alla stanza di casa, all’accampamento dove dormono, stretti uno accanto all’altro lei, il padre e la madre. Tutti e due, dopo quarant’anni di esposizione all’umidità della stanza, separata da un muro macchiato vistosamente dalla traspirazione della roccia su cui poggia, sono devastati da tosse senza rimedio e da respirazione faticosa, che peggiora di notte. Rosa fatica a prendere sonno e ne esce ad ogni colpo di tosse più forte e prolungato. Ha tutto il tempo per maledire lo schifo di vita che si porta dietro da bambina, “’a mala sorte”, il buio di un futuro che sembra destinato a negarle la normalità di giovane donna. Nel pieno della notte si alza silenziosamente e se ne va nel cucinino, chiude la porta della stanza da letto dietro le spalle e i rumori notturni dei genitori diventano sopportabili.
China sulla macchina per cucire, a tratti le si annebbia la vista e stenta a seguire con precisione il filo che salda i bordi dei guanti. Il boss le si avvicina: “Guagliò, oggi non è cosa. Lieve mano, vattenne a’ casa”. Rosa, non fosse un giorno di quelli che scendi dal letto e poggi a terra il piede sinistro, avrebbe stretto i denti e ripreso a confezionare i maledetti guanti della “Nuova Linea”. Oggi no. Il sole, che stenta a infilarsi nello stretto dei vicoli, è comunque un compagno della libertà che la estranea dalla luce al neon della piccola fabbrica, al terzo piano di uno dei palazzi dei “Quartieri spagnoli” risparmiati dal terremoto dell’80.
Via Toledo, come ad ogni ora del giorno e della sera, è la più popolata concentrazione di anime d’Italia che induce i benpensanti a chiedersi “ma a Napoli non lavora nessuno?”. Lungo il perimetro della Galleria Umberto le botteghe di abbigliamento fanno sognare le donne. Sognare perché i prezzi sono proibitivi.
Nel market di informatica Eugenio sistema in vetrina il mini cavalletto che ospita l’ultimo nato di una stirpe a costi proibitivi di smartphone, oggetto del desiderio, appagato e non da pochi grazie a tagli drastici su ogni altro genere di spese. Come rinunciare a più pixel della fotocamera, ad “app” innovative, a forme ultrapiatte, all’inedito dell’impermeabilità?
“Eugenio…”
“Ué, Rosa e che ce fai qua?”
“Passavo. Oggi nun fatico”.
Un caffè shakerato, un paio di battute di circostanza, in fretta perché lui deve tornare al negozio.
“Rosa te vengo a piglià, stasera”.
“Gesù e che mi metto?”. Ci pensa mamma Dora. “Avimmo ’a stessa taglia, ti presto ’stu vestito rosso”.
 La Panda parcheggia lungo un tornante del parcoVirgiliano, il parco dell’amore dove le coppie che non si possono consentire altro si appartano in macchina e oscurano i finestrini con i giornali. Rosa ha voglia di baciare Eugenio da sempre. Lo ha sognato a occhi aperti cercando la posizione meno scomoda nel letto, che avrebbe bisogno urgente di un nuovo materasso. E’ stato un pensiero costante in mille momenti di noia e stanchezza alla macchina per cucire. Ogni volta, finito il lavoro, si è allontanata da casa per passare davanti al negozio di Eugenio, per vederlo.
La Panda parcheggia lungo un tornante del parcoVirgiliano, il parco dell’amore dove le coppie che non si possono consentire altro si appartano in macchina e oscurano i finestrini con i giornali. Rosa ha voglia di baciare Eugenio da sempre. Lo ha sognato a occhi aperti cercando la posizione meno scomoda nel letto, che avrebbe bisogno urgente di un nuovo materasso. E’ stato un pensiero costante in mille momenti di noia e stanchezza alla macchina per cucire. Ogni volta, finito il lavoro, si è allontanata da casa per passare davanti al negozio di Eugenio, per vederlo.
Niente preliminari. Rosa si sente afferrare da braccia forti, prepotenti. Una mano le strappa i primi bottoni del vestito, libera un seno dalla sottoveste, lo stringe fino a farle male. Non c’è difesa e Rosa capisce in un attimo di aver fantasticato ingenuamente su questi momenti, senza riserve, certa di essere innamorata dell’uomo giusto, rassicurata dalla sua correttezza abituale. Prova a resistere alla violenza e sa che Eugenio non si fermerà alle mani che le sono addosso, la spogliano e la picchiano per vincere ogni tentativo di resistenza. Non le resta che piangere, mentre subisce lo stupro. Piange per il dolore di dover convivere in solitudine il trauma della violenza subita senza poterlo condividere nemmeno con la madre. Non denuncerà Eugenio, ha paura. Teme si possa pensare che era consenziente, che non le credano.
E’ un giorno come cento altri nella fabbrica di Ottavio, i guanti da rifinire sono sempre lì, un mucchio di cuciture da fare senza sbavature, per seicento euro al mese senza contributi. E c’è il viso stanco, le rughe che disegnano una fitta ragnatela, gli occhi bassi sulla macchina per cucire di Gemma, 75 anni compiuti, guantaia fuori età per mantenere il marito e compensare la sua pensione di quattrocento euro racimolata in pochi anni di lavoro dipendente, per dare una mano al figlio disoccupato con moglie e due figli a carico. Racconta Gemma, con un filo di voce, di “Mario, sposato senza amarlo, per obbedire ai miei genitori. Così ti sistemi mi hanno detto per convincermi e lui mi ha trattato come una serva. Ancora adesso che mi spezzo la schiena, alla mia età, se ne sta in poltrona dalla mattina alla sera, senza muovere un dito, pretende che gli cucini quello che ordina al mattino e biancheria stirata alla perfezione. Mi vorrei ammalare, credemi Rosa. A volte penso di morire nel sonno, di trovare così la pace”.
Incinta di tre mesi Rosa non può nasconderlo più. “Ci penso io”: la madre non ha dubbi. Tutti, nel quartiere sanno che se vuoi liberarti di un figlio non voluto devi ingaggiare la mammana che ha fatto abortire decine di donne. “Brava è brava”, sussurrano tra loro la madre e la zia di Rosa, che ha messo a disposizione la casa. L’imprevisto le smentisce. Alle prese con un’imponente emorragia, la mammana non può che arrendersi. “Subito in ospedale”, dice trafelata. L’ambulanza arriva dopo trentacinque minuti. Troppi. L’emorragia ha la meglio e la corsa al Pronto Soccorso non salva la vita di Rosa.
Eugenio, nel suo negozio di informatica, è alla prese con una ragazza attraente. Sente che “ci sta” e le strappa un appuntamento. “Stasera, qui, alla chiusura del negozio”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 1 ottobre 2017
Luisella, Ernesto. Storia di povertà
di Luciano Scateni
Che ne sappiamo delle povertà. Quanto ne sappiamo? Poco e quanto traspare dai rari resoconti della cronaca di un inverno di morte , se un senza dimora crepa di freddo, se in una laboriosa cittadina emiliana un buco in fronte racconta il suicidio Mario Rossi sconfitto dalla crisi, impedito a pagare i dipendenti e un cumulo di tasse non onorate. Che sapremmo di Luisella ed Ernesto se qualcuno non confidasse a un amico giornalista la pena per non aver potuto aiutarli?
Davvero una bella coppia. Luisella, Ernesto, piccoli amici, poi innamorati dal tempo delle medie in viale delle Acacie, su al Vomero, quartiere cresciuto a dismisura negli anni sessanta con la cementificazione delle “Mani sulla città” magistralmente raccontata da Franco Rosi. Lei asseconda il talento e conclude gli studi all’istituto d’arte, si espone al giudizio di Clelia Matania con una mostra nella Galleria Mediterranea. Ernesto, con il diploma di ragioniere, affianca il padre, libraio vecchia maniera, consigliere prezioso di clienti fedeli di cui conosce preferenze, orientamento politico, capacità di spesa. In vista del compleanno numero venticinque, Ernesto e Luisa si sposano civilmente. Celebra il vice sindaco, al secondo piano di Palazzo San Giacomo, accanto alla stanza del primo cittadino. Non avranno bambini e rifiutano di accertare il perché, di mettere sulle spalle l’uno dell’altra la “colpa” dell’infecondità.
La libreria non ha vita facile. Il costo dell’affitto è oneroso, Napoli non è certo in vetta alla classifica italiana per numero di lettori, un paio di acquisti allettanti, offerti con sconti irrinunciabili, si rivelano un disastroso investimento che immobilizza un consistente invenduto e impegna le risorse tutt’altro che rassicuranti per il pagamento di fatture pesanti. Scavalcare la fine di ogni mese con i conti in ordine diventa impresa da ansia in crescendo che dice male al futuro della libreria. Il vecchio libraio con i segni sul viso di uno stato depressivo, è costretto a licenziare lo storico dipendente che per anni ha gestito l’impegnativo equilibrio acquisti-vendite. Padre e figlio riducono progressivamente il prelievo dagli incassi al minimo per esigenze quotidiane ampiamente ridimensionate. Quando i conti non tornano più il vecchio libraio sceglie generosamente di escludersi dai costi personali e anche se con la morte nel cuore si adatta all’inattività e alle ristrettezze imposte dalle pensioni minime, sua e della moglie casalinga.
La morte, precoce lo libera dopo solo sei mesi dal peso di una condizione penosa. Le difficoltà di salvare il salvabile diventano un calvario che Ernesto ha consapevolezza di non poter gestire a lungo. Lisa condivide il disagio del marito e rimpiange di averlo assecondato nella scelta di non cercare un lavoro, dopo aver sperimentato che dalla pittura non avrebbe tratto nessun ritorno economico in una città da mercato dell’arte vicino allo zero anche per artisti apprezzati dalla critica. Il colpo di grazia per la libreria diventa questione di mesi, forse di giorni.
Ernesto bussa alla porta del “ragioniere”, sordido usuraio che strangola chi ricorre per disperazione ai suoi prestiti, con tassi di interesse da cinico strozzinaggio. I soldi del “prestito” sono appena sufficienti a onorare le tratte scadute. Ernesto torna dall’usuraio e il debito tocca livelli di incompatibilità con gli incassi della libreria. Guaio porta guaio. Una lettera dello studio legale che assiste il proprietario della libreria ricorda la scadenza del contratto di affitto e avverte che il rinnovo prevede un aumento di duemila euro al mese, “prendere o lasciare”.
C’è chi ipotizza che una delle cause di alcuni tumori sia il deficit del sistema immunitario provocato da stati d’animo all’estremo di negatività senza vie d’uscita. Ernesto non ne è consapevole, non associa la diagnosi di cancro del polmone al dissesto irrimediabile della libreria. “Sei mesi” gli dice il primario del Pascale, “forse meno”. Un amico a cui ha confidato la sentenza senza appello non sa come aiutarlo ma dopo qualche giorno la memoria gli restituisce la notizia di commercianti in ginocchio come Ernesto salvati dal fallimento. L’emissario del clan delle estorsioni, a conoscenza del disastro finanziario di un commerciate, si presenta al titolare del negozio con la proposta di acquistarlo per una cifra ‘ragionevole’. “Ernesto, se vuoi ti faccio contattare”. “No grazie, provo a resistere”. E ci prova, ma i distributori delle case editrici che monopolizzano il mercato gli negano altro credito, ritirano i libri invenduti, esigono il pagamento delle fatture inevase. Alle richieste dei clienti di libri indicati tra i top nelle speciali classifiche delle vendite, Ernesto è costretto a rispondere “mi spiace, non c’è” e sono sempre meno i clienti solidali con le difficoltà della libreria. Appena resuscitato da una seduta di chemioterapia telefona all’amico, spinto alla resa dal confluire di eventi impossibili da gestire.
Nelle nottate insonni Ernesto cerca nel futuro che gli rimane da vivere una via di uscita per il tempo in cui Lisa sarà sola ad affrontare la sopravvivenza. “Almeno non le lascerò debiti in eredità”. Quando sente che la vita sta per abbandonarlo prega chi gli è subentrato nella gestione della libreria di assumere Lisa. Se ne va Ernesto e qualche mese dopo il camorrista a cui il clan di appartenenza ha dato la gestione del negozio capisce di non averne la capacità. Lo chiude e riapre dopo i lavori di ristrutturazione per vendere scarpe di marchi famosi contraffatti, ma non riassume Luisa.
I risparmi durano poco, la donna cerca un qualunque lavoro ma riceve una serie di no. Il proprietario della casa che abita è persona comprensiva e non la sfratta per morosità, ma le concede due mesi di inadempienza. Lisa vende come può i mobili, il letto matrimoniale, oggetti accumulati in otto anni di matrimonio, biancheria, abiti di Ernesto e suoi e si garantisce per un paio di mesi un tetto, in un albergo due stelle. Smagrisce, non ha parenti che l’aiutino, impara giorno dopo giorno a convivere con la povertà. Esauriti i pochi soldi rimediati con la vendita dei beni di modesto valore, si assicura un posto nell’ospizio che accoglie i senza tetto. Lì conosce Eleonora, una nobile decaduta al punto di chiedere l’elemosina sui gradini della chiesa del Gesù e Alberto, ridotto in miseria dal gioco, Gilberto, per anni assoldato come comparsa per i film girati a Napoli, ma solo fino a quando la vecchiaia si è presentata con acciacchi debilitanti e Clementina, ripudiata dalla famiglia per aver messo al mondo una bambina con un delinquente che ha abbandonato madre e figlia. Da questi compagni in miseria Lisa impara che per un pasto caldo ci si mette in fila a mezzogiorno in punto nel locale mensa della Caritas e che chiedendo di bar in bar si può bere un caffè “pagato”.
A sera, distesa sul materasso che preme sulla schiena con le molle sporgenti, Lisa non piange neppure più, come le prime volte in ospizio. Ha finito per sopportare il respiro greve dei letti accanto, le frasi incoerenti dei vicini, biascicate nel sonno, i passi dei ritardatari trascinati stancamente. Ora il pensiero che ricorre a occhi chiusi è di una fine anticipata della vita, del suicidio liberatorio, ma come una condanna senza attenuanti ha la meglio la consapevolezza di non sapersi dare la morte.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 24 settembre 2017
Caschi gialli
di Luciano Scateni
Devo questo racconto a Salvatore, alla sua statura di operaio come forse non ce ne sono più. Lo devo alle migliaia di tute blu, di caschi gialli o di qualunque altro colore che hanno scritto la storia del movimento di lotta per i diritti dei lavoratori. Lo devo per il contributo decisivo agli anni della mia formazione politica e anche più adesso, come un manifesto antagonista della deriva di una sinistra in lotta fratricida, della sua “corrente” che non fa mistero dell’obiettivo di offuscare la memoria dei tanti Salvatore della Napoli operaia.
 Non è accertato biologicamente, ma è verosimile che in qualche angolo remoto del cervello la natura abbia installato un micro timer. Nella notte, alle tre e un minuto, o meno un minuto, aziona la sveglia con trilli da allerta per muscoli e sangue. Lo ha fatto per dieci lunghi anni e Salvatore se n’è assuefatto, ha finito per non imprecare contro i doveri di operaio addetto all’altoforno nel turno di notte. In punta di piedi, per non destare la moglie, Angela e Ciro, i “ragazzi” che hanno lasciato da qualche tempo l’adolescenza, esegue il rito spartano della colazione che a Napoli e anche per lui è tutto in un caffè nero della moka. Nella borsa a tracolla infila la colazione che Amalia ha preparato la sera prima e via. Quasi un chilometro per varcare il cancello aperto dell’Ilva e il buongiorno del magma rosso fuoco dell’altoforno. Lo affianca per la prima volta Emanuele (“ma chiamami Manuel”, gli ha detto stringendogli la mano). Il ragazzo ha compiuto da poco i diciotto anni. “Ora è così, ti assumono se maggiorenne”, è il pensiero che passa nella mente di Salvatore. Lui in fabbrica è entrato che aveva appena tredici anni e da quel giorno gli era passata accanto, estranea, la vita di ragazzo, senza lasciargli il tempo della scuola, del pallone nella squadra allievi di Bagnoli, degli amici, delle ragazze da corteggiare.
Non è accertato biologicamente, ma è verosimile che in qualche angolo remoto del cervello la natura abbia installato un micro timer. Nella notte, alle tre e un minuto, o meno un minuto, aziona la sveglia con trilli da allerta per muscoli e sangue. Lo ha fatto per dieci lunghi anni e Salvatore se n’è assuefatto, ha finito per non imprecare contro i doveri di operaio addetto all’altoforno nel turno di notte. In punta di piedi, per non destare la moglie, Angela e Ciro, i “ragazzi” che hanno lasciato da qualche tempo l’adolescenza, esegue il rito spartano della colazione che a Napoli e anche per lui è tutto in un caffè nero della moka. Nella borsa a tracolla infila la colazione che Amalia ha preparato la sera prima e via. Quasi un chilometro per varcare il cancello aperto dell’Ilva e il buongiorno del magma rosso fuoco dell’altoforno. Lo affianca per la prima volta Emanuele (“ma chiamami Manuel”, gli ha detto stringendogli la mano). Il ragazzo ha compiuto da poco i diciotto anni. “Ora è così, ti assumono se maggiorenne”, è il pensiero che passa nella mente di Salvatore. Lui in fabbrica è entrato che aveva appena tredici anni e da quel giorno gli era passata accanto, estranea, la vita di ragazzo, senza lasciargli il tempo della scuola, del pallone nella squadra allievi di Bagnoli, degli amici, delle ragazze da corteggiare.
La storia dell’acciaieria ha i natali all’esordio del 1900, quando la coscienza ecologica era categoria di pensiero pressoché inesistente e l’installazione lambiva il mare, determinante per il trasporto della produzione. I dintorni, l’insediamento urbano largamente destinato agli operai della fabbrica, sopportavano con rassegnazione propria di quel tempo le polveri sprigionate dalle ciminiere dell’Ilva, l’aria pesante che incombeva come una nuvola eternamente grigia.
Salvatore attraversa per esteso la vita dei “caschi gialli” e cresce in lui la consapevolezza di dover difendere la condizione di metalmeccanico dentro e fuori la fabbrica. Con riserbo, per scansare le conseguenze di ritorsioni, si iscrive alla Fiom e partecipa quasi clandestinamente alle assemblee che il sindacato convoca al di fuori della fabbrica nei locali del Cral, praticamente sull’arenile. L’azienda ha occhi e orecchie per quanto decide il sindacato e trova le contromisure. Operai e impiegati invogliati dall’offerta di piccoli privilegi, turni e mansioni meno onerosi, riferiscono ai dirigenti atteggiamenti e intenzioni dei leader sindacali, gli umori degli operai. Salvatore si confida con Amalia che da “brava cristiana” lo mette in guardia, convinta per eredità genetica che non bisogna “ribellarsi ai padroni”. “Non ci stai tu in fabbrica” replica il marito.
Non passerà mai di livello Salvatore. Lo stop è condiviso da uno staff di direzione al successivo e il fascicolo che lo riguarda, la decisione di diffidarne, di rendergli la vita difficile, lo accompagna in tutto il percorso di operaio.
Con tanti anni di fatica sulle spalle la salute comincia a dare segni preoccupanti di logoramento fisico e non solo. Ma c’è alternativa? Non c’è in una città che dimostra di non possedere la vocazione industriale e di non poter contare su una classe dirigente che ne comprenda l’importanza strategica. I caschi gialli assumono il ruolo di fondamentale presidio democratico di Napoli e sono in piazza ogni volta che si paventa una minaccia di derive reazionarie se la città rivendica diritti collettivi negati.
Nel 1943, quando l’occupazione nazista è vicina alla fine, il comando tedesco in fuga ordina di minare l’Ilva, di non lasciare in piedi neppure un mattone. A scongiurare il pericolo c’è il coraggio degli operai, che sfidano ritorsioni a costo della vita e salvano l’Ilva.
Quasi quarant’anni dopo la terra trema e Napoli deve fare i conti con danni, paura, sospensione della vita per affrontare le ferite che l’hanno martoriata. Il giorno successivo a quel 23 novembre dell’80 la città è in ginocchio, avvolta da un silenzio irreale. Scuole e uffici chiusi, quartieri a rischio rintanati in se stessi, fabbriche ferme. Salvatore, da qualche tempo responsabile del consiglio di fabbrica, è al suo posto all’altoforno, come in ogni giorno e con lui tutti gli addetti alla produzione. I media la definiscono “iniezione di fiducia nel futuro”, gesto coraggioso per esorcizzare il pessimismo della città già provata da anni di crisi. Nella cartellina, chiusa nell’armadietto dello spogliatoio, Salvatore ha collezionato tre lettere di biasimo della direzione aziendale, pretestuose nella sostanza delle contestazioni, evidenti intimidazioni per contrastare il suo battagliero attivismo sindacale.
Nell’area, per genesi spontanea e auto incentivi all’aggregazione, prende consistenza il nucleo industriale. Olivetti, Pirelli, Sofer, Cementir, Eternit e altre realtà produttive a ovest di Napoli; oleodotti, raffinerie, industrie chimiche (Snia Viscosa) nell’area orientale, sono sostanzialmente il nucleo attivo della classe operaia napoletana. Stritolato dalla crisi, incapace di sostenere la competitività di mercato e probabilmente boicottato da orientamenti politici ostili alla forza d’urto delle fabbriche – dove la sinistra ha consistenza significativa – il comparto industriale è destinato però a sparire, a destabilizzare gli equilibri di un’economia che i geografi delle grandi città giudicano sana se dotata di promiscuità tra industria, servizi, turismo. Salvatore ne ha consapevolezza e promuove iniziative per far fronte al colpo mortale che incombe sulla realtà sociale e politica della classe operaia.
L’ineluttabile avviene e la desertificazione smantella l’intero nucleo produttivo di Bagnoli, delle aree collegate. Passa inosservata l’incoerenza del gruppo Finsider che investe 1.500 miliardi per un nuovo treno di laminazione, tecnologicamente all’avanguardia. Non molto tempo dopo aver ridotto la produzione e aver dismesso l’area a caldo, decreta la fine dell’Ilva. E’ il 1992. Salvatore rimane quasi da solo a contestare la chiusura imposta senza la contrattazione di contropartite in termini di occupazione. Contesta anche il suo sindacato. “Napoli non ha più classe operaia” dà senso alla sua protesta ma la condanna finisce nel nulla, inascoltata. Gran parte degli operai finisce per accontentarsi della Cassa Integrazione Speciale e Salvatore come da copione, non è tra i pochi superstiti tenuti al lavoro per le operazioni di demolizione. Tornerà dove quasi tutto è stato raso al suolo solo nel giorno, enfatizzato dai media, in cui l’azienda fa implodere una delle ciminiere. Indosso, Salvatore ha il giubbotto con la scritta Italsider sbiadita dall’usura. Quando la torre filiforme va giù tra scatti di fotoreporter e riprese televisive, il sax di Daniele Sepe esegue con andamento struggente l’Internazionale.
Non sono più sonno le ore della notte di Salvatore. Durano, inquiete, fino alle tre, minuto più, minuto meno. Via dal letto, abituale cautela, attenzione ai rumori. Sul tavolo della cucina non c’è il pranzo da portare in fabbrica, fuori nessuno, tanto meno operai in cammino per il lavoro nel turno di notte. Non rimane che rientrare, controvoglia. Da quando è in Cassa Integrazione l’anomala presenza in casa ha dato origine a tensioni prima sconosciute, a incomprensioni, liti nervose, forme di depressione contagiose, incompatibilità. Lo stress da esclusione dal lavoro accelera i segni dell’invecchiamento. Salvatore percorre l’intero chilometro del pontile artificiale che s’inoltra nel mare di Bagnoli. Seduto in terra, ha tra le mani il “Manifesto”. E’ di qualche giorno prima. Il titolo dell’editoriale: “La classe operaia che non va in paradiso”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 27 agosto 2017 – Domenica 3 settembre –
Domenica 10 settembre e Domenica 17 settembre
IO COMUNISTA
di LUCIANO SCATENI
prima parte
Le pagine di “Io comunista” sono datate. Pensate e scritte nel lontano 1990, quando l’involuzione del Pci era pronosticata da pochi, avvertita con forte e motivato timore di anticipare la progressiva perdita della sua storica identità e i fondamentali del comunismo. Riproporre le riflessioni di quasi trent’anni fa in pieno caos della sinistra, divisa e in stato di confusione politica crescente, mi sembra un contributo, per quanto modesto, all’auspicabile rinsavimento delle fazioni del Pd che si contrappongono con animosità e motivazioni improprie, per giochi di potere personali, estranei alle emergenze del Paese e non meno alla storia della sinistra.
Come dicono gli storici correva l’anno 1990 e questo “Io comunista” non ebbe alcun successo tra i compagni “organici”, di quelli proiettati verso gli inediti lidi del migliorismo che avrebbe pescato nella sua rete anime desolate, vedove dell’appartenenza alla prima Repubblica. Non immaginavo di aver messo a fuoco con tanto anticipo quanto sarebbe accaduto di lì al renzismo, per sintesi indicato nel progetto di Partito della Nazione che per il momento accoglie, in quel che resta della sinistra storica, legioni un tempo osteggiate perché agli antipodi e dunque alfaniani, vediniani e pecore smarrite di un Parlamento che assiste impavido a trecento e più “onorevoli” eletti con il partito X e approdati alla compagine ’Y. Di qui l’idea di riproporre le riflessioni generate nel ’90 dalla delusione per i colpi demolitori agli ideali del comunismo.
Introduzione di Giuseppe Galasso
Favola, metafora, apologo, satira quella di Luciano Scateni? Forse. Sicuramente il frutto di un piacere nativo di scrivere e raccontare. Ma non é detto che questo piacere poi non abbia il suo costrutto, il suo senso. Nel nostro caso questo senso si può cogliere appieno specialmente nella prima parte del racconto di Scateni. L’ambiente é quello napoletano, ma non si fa fatica a scorgere quanto le stesse cose potrebbero essere dette, su uno sfondo debitamente mutato, per altri ambienti. E si potrebbe sintetizzare nella vicenda “reclutamento spontaneo del giovane comunista a scuola”: un “classico” dagli anni ’50 agli anni ’70, poi caduto inforte desuetudine. Ma anche la seconda, e un po’ surrealistica parte del racconto ha il suo senso. Il mutismo patologico é chiaramente una evasione paradossale dal conformismo e dalla sua routine. Quasi a dire: in “quel” sistema, nel sistema che é “quel” partito, o si sta tutto dentro e tutto fuori, ma talmente
fuori che è come se ci si trasferisse su un’astronave in un altro mondo o stadio. Un po’ eccessivo? Può darsi, né pare che Scateni questa sensazione di eccesso voglia evitare di darla. A lui piaceva di scrivere, e scrivere così. Che, insieme, dia qualcosa anche a noi, tanto meglio. E qualcosa, infatti, anche in questo racconto tanto sui generis innegabilmente ci ha dato.
***
Premessa
Spirano forti venti di trasformazione. Tanto forti da scollare il rosso dalle bandiere e mandarlo su, nel cielo, a perdersi tra le nuvole. “Ineluttabile” dice il PCI di Occhetto.
Mettiamo sia cosí. Ma i modi e le parole della politica, per questo si ingarbugliano e si arrovellano ancor più nelle maglie dei “bla” e poi “bla”.
Sono turbolenze, quando ci vorrebbe un sol soffio di tramontana che disperda il superfluo, l’inutile, il dannoso, l’ovvio l’ermetico, fino a scarnificare i progetti: soggetto, predicato verbale, complemento oggetto.
So bene che il paradosso di “Io, comunista” indurrà un gran sfregamento di mani degli anticomunisti militanti o simpatizzanti che il bestiario dello storico “Reader’s Digest” idealmente associava, sfumando le differenze tra plateale e occulto, rabbioso o venefico.
Raccomando loro di smetterla. Nelle rispettive case, altro che “bla-bla”.
“Io, comunista”, lo dico ai signori della corruzione e del malgoverno, (e con la mediazione del paradosso, ai comunisti) è’ ancora un gesto mentale di amore per idee e ideali investiti dal monsone maligno dell’omologazione a ideuzze e “concretezze” di intenti a cui proprio non mi va di aderire.
***
Bravo per chi? Il quartiere medio borghese voleva lui perché i suoi segni blu, il non familiarizzare con i discenti e principalmente il suo riferirsi a principi di sana conservazione, corrispondevano alle aspettative del ceto predominante, commercianti e impiegati cioè, con ambizione di miglioramento sociale per i pargoli.
Essendo basso e per difetto rispetto alla media meridionale, lui usava portare il mento in su, unendo le mani dietro la schiena per darsi slancio e dondolava tra punte e tacchi delle scarpe con rialzo sfruttando il margine positivo del movimento, insomma la fase ascendente, per restarvi quanto lo consentiva il tono muscolare dei polpacci, in conseguenza di ciò più sviluppati di bi e tricipiti.
Mencarelli si chiamava e i genitori, supponendo che non sarebbe divenuto un gigante, avevano previsto anche il vezzo d’apparire imponente e gli avevano imposto il nome Massimo, su cui gli alunni meno soggiogati dal suo autoritarismo avevano intessuto lazzi e ironie.
Era pedante la sua professionalità: di Manzoni soleva chiedere vita, morte e miracoli, in una sorta di terzo grado che non lasciava scampo all’interrogato e neppure il tempo per riprender fiato, lena mnemonica.
Certi sprazzi di suo divertimento, ma truce, ingrifato, consistevano nel preparare a sera le insidie da proporre l’indomani, andando a spulciare nella grammatica latina perverse eccezioni su cui far cadere l’allievo con grande sollazzo.
Aveva però patito l’effetto boomerang di una delle facezie preferite, riproposta il primo giorno di lezione agli alunni ereditati dal ginnasio, anno dopo anno. “Bene, bene – esordiva immancabilmente – vediamo un po’ il vostro livello di latinisti. Scrivete: I vitelli dei romani sono belli. È una frase semplice, da tradurre d’acchito. Vediamo chi è il più veloce”.
Specialmente i “secchioni” erano davvero contenti di consegnare il foglio rapidamente. Che diavolo, tutta qui la fama di cerbero del professor Mencarelli? “Vitelli romanorum sunt belli”ed era una corsa alla scrivania con l’aria da saccenti.
“Ma bravi, che dico, bravissimi. Tutti soci onorari dell’asineria… Nessuno che abbia usato il cervello per intuire che la frase era latina, che andava tradotta in italiano e non il contrario”.
Con il suo passo ondulante, il professore raggiungeva allora la lavagna e con grafia da amanuense, dopo aver diviso in due lo spazio disponibile, scriveva da un lato “I vitelli dei romani sono belli”e dall’altro “Va, o vitello del dio romano, al suono della guerra” .
Piú d’un alunno, tra l’esterrefatto e l’indignato, ha potuto cogliere sul viso quadrato di Mencarelli un’espressione di sarcastico disgusto.
L’imprevisto, nella persona di un tale De Filippis era però in agguato per guastare la festa del prof, pronto a mortificare ancora la classe all’inizio di una nuova stagione scolastica.
L’alunno, terzo figlio di una famiglia di umanisti, era stato preceduto nella classe di Mencarelli da un fratello maggiore che raccontando in casa della frase truccata gliela aveva ficcata nella memoria.
“È vecchia, professore, così lo aveva apostrofato: “Va, o vitello del dio romano, al suono della guerra”.
Il livore di Mencarelli non avrebbe piú risparmiato l’incauto contestatore.
Ero in quella sezione “A” svogliatamente, esausto per le tre classi medie incolori di una vecchia insegnante tutta Dio e Patria e le due ginnasiali afflitte da una megera dai capelli ritti in testa, zitella per indisponibilità dell’altro sesso e perciò furente contro ogni storia o storiella d’amore che le capitasse di individuare.
Figurarsi quel mio bacio, rubato a una ragazzina della “3a G” nel corridoio del secondo piano: “Sei sospeso. Cinque giorni a casa – è stata la sentenza – “e torna accompagnato dai tuoi genitori.”
Non fu l’unico incidente di percorso con l’isterica single, grassa fuori misura per un ingozzarsi continuo a compensazione di deficit d’affetto.
Ero una star a quel tempo, in quanto leader della squadra di basket vincitrice in due contigue edizioni del torneo studentesco che accendeva entusiasmi di bandiera quasi quanto le evoluzioni di Amadei, centravanti romano del Napoli.
Godevo perciò di non pochi privilegi e in primo luogo dell’interessata complicità del professore di ginnastica, a sua volta gratificato dai successi della squadra di pallacanestro.
Mi sottraeva a ore e ore di lezione, invocando l’imminenza di incontri decisivi per giustificare allenamenti singoli e collettivi.
Antisportiva per incrollabile convinzione, la despota dai capelli ostili a pettine e spazzola mandava giù il rospo e meditava vendetta.
Non so come abbia convinto una madre affatto liberale e un padre ex salesiano, a tollerare l’esodo da questo liceo governato da un preside iperteso e fascistoide che piantato sul portone d’ingresso incuteva terrore agli alunni a ogni accenno di sciopero per “Trieste italiana” e altri patriottici pretesti di quel tempo politicamente scialbo.
Il mio nuovo percorso di apprendimento incappa in un supplente che non mostra alcuna coerenza con la “2a B” del liceo G.B. Vico, mal sopportato per una sua contiguità con la didattica estranea alla realtà sociale.
Un uomo-rabbinico, con tutto il rispetto per i ministri del culto ebraici; un tipo aguzzo, tutto angoli, che una barba nera e rettangolare ascetizza e falsa l’indole di mezzemaniche dell’insegnamento.
Lo guardo stranito. Va blaterando “braccia in quarta” il supplentucolo, con la sua vocetta che si spezza di continuo in note false, come graffiate da carta vetro.
Vorrebbe che osservassimo nei banchi una posizione imbalsamata, con le braccia incrociate sul petto, e si ritrova a fronteggiare un concerto di “uhuuuh” concluso con una pernacchia modulata, di misteriosa provenienza solo per l’incauto docente ante litteram, ma identificata dall’intera classe nel fondo dell’aula, lato destro, quello presidiato da Pignataro, un bisonte di uno e ottanta che la “2a B” esibisce all’intero liceo quando c’è da far valere le proprie ragioni.
Deve tornar d’urgenza il titolare, nonostante un cuore bisognoso di quiete.
*
È la scoperta infinita di mille perché e principalmente del perché la cultura è ben altro che mera conoscenza. Messieur le generale Lapalisse direbbe “che scoperta”, ma per uno come me, che si è sorbito un decennio di cazzate sui sublimi piaceri del sapere fine a se stesso, è rivoluzionario sapere che Platone o Kant, le Catilinarie, Dante Alighieri, sono mediatori del confronto tra persone e eventi, idee e società con tutti i suoi dintorni.
Mi schiero e accade dopo una immensa lezione di Vincenzo Mainieri.
Scelgo la giustizia sociale, la povertà se è guerra ai ricchi, ricchi per prepotenza e violenze sui poveri, mi tuffo sulla libertà di pensiero, mi unisco in matrimonio con gli ideali di solidarietà a vantaggio dei popoli del mondo colonizzati e oppressi.
Scopro che la politica è in teoria un nobile esercizio dialettico tra forze contrapposte ma che i politici ne offrono un’interpretazione deforme, sbilenca da tutti i lati perché tangente ai loro interessi personali o di fazione, di corrente.
Mille lampi di nuova intelligenza si accendono in due ore di un dialogo fitto attorno ai percorsi che divergono dai “Promessi Sposi” con straordinarie invasioni in mille storie dell’uomo, per rientrarvi attraverso vie fascinose e non solo letterarie.
Divento comunista senza aver coscienza marxista e comincio a comprare l’Unità quasi clandestinamente, come un tempo si prendevano in edicola le prime riviste di nudi importate dalla liberale Svezia.
Metto piede nella sezione “Lenin” del partito, che sa di circolo dopolavoristico.
Vecchi compagni, anime storiche della lotta partigiana e di opposizione alle feroci repressioni in fabbrica, discutono di Togliatti come di un fratello mitico, infallibile.
Mi impressiona la fede nell’uomo e forse ne provo invidia, anzi disagio. Rifletto.
Ma come, ho abiurato il cattolicesimo per questo e i miei anni di ragazzino figlio di credenti, le tormentose obnubilazioni di pretonzoli malati di insana perversione da astinenza sessuale non meno che da eccessi di masturbazione: tutto disconosciuto per sottrarmi a un “devi crederci perché è cosi, altrimenti che fede è la tua…”.
Non mi sono mai liberato di questa ostinata insofferenza per i dogmi, ma il fulmine sulla strada del comunismo mi ha folgorato ben bene e così compio in scioltezza, a larghe falcate, il cammino dell’adesione organica al Partito, sempre un gradino più giù di compagni organicissimi, di quelli che escono all’alba per studiare l’Unità e aprir bocca senza fallo e di quelli che “Rinascita” possono recitarla a memoria; di quelli che fino alla soglia della maturità psicofisica ho fronteggiato con la bocca spalancata, annichilito dalla tempestività di citazione dei passi marxiani; di quelli che all’apparir di qualche brizzolo sulla mia tempia ho finalmente classificato come “il bravo comunista d’apparato”, tutto casa e PCI, che parla come il segretario nazionale o in subordine come il responsabile provinciale; come colui che di urbanistica può dar lezione a Kenzo Tange e di prevenzione sanitaria a Sabin perché i comunisti sanno… di tutto… di piú; come coloro che predicano meglio di un papa e razzolano peggio di Belzebú; come gli intercambiabili, che se il Partito li chiama saltellano dal sindacato bancari alla CGIL edili, al centro stampa e propaganda, ai senzatetto; infine come coloro che se ti viene un lampo di creatività per una battutaccia azzeccata sull’onorevole Pinco Pallino della DC ti fulminano d’immenso sapere strategico perché “…non hai capito che l’alleanza… si fa con lui o non si fa”.
Va bene, sono in prima fila e perdo l’appetito per far grande la giovane FGCI scoprendo con anni luce di ritardo che essa non è giovane ma vecchissima e illuminata di sapere politico principalmente dai veterani che, a un passo dall’ingresso nel mondo dei grandi, indossano elmetto e tute d’amianto per spegnere gli incendi dei mocciosi ancorché pretendano autonomia, libertà di iniziativa e di critica.
Domenica 3 settembre 2017 – seconda puntata
“Io comunista”, seconda puntata di un lungo racconto pensato e pubblicato nel lontano ’90 ma in piena sintonia con gli avvenimenti di questa stagione di eclissi degli ideali della sinistra storica: una dolente premonizione, evidentemente inascoltata.
Sono cooptato, è la prima volta e ne vado fiero. Quanti sono i fortunati a cui è concesso di raccontare agli amici “sai, mi cooptano” che suscita l’effetto collaterale di un doloroso travaso di bile.
Chi mi chiama di qua e chi mi vuole di là: il top dell’impegno di militante con la “M” maiuscola lo sfioro saranno due anni, due e mezzo dopo la cooptazione.
Nel volgere di una giornata di maggio, beneficiata dall’ora solare, sono impegnato su tre piani della federazione, voglio dire su tre piani diversi del palazzo e su tre piani di discussione. Mi occupo di nettezza urbana al pianterreno, di scuola all’ammezzato e di enti locali al primo piano.
Nel mezzo della mattinata lascio il triplice tema in sospeso, emulo Karpov in gara scacchistica simultanea e mi fiondo al gruppo regionale dove il compagno capogruppo mi comunica, non senza moti di commozionemarxista, che sarò il numero 27 nella lista PCI per le prossime consultazioni amministrative.
L’apres-midi è fitto di comunismo fenomenico, ovvero miracoloso, essendo che se trinitizza i compagni, me mi quaternizza con un fitto cartellone di presenze contemporanee al “federale”, salone underground della federazione, alla sala “Lux” di Volla dove sono relatore di “Abbiamo mani pulite, chi altri?” e a due code preserali di riunioni di caseggiato.
Nessuno mi può fermare, nemmeno la mia mamma che, all’annuncio “Vado a Roma, mammà”, zittisce il babbo ex salesiano per evocare il fantasma di una nonna chiromante.
“Quando sei nato, dice la mia emozionata genitrice, la nonna ti ha preso fra le braccia e sollevando fiera il bel capo canuto ha predetto: questo marmocchio vestirà di rosso. Intendeva il rosso cardinalizio, ma che fa, sempre di rosso si tinge il tuo futuro. Pregherò la Madonna delle Grazie perché ti conduca lontano…”.
“Mamma, ho replicato asciugandole una lacrima sul viso, che fai, mischi il sacro con il profano?”
Sono andato.
I compagni scoprono che io e l’italiano non ci azzuffiamo sul ring e che il Segretario ha qualche inflessione di troppo nel suo patrimonio oratorio, qualche zoppicatura dialettal-sintattica negli scritti.
Sicché eccomi ombra e mentore del number one e nei ritagli di tempo trascrittore di ogni pensiero di onorevoli compagni della Camera, mediatore tra l’ingegno politico della Direzione e i mass media, verbalizzante di riunioni e perfino consulente dell’immagine radio-televisiva dei leader scelti in rappresentanza di falce e martello per tribune politiche e convegni, confronti di piazza.
Roma, cuore e cervello del PCI. Perde in sei mesi l’aura di magia centralista che mi si era piantata nella testa in otto anni di militanza periferica.
Comizi, interviste, incontri bi e trilaterali, lunghe confessioni a tu per tu con il Segretario, nella sua tana di Botteghe Oscure e riunioni plenarie, articoli, dossier e slogan manifestaioli, risoluzioni, documenti, invadono la mia vita di relazione nel corso di giornate che sai quando iniziano, mai quando finiranno.
Affollano non meno il mio privato e cioè notti sempre più brevi, praticamente insonni, popolate di bla e poi bla e ancora bla. Mi saturo.
Ne sono invaso come una damigiana da 25 litri in cui se ne vogliano ficcare 26, o come si esauriscono le chances di ricevere informazioni dal personal computer a cui si chiede che immagazzini dati come fosse il cervellone del Bouburg.
Sospetto di esser prossimo al tilt un mattino oppresso da afa appiccicosa, nel metrò.
Il vagone è tappezzato di cartelli e locandine pubblicitarie che dietro il traslucido delle protezioni in plastica promettono di parlare in cinese dopo tre mesi di corso con docenti di madre lingua e invitano a provare il collante “Non mi stacco più”, particolarmente utile a signore e signori in possesso di dentiera. E’ che leggo ben altro in quei poster promozionali.
Per esempio: “…Come appare sulla Voce Repubblicana, il senatore Giovanni Spadolini afferma che le posizioni del segretario comunista evidenziano i ritardi del suo partito in tema di cultura industriale che, nel sistema europeo di ispirazione occidentale…”.
Oppure : “I comunisti, è l’opinione di Forlani riportata dal Corriere della Sera, sono da tempo a un passo dal bivio che conduce da un lato alle libertà democratiche di cui la DC è garante da oltre quarant’anni e dall’altro ai regimi totalitari da cui il PCI non ha mai preso le distanze. È questo il bivio che non sembrano voler superare i comunisti, perché la verità è che non saprebbero imboccare la via giusta…”.
Ma son matto ? Eh no, solo un po’ di stress… che sarà mai.
Distolgo lo sguardo dalle stramaledette locandine e mi applico all’osservazione di una mia dirimpettaia.
Bella femmina, niente da dire e solo dieci anni di troppo, ma d’altra parte non dovrò mica fidanzarmici.
Bello l’ovale e affascinante questa sua aria da gran donna, non fosse che potrebbe mascherare una qualche forma di alterigia.
Son matto. Scommetterei uno stipendio che è proprio Nilde, ma si, Nilde Iotti… La lotti sul metrò? E con lei, per caso c’è Pajetta?
Son pronto per la neurodeliri, ecco la verità e certo non mi salva lo stop del treno alla fermata in piazza di Spagna, dove m’intruppo nel flusso di viaggiatori in uscita, in un loro brusio indistinto dentro cui son certo di distinguere un “pci…pci-pci” che mi paralizza alla base della scala mobile, a guardare allucinato i gradini semoventi che vanno su uno dopo l’altro, ciascuno con una parola stampigliata sul lato visibile.
Prima che scompaia una scritta, sopravanzata da quella dello scalino successivo, riesco a leggere “compagni”… “abbiamo”… “davanti” … “a noi”… “l’impegno”… “di definire”… “la strategia”… “complessiva”… “di un nuovo”… “corso”…
Dovrei introdurre il compagno segretario in piazza San Giovanni, per il comizio d’apertura della campagna elettorale, Dovrei “scaldare” le folle con slogan microfonici a molti decibel, per gratificazione le delegazioni storiche in arrivo da est e da occidente, da nord e da mezzogiorno, del tipo “entrano in piazza… in questo momento…i caschi gialli della Falck…salutiamo i compagni della Pirelli…”.
Mandano in campo il tredicesimo invece, l’uomo panchina, il vice urlatore, e m’ingozzano di Ferrarelle.
“… Fa sempre bene un bicchiere d’acqua e una pezza in fronte”, mi sento dire da Nando l’infermiere e intravedo il compagno Segretario, che è cupo, incazzato, formalmente sul comprensivo-interdetto.
Provo a leggere sulle sue labbra carismatiche che cosa borbotti e mi sembra che sillabi “ma tu vedi ‘sto figlio di puttana, proprio mò doveva da star male”.
Fondo, faccio tilt, mi schianto, entro in depressione e ne esco di giovedì, a sera, mentre infilo un chiavino lungo dieci centimetri nella speciale serratura di cui la sora Cecilia ha dotato la porta d’ingresso della magione di due camere, cucinotto e bagno che ho preso in affitto per il gran salto di categoria nel comunismo della capitale.
Mi salva la metafora.
Si apre cigolando la porta, perché ho trovato la “chiave” giusta e la mia testa s’illumina di verità, perché ora so. Di qui ai prossimi sei mesi, ma il fioretto è rinnovabile, non leggerò una riga di un bel niente di serioso, non ascolterò un bla bla, dovessi riempire le orecchie di idrofilo e non mi uscirà di gola un monosillabo, che dico, una vocale.
Sfioro l’orgasmo.
Ma pensa te l’effetto di questa sublime evanescenza sociale, relazionale, interpersonale erga omnes.
Oddio, l’idea non splende di originalità. Fu Eduardo a stupire i mille del san Ferdinando con il surreale di un suo personaggio contestatore che, negandosi a verbi e sostantivi, parlava, si fa per dire, il linguaggio di tracchi e botte a muro, bengala e razzetti.
Ho dalla mia l’inedito di un silenzio totale e il corollario non marginale della finta sordità.
Mi sistemo sulla mia isola acustico-verbale con ogni comodità.
Accanto al letto Ikes, un sol blocco con comodini incorporati, mi doto di tutto il futile che riesco a mettere insieme grazie alla consulenza di Concetta, camerierina della sora Cecilia.
Torna dall’edicola con un pacco di Diabolik, Satanik e affiliati, sette versioni di quiz enigmistici, compresa la classica “Settimana”, detta “il divertimento più sano ed economico”, gli ultimi tre tascabili rosa, serie Armony, un paio di porno news tipo Playboy e Oggi, Sorrisi e Canzoni, Cronaca, Taglia e cuci, Fai da te che fai per tre, I dieci piccoli firmato da Agata Christie.
Le voci corrono. Alla sora Rosa non par vero di poter raccontare all’intero condominio della mia follia.
“Non parla, avvocato, non sente, guarda le riviste con le femmine ignude, sorride come un fesso, povero signorino, gli mancano molte rotelle, me fa na pena…”
“Professò, l’avesse da vede, dà i nummeri, lui così serio, un communista, de quelli proprio rosci…”
Vera, Maglia e Punti, Fai da te che fai per tre, Agata Christie.
Le voci corrono. Alla sora Cecilia non par vero di poter raccontare all’intero palazzo e ai suoi ampi dintorni della mia pazzia.
“Non parla, avvocato, non sente, guarda le riviste con le donne ignude, sorride come un fesso, per niente povero signorino, gli ha dato di volta er cervello, me fa una pena…
… Professore l’avesse da vede, dà i nummeri, lui cosí serio, un communista de quelli proprio rosci”.
Domenica 10 settembre 2017 – terza puntata
Stretto nella morsa del comunistese, l’adepto in carriera Pci è preda di una forma ossessiva di immersione nel frenetico agitarsi del partito. Non regge allo stress che i mestieranti della politica assorbono per sospetta vocazione a trarne vantaggi in crescendo e sceglie il mutismo, l’assenza, il peggio della futilità che i bravi compagni condannano perché “non sta bene per un comunista”. La metafora del silenzio ha risvolti sorprendenti.
La notizia del mio mutismo vola lontano, almeno fino a Botteghe Oscure e laggiù a duecento chilometri di distanza dove la mia mamma trova modo di scoppiare in un pianto di nobile solidarietà “Figlio mio e che ti è successo…” mentre il genitore ha la sua grande occasione di rivincita e sbotta in un “Le vie del Signore sono ovviamente infinite. Ecco la sua giustizia, finalmente. Meglio un figlio scemo che ateo e comunista”.
Non c’è chi intuisca il risvolto metaforico della mia astrazione dal mondo.
Amici e compagni se ne sorprendono, questo sì e in bella progressione s’irritano, s’indignano.
Io son certo di riuscire a neutralizzare il crescendo d’intolleranza con l’aria da fesso contento che ho stampata in faccia.
Il postino busta mezza volta e se ne andrebbe com’è venuto se mio padre non utilizzasse il suo venticinque percento scarso di udito residuo per captare la scampanellata in extremis e urlare alla mamma “laaaaa pooooortaaaaa…”.
Il telegramma dice laconico “Vostro figlio rifiuta contatti chicchessia. Stop. Urge vostra presenza”. Dopo pianti e moccoli, papà e mammà decidono di marciare su Roma e me li ritrovo attorno alla stracomoda poltrona dove mi son bevuto tutta d’un fiato la prima story di “Intrepido”, lasciando invece a metà il dannatissimo cruciverba di Bartezzaghi che vuol sapere da me e da un altro milioncino di affezionati lettori il nome di un’isola polinesiana sconosciuto perfino all’atlante degli atlanti, il caro De Agostini. Le provano tutte. Ricordi struggenti e blandizie, cazziate del babbo e implorazioni della mamma, smorfie, tentativi di penetrare nei miei silenzi con l’inganno di barzellette sparate a mitraglia; sui carabinieri quelle di mia madre, del genere “È sozza ma siamo tra adulti” quelle di mio padre. Una è niente male.
[Don Luigi è uomo d’onore, boss di Forcella per legge tramandata verbalmente di padre in figlio e guappo old style con prole sanguinaria. Don Luigi ha per figlia Carmela. Bella, giovane e procace, la ragazza giace abitualmente sotto campane di vetro, ma eccezionalmente giace sotto Chicco de Benedictis, venticinque anni di vita al platino per ricchezze smisurate di papà Astolfo. Gira e rigira, la ragazza è incinta e don Luigi sbotta: “Figlia mia e che hai fatto… Mi hai disonorato, svergognata. I’ t’accido. E mò dimme chi è stato, che ‘o strafoco”. Ma la girl è figlia di cotale padre e tace. Don Luigi è in deliquio e si tappa in casa…”Pe’ sempe, nun iesco cchiù”. S’affaccia alla veranda del vico Zurlo, solo questo si concede, e nel vicolo vede entrare una Rolls che è un bastimento. Decapotabile, superaccessoriata. occhio e croce trecentocinquanta, quattrocento milioni, lustra. Ne discende Apollo, un Adone, un metro e ottantacinque di perfezione atletica sull’elegante, non più di venticinque anni, in grigio cachemire tagliato dal dio degli stilisti. Chicco è di fronte a Don Luigi e ostenta la calma dei forti di portafoglio. Chi sono ? De Benedictis, lieto. Son io…il padre. Anzi il futuro padre. – Manteniteme, sinnò m’’o magno. – Torni in sé, signore. Sono persona perbene, conosco i miei doveri. Ho tutto previsto. Dunque, nasce femmina? Un miliardo, una palazzo a via Petrarca, un motoscafo d’altura, una casa sulla Costa Smeralda. Nasce maschio? Due miliardi, due palazzi in via Petrarca, due barche a mare, due case sulla Costa Smeralda.
Il cuore di don Luigi fa un tuffo, anzi due, in un lago di zucchero e cannella, disponendosi a godere per la terza ipotesi di parto gemellare o, perché porre limiti al buon Dio, di tre, quattro nipotini. C’è una sola ipotesi sfortunata, conclude il nobile Chicco, remota ma non impossibile. La ragazza abortisce: amici come prima e ognuno per la sua via…
Lo scatto in avanti del boss mette Bolt tra i mediocri dilettanti dei cento metri olimpici e la performance atletica si conclude con le mani serrate attorno ai risvolti della irreprensibile giacca del de Benedectis:
_-Titò, qua amice e amice. Tuuu… tuuuuu… tu t’a chiave n’ata vota (in italiano, te la scopi di nuovo].
A ben vedere tradirei il divertimento. L’occhio ridacchia e il naso ha impercettibili fremiti da riso represso, ma per mia fortuna conservo l’aspetto generale di sordo, muto e tonto.
L’inclita compagnia che mi circonda d’amore è sicura che o non ho sentito, o non ho afferrato il bello della satira. Ciascuno dice la sua.
Presenzia anche la mia interdetta pupa e compagna ex femminista della serie “ma che bel percorso all’indietro a larghi passi di gambero”. Alla fine del consulto, l’unanimità.
Il giovane, cioè io, è carente di rotelle; si chiami dunque lo psichiatra, il migliore dice papà con uno slancio di grandeur inedito che mi commuove fino allo struggimento prima di sfociare nell’irritazione.
Mi ricordo delle mille lire che mi ha negato ghignando, il vecchio avaraccio, quando per dieci sigarette mi sarei venduto i due nonni e la zia Margherita, quella dei pizzicotti rifilati con le sue dita artiglianti giusto sulla porzione di guancia afflitta da un molare cariato.
Arriva l’aggiusta cervelli ed è di quelli paludati, socio di una dozzina di accademie psichia…qualcosa.
Credete, ce la mette tutta e infine la sua uscita dalla comune è dignitosa, nonostante la resa.
Stupisce la famiglia con citazioni di casi insolubili da Freud ai nostri giorni e butta lì una decina di astruserie tecnico-lessicali molto impressionanti.
Rifletto: questo è davvero matto.
I bla bla professionali di professor coso replicano nel loro genere il politichese dei politici, il sindacalese dei sindacalisti, il comunistese di compagne e compagni, figicini e aggregati, il ripetersi infinito di identiche intonazioni, sgorbi sintattici e pause, aggettivi, neologismi e punti di sospensione, picchi e ricadute di un frasario che satura il manuale del bravo marxista teso alla infallibilità del Segretario.
E voilà, eccolo qui il pronipotino di Gramsci, il numero uno della federazione romana.
È al mio capezzale dopo aver contato le ore della pazienza rivoluzionaria, per non incappare nella censura del comitato di controllo.
Anche il Moretti lascia. Il raddoppia l’ha tentato con scrupolo e buona volontà, ma ignaro delle mie nausee da iperdose di bla bla si è proprio sintonizzato sulle circonvoluzioni di pensiero da cui fuggo azzerando i sensi dell’udito e della fonazione.
Il mio caso sconfina dal perimetro dei due vani e accessori della sora Cecilia ed è lesto a fiutarlo la “Repubblica”.
Il suo inviato ha proprio l’aria da inviato, scarpe e calzini da inviato, l’occhio acuto del segugio che non molla a costo della vita, il microregistratore nella manica, le antenne frementi in fase di captazione.
È simpatico e irresistibile. Ha una voce che conquista, e… un’aria cosi perbene.
Lo dice mia madre, per assolversi della licenza concessa al signor giornalista di introdursi nel regno del silenzio, ovvero di comparire al mio cospetto.
Ci fronteggiamo per tredici lunghi minuti. Lui s’ingegna al meglio, mi stuzzica e solidarizza, provoca e comprende, spazia su orizzonti infiniti.
Si arrende infine e cerca altrove i materiali per il “pezzo”.
Se no il buon Eugenio chi lo sente: il megadirettore è segugio di razza, che non molla la presa per ventiquattro, trentasei, settantadue ore, irrispettoso del sonno altrui.
Quando il computer restituisce il foglio saturo di parole, allora sbotta in effusioni e generosità : “Bravo Ciangottini, vai a riposare. Sono le due di una notte, fino alle sette di domani mattina puoi rifarti di sonno e stress”.
Ciangottini si butta sulla mia girl e dal terzo grado sul “muto senza perché” ricava la certezza che il sottoscritto s’ingegna a indispettire il mondo per tener fuori il collo dalla merda. Pardon per la parola ma l’inviato, si sa, non adora conformarsi al perbenismo.
Quasi quasi, il Ciangottini porta a casa la bambolina del tiro a segno. È’ andato vicino al bersaglio e comunque butta giù le cinquanta righe che il capo ha davanti a sé, in vista di spedirle alla fotocomposizione:
Roma, 21 novembre.
“Non è un silenzio isterico. Questo giovane’uomo è senza dubbio responsabile di una scelta inconsueta, folle se vi pare e a patto che per pazzia s’intenda la tenace, incoercibile voglia o, lasciatemi dire, il coraggio di erigere una barriera fra sé e le convenzioni, la banalità, le noie mortali dell’omologazione collettiva a uno, cento stereotipi del linguaggio e dei comportamenti. Quest’uomo ha smesso di parlare e sembra non oda alcunché, ma mangia, beve, legge e non ha l’aria smarrita, l’occhio dell’ebete, l’espressione insignificante dello smemorato. Anzi, guarda con sussiego chi si attiva per scardinare il suo ermetismo e sembra divertirsi di cuore osservando come monta la mobilitazione attorno a una sua scelta di zittire i canali di comunicazione, decisione mal tollerata da parenti e amici. Sono venti giorni che ha smesso di parlare; è vero, non ha più messo piede nell’austero edificio che ospita la direzione del suo partito per il quale ha faticato a vario titolo fin da ragazzo; sembra schizoide la sua scelta di aggrapparsi al fumetto e di ammattire per anagrammi e sciarade, di divorare storie di regnanti e stelle del rock; ma è fuori di testa un giovane che ogni mattina sprizza energia spingendo a più non posso sui pedali della cyclette e che nel pomeriggio spende almeno un’ora nella scrupolosa pratica dello yoga? La verità è altrove e se ne ha prova osservando come attorno a lui ci si dia da fare per rimuovere il fastidio di una diversità che interferisce con le regole del gioco tutto conformità con il consueto, il previsto, l’abitudinario. Hanno provato in tanti a disinnescare la mina vagante della trasgressione. Il padre e la madre con litanie suadenti e bacchettate sulle dita, la sua giovane e belloccia compagna, con carota e bastone. Silenzio, poi silenzio, infine silenzio. Non si contano più i paladini della guarigione, aumentano i volontari della crociata per il ritorno della parola al ribelle.
Chi guiderà le legioni della guerra santa domani, e tra una settimana, un mese, quando il silenzio, siatene certi, diventerà questione nazionale?
Noi stessi non siamo esenti da questo pathos di religiosità del recupero; anche noi abbiamo cercato nel cappello a cilindro della prestidigitazione i trucchi e le macchinazioni mentali per infrangere il muro di solitudine fonica del comunista stanco.
Cediamo alla sua ferrea imperscrutabilità, a certi suoi ammiccamenti non verbali all’ironia che pochi colgono per sostanziale stupidità e che scoraggiano anche la nostra ambizione per lo scoop.
Credete, abbiamo la convinzione di essere di fronte a un fenomeno e affatto nel senso del mostro da esibire alle fiere di paese ma piuttosto nel significato di simpatica bizzarria.
Verrebbe voglia di spiare il “reprobo” nelle ore notturne e chissà che non ci sorprenderebbe con un robusto sfoggio di vocalismi a favore di celebri monologhi shakesperiani o di canticchiamenti a mezza voce di Who’s that girl, in omaggio ai melodiosi cinguettii di Madonna”.
Domenica 17 settembre 2017 – Io Comunista, ultima puntata
Propone un finale surrealista la metafora del silenzio e dell’estraneità al mondo inutilmente stressante della politica, distante anni luce dall’etica della missione a cui gentiluomini come Enrico De Nicola hanno dedicato passione, competenza e sobria dedizione. Di silenzio antagonista, in questo balordo 2017, l’Italia e non solo lei, avrebbe straordinariamente bisogno. Non è così e viaggiano, in un’aria mefitica, le parole dell’inconcludenza, a mascherare mediocrità e insipienza, interessi particolari che prevalgono sui bisogni collettivi.
La magione dove vegeto è stazione di pellegrinaggio. La sora Cecilia, padrona tuttofare. si eccita non poco per il solenne réndez-vous del sindaco con il ribelle, che sarei io.
Il primo cittadino ha fede nel carisma del ruolo e a sua volta entra in preorgasmo perché suppone di guadagnare consensi elettorali convincendomi a “fare il bravo”. Le prova tutte. Si appella al mio senso civico e alla coscienza di comunista.
“Pensi, un partito che non dà adito a scandali, mai”.
Mi offre contropartite democratiche e per esempio la soluzione immediata di un problema sociale, che so la rimozione puntuale dei rifiuti, cento case per cento famiglie di baraccati, in cambio di una sola frase.
Stento a interpretare la simulazione del mutismo da sfinge.
Avrei una voglia matta, di sbattergli sul muso una risata a pieni polmoni, come nel bel mezzo della puntata più esilarante di “Indietro tutta” della premiata band Arbore & Co., eppure mi astengo perché il meglio deve ancora arrivare e mi limito a un’occhiata di insolente superiorità.
Si inseguono le interrogazioni parlamentari e i vertici di partito, le consultazioni informali e ufficiali delle massime cariche dello Stato, la volontà dell’esecutivo, che si accorda per l’istituzione di una commissione d’inchiesta con licenza di azzerare l’anomalia del “giovanepoliticochehachiusoconilmondo”.
Roba da piatta routine, su cui svetta la geniale pensata che i radicali diffondono trenta secondi si, trenta no, dalla loro emittente radiofonica : “È un paradosso? Che si neutralizzi con un altro paradosso!”.
O con molti paradossi. Giacinto, detto Marco, assolda comici della serie “gli irresistibili”, e sono gag pirotecniche su partitocrazie a vario titolo, facezie e battutacce. Gigi e Andrea lasciano il campo in piena crisi depressiva e con il giuramento di tuffarsi su Pirandello, Bernard Shaw e Arthur Miller. Si ricorre alla miss “90-60-90”, maggioratissima che fa benissimo, fino alla resurrezione dei sensi.
Ella è attirata dalla sfida e mi propone un suggestivo show, intendo un’ esibizione corporale, da ancella dell’eros.
Le porgono fazzolettoni di Valentino e con essi la superdotata asciuga lacrime di lesa dignità, ricomponendosi nervosamente.
Non che sia insensibile al fascino della natura, ma cedere a una femmina procace neppure mi va e disilludo la truppa pannelliana.
Dicono che nel privato il Presidente si lasci andare a qualche trasgressione, che nella circostanza apostrofi i suoi fedelissimi con gergo trasteverino.
“Razza di incapaci, volete farlo parlare, questo rompiscatole, o pensate di gettare il Paese nel ridicolo? Chi sarà mai, il padre-terno, un marziano, la sfinge? Fate cantare il galletto da strapazzo o vi strapazzo io…”.
Il disagio istituzionale si trascina per giorni e settimane, mesi.
Mi sfiora la certezza che il pianeta non sia compatibile con nessuna diversità e perciò l’olocausto dei semiti e il martirio di Mandela, la marginalità del gay e l’emarginazione degli Cheyennes.
Per farla breve, salterò alcuni ripetitivi passaggi intermedi per ritrovarci d’un balzo al tavolo delle Nazioni Unite, in pieno faccia a faccia tra i padroni del mondo.
“È un diverso piú diverso di ogni diverso”, dice il compagno Gromiko e Kissinger: “Se non riuscissimo a piegare un testardo figlio di puttana pseudo anticonformista come potremo mai difenderci da masse di contestatori?”
Al mio letto, ormai non mi alzo più (a che pro?) si avvicendano il Segretario dell’ONU e Arafat, Margaret d’Inghilterra e Ranieri di Monaco, Francois Mitterand, Bettino e naturalmente Alessandro, il Natta.
Dico, sono commosso che diavolo, ma irremovibile.
La sorte mia si decide in campo neutro, in quel di Ginevra e il verdetto è “Deve sparire. Chi offre un’astronave da spedire nello spazio per l’eternità?”.
Si offrono gli yankees.
All’ora “x” del giorno “y”, il lancio a stelle e strisce, per il bene dell’umanità.
Replicano i sovietici “Non sia detto, a noi l’onore”.
Mi sequestrano notte tempo e per il mondo svanisco nel nulla, fornendo a CIA e KGB spazi inediti di fraternità nell’operazione che dividerà al cinquanta per cento oneri e meriti.
Mi sveglio sprofondato in una poltrona del jet militare in fase d’atterraggio sulla pista numero dodici dell’aeroporto moscovita, accanto al colonnello Podgorny, addetto
al “candidato per gli spazi infiniti”, cioè me. Mi sorride e mi blandiscono pure le compagne hostess, offrendomi caviale e vodka d’esportazione.
Mosca. Ho sognato di visitare la grande mamma russa più di quanto abbia desiderato Bò Derek e mi ci catapultano impacchettato per un viaggio senza ritorno.
Ridicolo, no? Beh, meno dell’imbalsamato primo ministro, che mi propina un discorsetto a base di pace e amicizia tra i popoli, anche più buffo nella traduzione simultanea della compagna Tatiana che dice amicissia e patze con comicissima serietà.
Non resisto e sbotto in una fragorosa risata con supplemento di saliva vaporizzata che finisce sulla guancia sinistra dell’impettito moscovita.
Mi agganciano al sedile dell’Ilyiuscin, offesi mortalmente.
Atterriamo con dolcezza orientale sulla pista dello scalo USA di Washington, dove è in attesa una limousine nera e lunga quanto un transatlantico, affollata di G-men con Borsalino a tesa morbida.
Andiamo verso il destino, ovvero verso la rampa di lancio e i miei angeli custodi sono solennemente compresi del ruolo di salvatori della Terra.
Sono anche nervosetti e gonfi di pistoloni a canna lunga.
Una nuova, titanica risata, prorompe nella Bentley di rappresentanza quando si manifestano contemporaneamente i tic dei miei truci accompagnatori.
L’uno porta continuamente la mano al naso e nascondendo maldestramente il gesto ficca due volte di seguito l’indice nella narice sinistra; l’altro solleva le spalle a ritmo di cha-cha-cha, come a dire “e che mi frega?”.
Ognuno dei due non sopporta il tic del vicino.
Il cancello della base ci inghiottisce e l’auto s’infila nelle visceri del bunker, in un dedalo di stupefacenti variazioni sul tema della tecnologia sofisticata.
580… 579… 578…
Il count-down è osservato da seriosi e scamiciati spazialisti che non mi degnano di un’occhiata.
Sono piuttosto incazzati sapendo che il loro gioiello di perfezione balistica si perderà in qualche buco nero del cosmo, ma le loro labbra scandiscono in silenzio i secondi.
“524… 523… 522”.
Mi imbacuccano in una tuta da volo tipo pubblicità Good Year e tocco vertici di sublime divertimento quando un occhialuto che tutti chiamano Angelo tenta di colmare in quarantacinque secondi le lacune di navigatore spaziale che mi ritrovo.
“You know ? Okey. And now…don’t pull this knob…”.
Non sono poche le mie carenze di seconda lingua, ma capisco che il solerte ingegnere mi va dicendo che cosa devo e non devo fare per un viaggio celestiale.
 L’effetto è irresistibile. Rido, rido a crepapelle, e ancora di piú quando Angelo si congestiona in un impeto di professionalità battendo i piedi sulla passerella metallica con le scarpe magnetiche, in una involontaria ma apprezzabile imitazione del tip-tap.
L’effetto è irresistibile. Rido, rido a crepapelle, e ancora di piú quando Angelo si congestiona in un impeto di professionalità battendo i piedi sulla passerella metallica con le scarpe magnetiche, in una involontaria ma apprezzabile imitazione del tip-tap.
Lacrimo e mi piegherei in due se l’involucro da cosmonauta in cui mi dibatto non impedisse qualunque movimento.
Gli scuotimenti del diaframma trasmettono potenza alle corde vocali e di per sé il casino della sonorità ridanciana sarebbe già tempestoso, ma diventa boato grazie all’amplificazione del microfono a cuffia incorporato nella tuta spaziale.
Cede per primo Dan, assistente al volo: Ah-ah… ahahahah… ah-ah e il contagio dilaga.
Ah-ah i tecnici su tutta la rampa e perfino l’ineffabile Angelo.
Ahahahah… ah-ah, i controllori nella stanza dei bottoni e il senatore Mc Neily, delegato del Presidente alla dispersione dell’incomodo (io).
Ahahahah il compagno Shernienko, inviato speciale del Cremlino.
Sistemarmi nella capsula è un’impresa, ma riesce, tra una sghignazzata e una convulsione.
Five… four… three… two… one: ZERO. Il conto alla rovescia è sovrastato da un’unica, cosmica risata.
La mia, ormai nella ionosfera.
Ridono stelle, pianeti e meteoriti, cherubini e demoni.
L’astronave va.
FINE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 20 agosto 2017
MANIFESTO PER UNA PACIFICA RIVOLUZIONE
di Vitaliano Della Sala
Un racconto nel racconto a dimensione colta, appassionata, lucida, storicamente attuale, benché firmato nel 2002. Don Vitaliano della Sala lo ha regalato con generosità al mio libro “Amore e/o Morte” La sua visione del mondo è senza mezze misure e ti chiede perentoria “da che parte stai?”. Gli schieramenti che Vitaliano mette l’uno contro l’altro senza alcun punto tangente sono ricchezza-povertà, violenza-pacifismo, liberismo-comunismo. La sua prefazione è un “manifesto” rivoluzionario. Anticipa il crac della sinistra che ha progressivamente eroso l’impianto degli ideali di giustizia sociale, della lotta di classe, di un futuro libero dalla discriminante che i poteri esercitano sul corpo indifeso delle marginalità. Ho condiviso a suo tempo ogni parola del “racconto” che segue e ancor più lo condivido in questa difficile stagione della sinistra smarrita. (Luciano Scateni)
Dom Helder Camara, vescovo brasiliano a cui non è mai stata risparmiata l’accusa di essere comunista, diceva: se dò da mangiare al povero mi dicono che sono un santo, se cerco di capire perché il povero non ha di che mangiare allora mi dicono che sono un comunista.
Oggi viene facilmente tacciato di comunismo chiunque pensa che la ricchezza non è casualmente distribuita e ritiene ingiusto l’ordine del nostro mondo che fa molti poveri e pochi ricchi.
E, sempre oggi, c’è chi farebbe carte false per non essere chiamato comunista e si affanna a gettare nella spazzatura non solo gli aspetti discutibili del proprio passato, ma anche le utopie, gli ideali, le lotte e le conquiste sociali per le quali altri hanno speso la vita. Molti fanno a gara nel prendere le distanze dal comunismo sostenendo, ad esempio, che non si concilia con la libertà e con il mercato, mentre il mercato sarebbe perfettamente conciliabile, secondo loro, con la libertà. E così, più prendono le distanze dal comunismo, più aderiscono all’ideologia del capitalismo. Tragicamente questo comporta che per non essere più comunisti bisogna far finta di non vedere che esistono mercati che fagocitano gli uomini per salvaguardare i profitti, che ci sono violazioni delle più elementari libertà; che masse di diseredati sono derubate del diritto ad una vita almeno non indecente: per non apparire comunisti bisogna negare, cioè, che esistono ingiustizie strutturali da sovvertire, sistemi di disuguaglianze da rovesciare.
Non credo che esistano soltanto le due categorie di comunismo e liberismo, quest’ultima vincente e l’altra di cui seppellire finanche i più miseri resti. Credo che tra di esse si insinuino, con la forza di cunei, le donne e gli uomini, il cui numero si conta in miliardi, che vivono ricacciati ai margini del sistema mondiale e a cui non è stata riservata alcuna possibilità di futuro. Tra liberisti ed ex comunisti convertiti di fresco al neoliberismo, queste donne e questi uomini sono la parte dalla quale e con la quale stare.
Infatti, ci sono dei momenti nella vita in cui le cose ci appaiono di una semplicità estrema, di una chiarezza senza alcuna traccia di ambiguità, momenti in cui diventa immediato sapere e decidere da che parte stare. Don Lorenzo Mi/ani, il priore di Barbina, mostrava ai suoi ragazzi una fotografia di un torturato e del suo carnefice e chiedeva loro, a bruciapelo, “tu da cheparte stai?’ I ragazzi rispondevano senza esitazione indicando il torturato. Non si domandavano neanche chi fosse la vittima e per quali ragioni venisse aggredita. Se era un buono perseguitato o un cattivo punito. Comprendevano che si trattava comunque di uno che stava subendo, che il potere non stava dalla parte sua, che si trattava, in quella situazione e in quel momento, del debole e della vittima. E bisogna sempre stare dalla parte di quello che “sta sotto”, e oggi sta “sotto” chi è vittima della globalizzazione dei mercati e della guerra, che della globalizzazione è il flutto velenoso.
Sulla globalizzazione sono state dette e scritte molte cose e con competenza. Un tema come questo, però, non può essere lasciato solo agli addetti ai lavori. Non bisogna lasciare che solo gli esperti o gli addetti del settore se ne occupino, lo comprendano, propongano strategie di lotta o possibili alternative. Qui si tratta, e per davvero, delle sorti del mondo, della sorte di miliardi di esseri umani. Una cosa troppo grande, troppo importante e troppo coinvolgente per non assumerla in prima persona. Questo non vuol dire che ognuno di noi deve diventare un esperto del problema o un addetto ai lavori. Vuol dire che di fronte a questo stato di cose ognuno è interpellato, è posto di fronte alla scelta di accettare o rifiutare. Non esistono, infatti, scelte neutre. O si è pro o si è contro. Le scelte che si compiono riguardano il concreto, il quotidiano, si può dire, delle nostre esistenze. Mai come oggi, la mondialità del fenomeno, le sue spaventosamente gigantesche proporzioni non devono farci sentire piccoli e impotenti anzi, proprio ora, esistono le concrete condizioni di possibilità perché le scelte e l’azione dei singoli, di miliardi di singoli, possano avere una loro efficacia. Anche scrivere racconti, d’amore e di sofferenza, di prevaricazioni, di solitudini, è un modo per dire che nessun sistema è perfetto, nessun gigante di bronzo è privo di giunture o di parti in argilla. Tra queste giunture, nei punti deboli del sistema bisogna infiltrarsi; mirando all’argilla è possibile colpire il gigante. La vecchia storia di Davide e Golia o è falsa oppure è vera, o insegna qualcosa o non insegna nulla.
La globalizzazione di marca liberista ha una fiducia idolatrica nel potere del mercato. Una fiducia irrazionale ed acritica, visto che il liberismo non ha risolto i problemi dell’umanità, visto che milioni di esseri umani muoiono ancora di fame, di malattie, sono destinati ad una sub vita fatta di analfabetismo, sfruttamento, stenti. Ma c’è un diverso modo di concepire il mondo, l’umanità, i suoi diritti, le sue aspirazioni. Non si può accettare che il sud del mondo diventi un grande bacino commerciale, che miliardi di esseri umani o si trasformano in consumatori oppure, semplicemente, non sono. Non si può accettare l’ideologia della forza, il dispiegamento della propria muscolatura economico-militare come mezzo per risolvere i conflitti, o meglio, perché sia chiaro a tutti chi è che comanda. Non si può accettare una politica internazionale senza scrupoli come quella condotta con Saddam Hussein in Iraq, l’UCK in Kosovo, i mujahi ddin e i talebani in Afghanistan. Come non si può che condannare risolutamente ogni atto di terrorismo, così non si può accettare che, ad esempio, a causa degli embarghi muoiano milioni di bambini, che si decida freddamente che una quota di fame nel mondo debba considerarsi fisiologica.
Purtroppo sembra essere diventato scontato che quando tutte le vie diplomatiche sono state percorse senza che sia stato raggiunto alcun risultato positivo, allora l’unico mezzo per fermare la violenza e il terrorismo è la guerra. Questo è lo sciocco punto di arrivo della nostra civilissima barbarie. Una conclusione che, mi auguro, potrà apparire inammissibile fra duecento anni così come lo è oggi la schiavitù che duecento anni fa era perfettamente legittima, contemplata dagli ordinamenti giuridici allora vigenti. Siamo ancora tanto incivili, tanto poco dirozzati da non capire che la guerra non può essere mezzo per raggiungere alcun fine. Per qualcuno era già chiaro più di duemila anni fa: “un eunuco che vuol deflorare una vergine, così è chi vuol rendere giustizia con la violenza” (Libro del Siracide, capitolo 20, versetto 4) sono parole tratte da un libro della Bibbia, precisamente dell’Antico Testamento. Continuano a tornarmi alla mente in questi tempi bui della vendetta e della forza esibita. La ritorsione americana contro l’orribile attacco terroristico alle torri gemelle dell’U settembre è paragonabile al tentativo dell’eunuco. Un tentativo vano, destinato inequivocabilmente al fallimento. Non ci riusciranno mai a fare giustizia ricorrendo alla violenza. Non potranno mai nascere frutti di bene dalla violenza. Perché la violenza chiama altra violenza, così come un abisso oscuro ne invoca un altro ancora più nero. La violenza è inarrestabile. Quando sembra essersi placata, in realtà sta soltanto covando sotto la cenere, per poi esplodere in nuovi incendi, per infiammare di vecchi odi nuovi nemici, o di nuove ragioni di odio i nemici di sempre.
È un copione che è stato già rappresentato: il nemico cambia volto e cambia nome ma non si trova pace. Perché la pace può essere frutto soltanto della giustizia. E il nostro non è un mondo giusto nel quale la parte fortunata, quella ricca, occidentale è un buon modello, un bell’esempio. E finché non c’è giustizia e non sí offre un modello di sviluppo possibile, a misura d’uomo, di ogni uomo, ci saranno sempre masse di esseri umani che cercheranno di combattere guerre “giuste” e guerre `sante”: le guerre dei poveri, che si consegneranno anima e corpo a chi, come Bin Laden o altri manovratori nascosti del terrorismo, sapranno cavalcare la tigre. E’ inutile illudersi: di questo passo la fine del pregiudizio eurocentrico, occidentale, sarà dolorosa e luttuosa. Dobbiamo smetterla di guardare le cose dal nostro punto di vista, di osservare e giudicare tutto il resto del mondo da questa piccola parte di mondo che è l’occidente privilegiato. Non ci sarà autentica soluzione del conflitto fino a quando non accetteremo di guardare le cose dal “rovescio della storia’, dalla parte di quelli che nascono nella parte sbagliata del mondo; fino a quando non cominceremo a prendere sul serio il fatto che tutti gli imperi prima o poi sono inesorabilmente crollati.
Riempie di un’incolmabile amarezza constatare che la pace potrebbe essere a portata di mano, se solo volessimo davvero agguantarla, bisogna invece prendere atto che essa è un traguardo di civiltà che siamo ancora ben lontani dall’avere raggiunto.
Occorre allora rifiutarsi di subire la logica dei mezzi e dei fini. Nessun fine può giustificare il ricorso a un mezzo come la guerra. Mezzo che, puntualmente anche stavolta, come sempre in passato, mancherà il suo fine. Almeno quello dichiarato, visto che quello implicito di ogni atto di guerra è mettere in chiaro ed in pratica chi è il più forte, chi comanda.
Per questo non bisogna assolutamente perdere la speranza in un mondo migliore e il coraggio e la caparbietà nel volerlo costruire, non bisogna “perdere la testa”. Già, la testa: la nostra arma nonviolenta con la quale possiamo difenderci dalla marea montante di stereotipi, preconcetti e pregiudizi, con la quale possiamo smontare i meccanismi delle propagande di regime, delle viziosità ideologiche, con la quale possiamo contrastare la violenza che si alimenta di istinti viscerali.
O forse non lo sappiamo ancora tutti, non lo sappiamo ancora bene, che il sonno della ragione, come l’assopirsi dell’umanità che è in noi, genera mostri?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 13 agosto 2017
Missili, ovvero, se questo è il mondo
di Luciano Scateni
PUNTATO AL CUORE DEL VILLAGGIO, IL MISSILE PENETRA NEL SOTTOTETTO, INESPLOSO.
NAHINA È TRA LE POCHE AFGANE CAPACI DI LEGGERE E TRADURRE L’INGLESE.
LA PARTE ANCORA VISIBILE DELL’ORDIGNO DICE “MUORI CANE DI UN MUSULMANO, È LA VENDETTA AMERICANA”. NAHINA ESCE DALLO CHOC E CON LA MATITA TIRA UN FREGO SULLA SCRITTA. LA MANO MALFERMA TRACCIA DUE PAROLE: «ALLAH È GRANDE”
Quanti musulmani tra i seimila delle Torri?
graveolente: odore di morte intorno a ground zero
monoteismo: USA, unico, immenso popolo scelto da Dio
vero-falso: arriva dal cielo, gioiello della tecnologia bellica, tele diretto. Corre dritto come un fuso sull’ospedale di Kabul. Uccide chi si confronta già di suo con la morte. “Non è vero” farfuglia radio Rangers. Poi: “Forse sì”
***
In tasca una piccola manciata di puls, rigirata tra le dita, mette ansia nella testa malata di Rajpugy. Anche a volerli spendere, dove e quando: lo sguardo smarrito vaga in ogni direzione senza trovare un filo di speranza nel futuro. L’Altopiano iranico propone paesaggi identici ai quattro punti cardinali e incute paura, con i suoi picchi sassosi e i sentieri sconnessi che li avvolgono in spirali infinite.
“Solo Allah può sottrarci alla morte”. Kaleb ha pietà per sé e il volto della sua donna, scavato dalla fame e dalla fatica, scrutato di notte, quando cerca scampo al gelo stringendosi al suo petto, finalmente senza il pesante velo che di giorno imprigiona il caldo soffocante e accresce la pena per un disperato viaggio delle speranza. Dà pena la fragilità di Mohammed. Ha solo sette anni, ma deve cavarsela da solo lungo i ripidi tornanti che s’inerpicano fino alle vette irraggiungibili del Band-j, mano nella mano con il vecchio Awadj, impedito dall’artrosi deformante che lo costringe a un’andatura sbilenca.
A valle corre lento il fiume Halmed. È poco più d’un rigagnolo, asciugato dalla siccità e maleodorante, inutilizzabile per la povera agricoltura dell’area e per i pastori in cerca di acqua per le pecore che si lamentano con un belato continuo senza prendere fiato.
Le poche cose che stanno come spine nella memoria raccontano a Kaleb brandelli di storia dolorosa. Le dominazioni del regno ellenico di Battriana, quella turca dei Kushan, le incursioni di Alessandro Magno, la sottomissione agli arabi. A render meno cupi i pensieri, il ricordo della liberazione conquistata dalle tribù afgane guidate dai Durrani, difesa contro gli inglesi, fino alla pace di Rawalpindi e all’indipendenza, garante l’emiro Aman Ullah, estromesso da un colpo di Stato che mise sul trono Nadir Khan e il successore Mohammed Zahiri, paladino della neutralità del Paese e dell’ammissione alla comunità mondiale dell’Onu.
Poi l’incubo dell’aggressione sovietica, l’eroica resistenza al suo strapotere militare: un Vietnam russo alla fine e il governo in mani talebane.
Appena oltre una pericolosa sporgenza di roccia, seicento metri di baratro e per sfuggire all’attrazione fatale del vuoto solo quaranta centimetri di un sentiero sassoso, a tratti infido. Oltre l’ostacolo, la “grande valle”. Lo sguardo abbandona la maestosità del paesaggio per inseguire le calme evoluzioni di una balla enorme. Sulla tela grossolana si legge la scritta “USA”. Le mani di Kaleb sono irrimediabilmente lontane dagli aiuti che piovono dal cielo senza intelligenza per finire dove nessuno potrà mai entrarne in possesso.
Il sentiero senza una ragione evidente si fa largo e comodo, diventa strada, polverosa, ma piana. Al • margine di un anfratto mimetizzato con pietre e
irrimediabilmente lontane dagli aiuti che piovono dal cielo senza un obiettivo precostituito e finiscono dove nessuno potrà mai entrane in possesso. Il sentiero senza un perché logico si slarga in una strada polverosa. A margine di un anfratto mimetizzato con sterpi e pietre, s’intravede l’accesso a una cavità naturale che l’uomo ha spicconato per ampliarlo. Nelle sue visceri si nasconde un manipolo di talebani con armi leggere, provviste di cibo e batterie mobili lanciamissili. Gli uomini di guardia sollecitano gli esuli a superare in fretta il largo spiazzo su cui s’affaccia il rifugio e Kaleb ci guadagna una forma di pane raffermo, un secchio di latte di capra, un paio di borracce d’acqua. In un amen l’inferno. Il sibilo di un aereo incursore e la montagna trema, squassata dall’esplosione di un missile che s’infrange a una cinquantina di metri. Frammenti di roccia partono impazziti in tutte le direzioni. Uno, tagliente come la lama di una spada, falcia Amina, sposa di Kaleb e la sua bimba di pochi mesi. I loro corpi scompaiono nel vuoto, rimbalzano sul pendio aspro della montagna, rotolano a valle. Kaleb è ferito a morte. Chiama a sé il piccolo Mohammed, infila nel piccolo tascapane le monete che possiede, gli affida pane e latte e chiude gli occhi. Con un ultimo sguardo cerca nel cielo, con odio, il nemico. L’ultima invocazione è per Allah, che mandi all’inferno chi gli ha preso moglie e figlia e ha ucciso ventuno profughi.
Poco lontano una fragile casa contadina scompare in una vampata di fuoco
[fuoco . . . uuuuuh — uuuuuh f.u. o.c.o/ polverepolverepolvere. per Allah non respir…/
gas. in gola, sulla pelle. dentro l’anima/
americano… basta/
vieni giù. guarda, gli occhi di Kemira son vuoti/
per Allah, la terra si sbriciola/
stelle infinite dov’era il tetto/ coriandoli luminosi, lampi/
guarda. sono spenti gli occhi di Ahmad aveva trenta giorni di vita/
Allah, Allah? dov’è la tua rabbia…
Il secondo passaggio del caccia è fatale all’equipaggio comandato dal capitano Mac Coy. Il missile terra-aria centra la coda dell’aereo che schizza in alto prima di avvitarsi e finire nei pochi centimetri d’acqua del fiume Halmed. La CNN annuncia il disastro:
“In missione ricognitiva un aereo della settima compagnia aerea degli Stati Uniti è precipitato in Afganistan in seguito a un guasto tecnico “.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 6 agosto 2017
FATIMA
di Luciano Scateni
Con tutto il rispetto per chi crede nei miracoli e ai loro autori celesti: è in corso la stagione innovatrice e revisionista di Papa Francesco e in tanti, ritengono di affidargli il completamento della “rivoluzione” iniziata con il risanamento non solo morale del clero. Un terreno di difficoltà a intervenire, per l’incidenza sulla fede dei cattolici, è il mondo dei miracoli, àncora e ultima risorsa per i mali che affliggono l’umanità. Pur se banale, lo scetticismo si pone la domanda: tra tante supposte guarigioni come mai non si è verificato che a un amputato fosse restituito miracolosamente l’arto perduto? Come mai il Santo protettore dell’acqua non ha reso fertili le aree del mondo dove la terra è spaccata dalla siccità e la gente muore di sete e malattie? Perché nascono bambini con malattie mortali come il cancro, perché terremoti e uragani uccidono innocenti e rivelano la fragilità del mondo, che l’onnipotenza del creatore avrebbe potuto agevolmente scongiurare?
 Il mio racconto della domenica per la Voce è saturo di diffuso misticismo, segnato da visioni ultraterrene, dedicato a quanti risponderanno sì all’offerta della multinazionale Hachette, regina europea dell’editoria. A lei si deve il “miracolo” della moltiplicazione di rosari, coroncine, fascicoli in edicola per la soddisfazione dei fan della Madonna di Fatima, nel centenario delle presunte, ripetute apparizioni a tre pastorelli, con la raccomandazione di recarsi nel luogo del “miracolo” il 13 di ogni mese per sei volte.” Non voglio farvi del male” avrebbe detto la Madonna, “bellissima signora” e avrebbe precisato “vengo dal cielo”. Perché la madre di Dio avesse scelto di apparire a tre sprovveduti custodi di pecore, anziché al mondo intero, in contemporanea, considerata l’onnipotenza a lei garantita dal figlio, è un mistero glorioso senza risposta e solido presupposto del delirio di fede che ne è scaturito. Per Fatima e il suo mito di Madonna del rosario il 2017 cade a proposito per il marketing di quanti hanno intuito il business proposto dal centenario delle presunte apparizioni. Di rilevante opportunismo si rivela il meticoloso lavoro di preparazione dell’Hachette che piomba nelle edicole di mezzo mondo con la pubblicazione di cinquanta fascicoli. Il piano editoriale è parzialmente noto, cioè fino al numero ventidue e si articola con sorprendente esito della creatività Hachette in questa celestiale sequenza: Rosario dei Beati Veggenti di Fatima, del Sacro cuore di Maria, della Madonna Pellegrina di Fatima, rosario dell’Angelo della Pace, per suor Luvia Dos Santos, di San Giovanni Paolo II, dei Segreti di Fatima, della Novena alla Madonna di Fatima, della Madonna del Carmine, del rosario delle Apparizioni, della Carità, della Trinità, di San Giuseppe, del Pellegrino, della Parola, della Madonna Addolorata, del rosario per i Fanciulli, del Centenario, dell’Obbedienza, della Divina Misericordia, di Papa Benedetto XV. Da questo punto in poi, accanto ai numeri dal 22 al 50, appare la definizione “non disponibile” ed è lecito sospettare della potenza creativa dei redattori.
Il mio racconto della domenica per la Voce è saturo di diffuso misticismo, segnato da visioni ultraterrene, dedicato a quanti risponderanno sì all’offerta della multinazionale Hachette, regina europea dell’editoria. A lei si deve il “miracolo” della moltiplicazione di rosari, coroncine, fascicoli in edicola per la soddisfazione dei fan della Madonna di Fatima, nel centenario delle presunte, ripetute apparizioni a tre pastorelli, con la raccomandazione di recarsi nel luogo del “miracolo” il 13 di ogni mese per sei volte.” Non voglio farvi del male” avrebbe detto la Madonna, “bellissima signora” e avrebbe precisato “vengo dal cielo”. Perché la madre di Dio avesse scelto di apparire a tre sprovveduti custodi di pecore, anziché al mondo intero, in contemporanea, considerata l’onnipotenza a lei garantita dal figlio, è un mistero glorioso senza risposta e solido presupposto del delirio di fede che ne è scaturito. Per Fatima e il suo mito di Madonna del rosario il 2017 cade a proposito per il marketing di quanti hanno intuito il business proposto dal centenario delle presunte apparizioni. Di rilevante opportunismo si rivela il meticoloso lavoro di preparazione dell’Hachette che piomba nelle edicole di mezzo mondo con la pubblicazione di cinquanta fascicoli. Il piano editoriale è parzialmente noto, cioè fino al numero ventidue e si articola con sorprendente esito della creatività Hachette in questa celestiale sequenza: Rosario dei Beati Veggenti di Fatima, del Sacro cuore di Maria, della Madonna Pellegrina di Fatima, rosario dell’Angelo della Pace, per suor Luvia Dos Santos, di San Giovanni Paolo II, dei Segreti di Fatima, della Novena alla Madonna di Fatima, della Madonna del Carmine, del rosario delle Apparizioni, della Carità, della Trinità, di San Giuseppe, del Pellegrino, della Parola, della Madonna Addolorata, del rosario per i Fanciulli, del Centenario, dell’Obbedienza, della Divina Misericordia, di Papa Benedetto XV. Da questo punto in poi, accanto ai numeri dal 22 al 50, appare la definizione “non disponibile” ed è lecito sospettare della potenza creativa dei redattori.
L’opera in questione è lanciata da una campagna pubblicitaria massiva che annuncia l’evento e si compone di 50 fascicoli. Con ognuno un rosario in “elegante custodia” (chissà quanto gradita alla Madonna), dedicato alla figura, ai luoghi e ai santi legati a Fatima e un fascicolo con il racconto a puntate dei segreti, dei misteri e della devozione. L’esordio in edicola è proposto al costo accattivante di 1 euro e 99, alla seconda uscita il costo lievita a 5 euro e 99 (furbi sembra meno di sei euro), poi il costo s’impenna (8,99 euro) “salvo variazioni dell’’aliquota fiscale”. Conservare a dovere i fascicoli? Tutto previsto, con il fascicolo numero 20 in edicola sarà disponibile il raccoglitore per “soli” sette euro (stavolta Hachette ci risparmia Il 6 e 99.
Il capitolo di prodigi extrasensoriali attribuiti al Cristo, a santi e madonne è davvero ricco. Qua e là nel mondo mistificatori di ogni genere hanno fatto piangere lacrime e sangue a statue e gridato al miracolo, seguiti da sprovveduti fedeli prima che l’evento si rivelasse un truffa. Intorno a famosi miti, si è alimentata la speculazione, complice la tolleranza della Chiesa e il giro di affari ha presto assunto picchi milionari. Per capirci Lourdes, Loreto e affini. Il più recente e finanziariamente prolifico è certamente il culto della Madonna di Medjugorie, non meno l’altro, di padre Pio, ma quello centenario di Fatima non è da meno e solo per citare un suo remunerativo indotto sono settanta gli hotel sorti a Fatima.
Ai tre pastorelli la Madonna di Fatima avrebbe rivelato importanti eventi del futuro, e consegnato in più l’ammonimento sul “pericolo comunista”, da brava interprete del pensiero catto democristiano. Nel corso di una delle apparizioni La Madonna lo avrebbe autorevolmente confermato confidando ai pastorelli che “Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segnale che Dio vi dà del fatto che si appresta a punire il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedire tutto questo, sono venuta a chiedere la Consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la comunione riparatrice. Se ascolterete le Mie richieste, la Russia si convertirà e avrete pace; diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa; i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto, diverse nazioni saranno annientate. Infine il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia che si convertirà, e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace” Nessun cenno al nazismo, alla Germania di Hitler, mai un monito contro i potenti del mondo che affamano intere popolazioni, contro la diseguaglianza ricchi-poveri, la corruzione del mondo occidentale, la fame che uccide un bambino africano ogni pochi secondi.
Nel 1930 la Chiesa cattolica si pronuncia sull’aspetto soprannaturale delle apparizioni e ne avalla il culto. Come per Lourdes a Fatima sorge un santuario e la Chiesa decide che le presunte apparizioni sono da catalogare come rivelazioni private (anche perché di pubbliche non si ha memoria, non è strano?). Durante una delle presunte apparizioni erano presenti trentamila persone e molti malati in barella. A mezzogiorno si racconta che un globo luminoso scese dal cielo, che la Madonna sarebbe apparsa ai bambini per consolare alcuni fra i malati, promettendo a Lucia che entro l’anno li avrebbe guariti. Non si ha notizia di guarigioni dei malati presenti, ma è un dettaglio trascurato dagli storici dell’evento.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 30 luglio 2017
Rondini, cani, luci, foto nelle istantanee di John Berger, lo scrittore, giornalista e intellettuale a tutto tondo di cui abbiamo deciso di pubblicare alcuni racconti tratti dal volune “Perchè guardiamo gli animali – Dodici inviti a riscoprire l’uomo attraverso le altre specie viventi”, edito nel 2016 da il Saggiatore.
Ora è la volta di “Aprire un cancello”, scritto nel 2001.
APRIRE UN CANCELLO
Quando parlavo con i cani…
di John Berger
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 16 luglio 2017
JOHN BERGER E IL SUO GATTINO BIANCO
Lo sguardo di un cane, la corsa di una lepre oltre il confine, il bagliore di una lucciola, gli occhi di un orango. Questo e tanto altro nei racconti di un intellettuale a 360 gradi, John Berger, scrittore, giornalista, pittore, critico d’arte.
Autore di G., vincitore del Booker Prize, e di Questione di Sguardi, con “Perchè guardiamo gli animali” – uscito per il Saggiatore a inizio 2016 – Berger scandaglia nei rapporti tra creature che popolano questo mondo, con uno stile inconfondibile.
Questa domenica pubblichiamo “C’era una volta”, storia di un gattino bianco e non solo. Lo ha scritto nel 1984.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 16 luglio 2017
JOSEPH
di Luciano Scateni
Nel cielo del Medio Oriente s’intrecciano le bianche scie dei reattori che si lasciano alle spalle la condensazione dei vapori di kerosene a contatto con lasciano con il sottozero dei diecimila metri di altezza. Lo sciame di bombardieri, caccia da ricognizione, droni vola in bellicosa competizione di bandiere Usa, Siriane, Russe. Su, molto più in alto compiono le loro orbite i satelliti spia, in grado di leggere il titolo di prima pagina di un quotidiano sfogliato da un lettore seduto al bar per la prima colazione. Niente di chirurgico: bombe e missili radono al suolo villaggi che nulla hanno a che fare con il terrorismo e non di rado devastano scuole, ospedali, chiese. Con tutto questo qual è il rapporto di Alahamir, della moglie Farah, dei figli Asser, Manuji, Actar, Karinia? Joseph non lo saprà mai
Il braccio di Joseph si ritrae, ma solo per un momento. Il pluridecorato pilota è addestrato a far valere il gelo di una ferrea disciplina sulle emozioni. Ma poi, gli hanno insegnato che alla pietà per le vittime delle sue bombe deve opporre la pena per i morti della sua terra.
Occhio per occhio. Mary, Philip e Ted, Johnny, Maggie: 8 e 45, settembre, undicesimo giorno. Un lampo, occhi, naso, gola, saturi di polveri e gas, carni straziate, urla, invocazioni. Un’ecatombe, le torri gemelle di schianto giù. Ferita l’intera America, l’orgoglio della potenza mondiale umiliato dalla scoperta della vulnerabilità.
Il pollice di Joseph preme sul pulsante rosso. “Cede docile alla pressione, forse troppo”.
 Alkhada, le sette in punto del mattino. Ahmida, Mahmood e Muttawakil, Abdul Hanan, Endalah, disintegrati dalla testa devastante del missile sputato con “imprecisione chirurgica” dall’F35 in picchiata.
Alkhada, le sette in punto del mattino. Ahmida, Mahmood e Muttawakil, Abdul Hanan, Endalah, disintegrati dalla testa devastante del missile sputato con “imprecisione chirurgica” dall’F35 in picchiata.
Fuori di testa Joseph prova a farsene una ragione: “Buongiorno. E’ il nostro buongiorno della vendetta. Contro di voi, uomini e donne avviliti dall’odio, disumanizzati da rancore e pregiudizi, violenza, superbia, intolleranza, è il nostro contro l’ideologia del terrorismo”.
Alahamir
Tre robusti tronchi, piantati nella terreno bruciato dal sole, sostengono un telo riparato mille volte con residui di un logoro mantello di stoffa pesante, tela cerata. Paletti, tutt’intorno, segnano i confini del territorio assoggettato, al centro sei giacigli, uno scanno largo quanto il fornello a petrolio che poggia su tre piedi e un pezzotto di legno, un paio di contenitori della Pepsi posti di lungo e di largo, pieni di oggetti consunti, una grande scatola di cartone con le povere riserve alimentari centellinate fino a un nuovo viaggio per l’agglomerato di Ossiah, dove all’aperto si compra l’essenziale per non morire di fame. Oltre la tenda, stesa in terra, una larga stuoia di giunchi intrecciati sapientemente, logora, un vecchio fucile, ancora efficiente, abbandonato da un soldato inglese a conclusione di secoli di colonialismo, mai usato per cacciare, che a uccidere animali per sfamarsi sono da secoli arco e frecce, un filo di plastica con l’anima in ferro, teso tra due pali, regge poveri panni, gli stessi da anni, più volte rammendati Al centro della tenda il fondo tagliato di un bidone colmo di cenere degli sterpi bruciati durante la notte, l’odore greve di corpi lavati di rado, di alito pesante, la metà di uno specchio imbracata in un fil di ferro agganciato alla tenda, uno zufolo rudimentale, capace di emettere poche, monotone note, il tascapane di Alahamir, pieno quasi di niente ogni volta che prepara un nuovo cammino con le sue pecore, in cerca di d’erba nel sottobosco della foresta, l’apatia stabilizzata di Farah, la donna di Alahamir e Asser, Manuji, Actar e Karinia, scheletrici figli di accoppiamenti mai oltre il soddisfacimento di bisogni elementari. Sui loro volti i segni indelebili di fame, rassegnazione, paura.
Si rischiara appena il cielo, un cane latra, affamato, le pecore si preparano al un nuovo giorno scampanando.
Alahamir copre gli occhi con un braccio. Prova a smarrire nel sonno la consapevolezza di una vita disumana.
Farah si tira su per prima, porta fuori della tenda il catino con l’acqua usata per lavarsi, raduna le foglie di Waighé e rametti raccolti per il fuoco della notte, li accende e il fuoco lambisce il trespolo di ferro che regge un bricco con acqua di pozzo dove immergere thè nero, molto aromatico.
Coalizzati, Asser e Karinia sono antagonisti abituali di Manuji e Actar e non solo con scambi di insulti che il padre riesce a sedare solo mostrando ai figli lo scudiscio di pelle che hanno assaggiato più volte urlando di dolore.
Joseph deve liberarsi di un missile prima ancora lanciato: Suppone di volare sulla terra di irriducibili talebani, lo proietta verso terra, con un rapida inversione di rotta per fotografare l’effetto dell’impatto.
Il “Mikoyan Kh-10S Yen, missile aria-superficie esplode a cinquanta metri dalla tenda. Farah porta le mani alla gola, sputa l’anima, si piega in due, raccoglie le gambe, le circonda con le braccia, rantola.
Alahamir urla ai figli di coprirsi la bocca, di correre via, senza fermarsi mai. La tosse gli toglie il fiato, i polmoni esplodono, la vita se ne va in un niente. Il peggio è assistere impotente alla morte tra gli spasimi dei quattro figli che dopo pochi passi di corsa cadono, stroncati dai gas letali. Farah gli muore tra le braccia.
[Ma non era Saddam Hussein a nasconderli in attesa di usarli nella guerra contro gli sciiti?]
Wladimir Ostrosky, ingaggiato nell’8l dal laboratorio NCS di Appleville, osserva al microscopio il batterio geneticamente modificato di una malattia confinata per millenni in un piccola area dell’Africa abitata da una tribù di giganti neri come l’ebano. In che forma prepararlo, come veicolarlo per obiettivi militari?
A Wasghington hanno fretta. Non è ancora compiuta la vendetta per la strage di Ground Zero, per l’orgoglio ferito del Paese più potente del mondo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 9 luglio 2017
Per Caso
di Luciano Scateni
Questo è un racconto per caso. A cominciare dal titolo, che non lo è. Esiste, altroché, un rapporto conflittuale con la tastiera del pc, sbiadita ai bordi, assai di più sulle lettere di maggior impiego nella scrittura di ogni giorno: nascerà un’idea di qualità, lettere si uniranno a lettere in parole condivise e pensieri fluidi? Provi a far tue le suggestioni di Palo Alto e le induzioni post-ipnotiche di Watzlawick, t’ingegni a zittire l’emi-cervello di sinistra, i suoi inviti a logiche semplificazioni. E’ il destro di dove origina la creatività…allotra attivarlo. Ingoi e digerisci in fretta la ridda di stereotipi d’assalto che premono per oscurare, eludendo la coscienza critica, l’impressionante chiarore del monitor dirimpettaio.
Ancora nel limbo dell’incertezza, a mezzo di un cammino noto, sul crinale che separa le banalità dall’estro: era questo il tormento di Joyce, prima che l’Ulisse gli sgorgasse da neuroni finalmente liberi, così follemente invitanti?
The “genius”, l’immenso jam session man Keith Jarrett, sostiene con sospiri e lamenti gutturali l’empito che trasforma voli di piena magia sui tasti dello Steinway, con prologo in calda mediterraneità e successioni di profluvi, note fuori spartito. Entra prepotente nell’anima superba purezza dell’improvvisazione su temi-non temi e virgole musicali che generano cascate di frenesia compositiva. Il Concerto di Colonia (Koln Konzert) torna nella pila dei Cd, insostituibile nella hit parade della sezione jazz e i valori pressori stentano a conquistare la norma.
Il computer, precipitato nella crisi dell’esordio narrativo, ne esce indenne: “The Koln Konzert” ha la meglio sull’input logico-analitico dell’emisfero di sinistra e la sua improduttività razionalista. Le dita che corrono nervose, coinvolgenti sul piano di Jarrett è la magia che spalanca le porte della creatività.
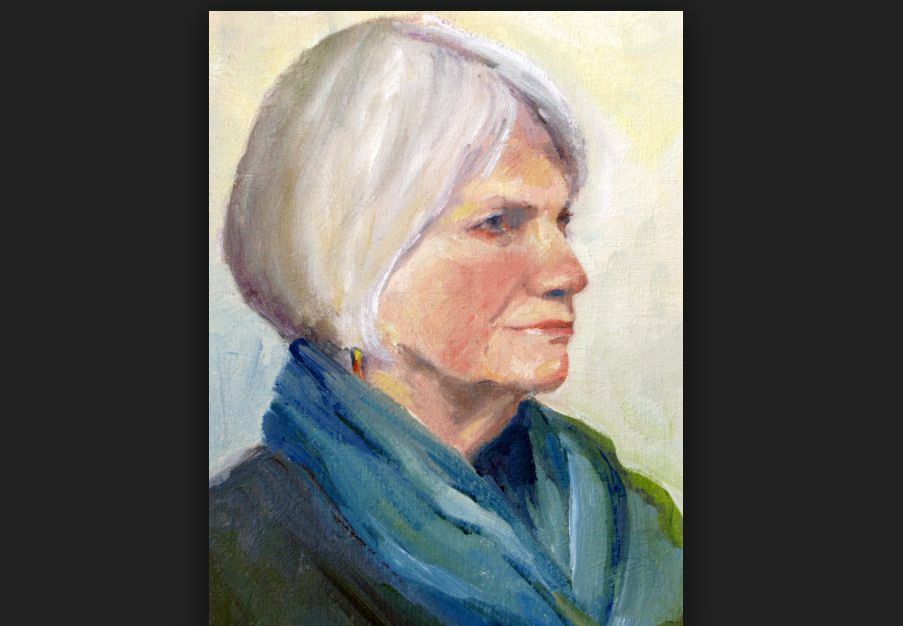 Il vetro di un’anta della finestra è angolato così da riflettere l’interno della stanza e il ritratto fotografico di Betty, il volto racchiuso chiuso in una ghirlanda di capelli candidi, gli orli ricamati della camicia di lino. Una fascia stretta imprigiona il petto, per nascondere forme generose e specialmente i grandi capezzoli che giovanetta le mettevano addosso una gran vergogna. Betty Edwards, con le tecniche del suo rivoluzionario “Disegnare con la parte destra del cervello”, aveva scommesso con venti ragazzi “negati”. In tre mesi li aveva connessi con l’emisfero destro, fino ad allora dormiente e con il recupero della creatività il prodigio di ritrovarsi pari a diplomati al liceo artistico. A Betty d’altri tempi piacerebbe uscire dal picoglass e scoprire se Anna, la prima nipotina, è diventata il genio che lasciava intendere di essere, appena scoperto il gioco della relazione con il mondo attraverso le parole. La piccola, a diciotto mesi, diceva “Mami, se parli troppo non riesco a dormire. Perché non vai a giocare di là?”. Chiamava se stessa Paola, il nome della madre e con la bambola condivideva il proprio, in un gioco psicologicamente complesso di dissociazioni. personalità.
Il vetro di un’anta della finestra è angolato così da riflettere l’interno della stanza e il ritratto fotografico di Betty, il volto racchiuso chiuso in una ghirlanda di capelli candidi, gli orli ricamati della camicia di lino. Una fascia stretta imprigiona il petto, per nascondere forme generose e specialmente i grandi capezzoli che giovanetta le mettevano addosso una gran vergogna. Betty Edwards, con le tecniche del suo rivoluzionario “Disegnare con la parte destra del cervello”, aveva scommesso con venti ragazzi “negati”. In tre mesi li aveva connessi con l’emisfero destro, fino ad allora dormiente e con il recupero della creatività il prodigio di ritrovarsi pari a diplomati al liceo artistico. A Betty d’altri tempi piacerebbe uscire dal picoglass e scoprire se Anna, la prima nipotina, è diventata il genio che lasciava intendere di essere, appena scoperto il gioco della relazione con il mondo attraverso le parole. La piccola, a diciotto mesi, diceva “Mami, se parli troppo non riesco a dormire. Perché non vai a giocare di là?”. Chiamava se stessa Paola, il nome della madre e con la bambola condivideva il proprio, in un gioco psicologicamente complesso di dissociazioni. personalità.
L’esordio non programmato del racconto si dispiega in centoventi pagine di un’epica narrazione sorprendente quanto brevi fiabe non-sense nate da caotiche, attendibili successioni, oscuramente logiche. In vista dei diciotto anni virtuosismi in sequenze tra surrealismo e non sense, pubblicate dai “Quaderni dell’inverosimile”, cult di intellettualità fuori schema.
Budello sonoro su casse di palissandro, percussioni asincrone, mandole sfiorate da plettri tartarugati. A Kioto, nel gelido dicembre, improvvise folate di ghibli cocente.
Fumaioli di caicchi in Turchia. Da essi vapori magenta, argento e blu notte. Sul ponte sinuose movenze e sei veli caduti uno a uno, profumati di odalisca.
Vele e su di loro furie di libecci e maestrali. Talenti mortificati in postpubertà da saccenti maestri di pennello. Tavolozze sequestrate a compagni di sventura cosmopoliti, le loro opere in olio, acrilico, graphic computer, esposte al pubblico ludibrio, sul lungomare di Partenope.
Sabbia apocrifa /ambiguità siderali /seni di Ofelia gonfi di presunzione/fiumi incandescenti di champagne / Trump a testa in giù nel Gange purificatore.
Derisione maldestra, poesia molesta, Artù lancia in resta, festa modesta, mesta protesta, repressione lesta, testa pesta, attenzione desta. Una tempesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 2 luglio 2017
Ahmad
di Luciano Scateni
Allah, grande? Gli hanno detto “Chiede a ogni buon musulmano di abbattere il nemico dell’Islam” che l’accoglierà dopo il martirio in un aldilà per chi si immola, che lo raggiungerà chi lo ama, che morire nel suo nome è un atto di eroismo in questa vita che prelude alla felicità eterna. Perché non credere ad Allah?
Non c’è più notte a Kabul. Serve a nulla che Jaira porga il seno al piccolo Calef. Non s’acquieta il bambino. Dai capezzoli arrossati non sgorgano che umori senza sostanza. Al tuonare sordo della contraerea Calef sobbalza e ogni volta le mani patite della madre lo avvolgono, a impedire che dalle orecchie il suono del-– la guerra si trasmetta alla testa, al cuore.
Sempre più vicine le esplosioni e l’aspro sapore dei missili che squarciano gli obiettivi è nella bocca, soffocante. Il sibilo degli incursori in picchiata si insinua nelle vene, accelera il cuore, schianta le ultime resistenze del fisico e della mente. Il pianto del bimbo non ha più forza, né convinzione. È un lamento monocorde, un mugulare perpetuo. Jaira finisce per ricalcarne la struggente monotonia, pensieri tristi non hanno spazio per la speranza, ridotta a niente dai mali antichi della sua terra.
Ahmad è via da sedici mesi. Jaira sa di lui quel poco che strappa di bocca a pochi amici, jiadisti di complemento, i marginali al nucleo della guerra santa che alleva guerrieri suicidi. Esile, ma solido come un giunco nervoso che il vento flettere, non schianta, il padre di Calef non è tra gli eletti che possono parlare guardando negli occhi Abu Ghaith, l’uomo che governa il pensiero di milioni di musulmani divulgato al mondo.
Come l’incisione quasi indolore di una lama affilatissima che affonda senza ostacoli nella carne, la voce di Hannon Shaari ha enfatizzato con Ahmad il racconto della sua morte epica per la gloria dell’Islam. “Predestinato. Sei uno dei figli diletti, scelti dall’Imam per colpire il cuore del nemico. Da questo momento la tua vita è sacra, appartiene al popolo musulmano e la tua missione è nelle mani dell’Islam”.
La jihad sottrae ad Ahmad l’appartenenza alla famiglia e lo introduce nel percorso folle, mistico del sacrificio.
Il nemico è all’erta. Ha tracciato con efficientismo militare la trama degli obiettivi che presume siano obiettivi Isis della vendetta e li protegge con un imponente potenziale ombrello difensivo.
Nelle visceri del monte Shaennin l’intelligence mussulmana coordina il flusso di informazioni e prepara l’ultimo stadio del piano per umiliare i nemici del popolo musulmano.
Washington. Da sedici mesi Ahmad se ne sta dietro il banco di una bottega polverosa di libri rari che raccontano la storia, gli usi, i costumi, la cultura del suo popolo. Nessuno immaginerebbe che al di sotto del malandato parquet si nasconda un vano di modesta cubatura ma sufficiente a custodire esplosivi e armi sofisticate, un telefono cellulare, che insieme al cuore tecnologico ha spazio sufficiente per l’hc3. Pochi grammi della micidiale miscela sono devastanti quanto di dieci chili di tritolo. In una nicchia microscopica è nascosto il sensore, esempio di ultima generazione della tecnologia, che appena ricevuto l’impulso inviato sulla frequenza del cellulare riduce il telefono in miliardi di pezzi. Stessa sorte tocca a quanto è nei dintorni per un’ampiezza di molti metri.
Da sei mesi Assan Moshef, stimato uomo d’affari egiziano, si è distolto dal governo della società. Due dei suoi quadri intermedi della holding di import che commercializza in patria l’informatica della SBC, multinazionale con il cervello a Washington e i terminali produttivi a Detroit, sono stati sollevati dai compiti abituali e assegnati a una missione molto speciale. Il loro obiettivo è Vincent Lister.
Lister è un patriota vivisezionato dalla CIA. Al microscopio dei servizi segreti ogni dettaglio della sua vita, dei familiari, degli avi, di amici e parenti, appare ineccepibile, come il senso del dovere e un americanismo esasperato. Vice Presidente degli Stati Uniti è ritenuto dall’Isis l’uomo il duro dell’establisment che ha convinto il Senato a dichiarare guerra senza prigionieri al Califfato. Il lavoro di Macheb e Halfedi è paziente, preciso, metodico. Sul tavolo di Moshef c’è un rapporto dettagliato, esaustivo. Lister è single. Ha rinunciato all’idea di famiglia perché avrebbe ostacolato la carriera politica. Vive da solo in uno chalet a venti miglia da Washington e l’accesso alla casa è possibile unicamente alla fedele Virginia, domestica impagabile che ogni giorno governa la villetta dal mattino alle prime ore del pomeriggio. Il colonnello rientra a sera, mai prima delle sette. Possiede due cellulari, uno di servizio, l’altro per le conversazioni private. Nelle rare giornate di riposo che l’amministrazione gli concede, Lister parte di buon mattino con la sua Pontiac e supera le settanta miglia che lo separano dalla collina di Green Page dove l’unica sorella vive con il marito, timorato di dio, e tre figlie femmine, inguardabili.
Macheb entra nella bottega di Ahmad con mille precauzioni, perfino eccessive e l’afgano intuisce che è la visita attesa da tanti mesi.
Halfedi parcheggia l’auto a metà di una stradina che corre perpendicolare al sentiero su cui si affaccia lo chalet di Lister. Attraverso un viottolo che costeggia larghi spiazzi erbosi si ritrova alle spalle della costruzione e senza forzare la serratura, con un passepartout universale, si introduce nel retro della casa. La stanza da letto è al piano superiore. Il cellulare di servizio è in vista sul comodino. Finisce nelle ta sche di Halfedi e al suo posto rimane quello identico, esplosivo, elaborato per l’attentato.
Il cuore di Ahmed fa brutti scherzi da qualche tempo. “Quando, grande Allah? Quando vendicherai i morti di mille bombardamenti, i bambini, le donne, i vecchi vittime della grandinata di missili, quando punirai il demone americano che opprime il mondo e affama il popolo musulmano? Quando rivedrò Jaira, il piccolo Calef?”
È un mattino cupo: incubi nella notte appena conclusa, poco sonno, l’ansia delle incognite, la responsabilità della missione, anche paura.
In terra, piegato in quattro, un biglietto. La carta quadrettata è quella di altri messaggi, la grafia inelegante, frettolosa. Solo numeri. Una lunga sequenza. La prima cifra è il codice dell’operazione, come dire “È il grande momento, Allah è con te”, poi i numeri del giorno del Ringraziamento e infine 12 e 30, l’indicazione dell’ora.
La mano è ferma, il cuore trema. Due dita premono il tasto, parte l’impulso. In un amen gli Stati Uniti perdono il loro vice Presidente.
Kabul, ore sei e trenta del mattino: Jaira, Calef, e con loro quattrocentomila afghani, non hanno il tempo di invocare Allah. L’esplosione disperde i corpi di midi miagliai di uomini, donne e bambini, stroncati dall’energia atomica.
Tarda a tornare Ahmad. Non riesce a morire accanto alla moglie, al figlio, al vecchio padre che gli ha inculcato la fedeltà all’Islam, fino alla morte. Quando la nube tossica si è diradata si aggira con i duri dell’’Isis tra le macerie della sua misera casupola. Sotto spezzoni delle travi di legno i corpi deformati di Jaira, Calef, del padre. Non c’è tempo per seppellirli e via per un raid nella grande moschea sciita di Imam al-Sadiq. Farà centottanta vittime la cintura esplosiva di Ahmad un attimo aver l’urlo disumano “Allah è grande”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 25 giugno
Pittore, per non morire
di Luciano Scateni
24 ore e altre 24, più 24, per 365 giorni di ognuno di dieci anni e sei mesi. In quattro a inspirare-espirare in quattro metri quadrati, nemmeno un attimo di intimità, compagni di pena imposti, rumore permanente di chiavistelli, urla di chi non ammortizza la rabbia per la libertà negata e basta, nessuna ragione per mettersi alle spalle la non vita in una cella che uccide le idee, la percezione dell’esterno, non raramente con l’esodo dalla disperazione con l’estremo rimedio di spegnere la vita per farla finita. Oppure il pieno di un intero giorno, del successivo, di quelli dei che mescolano rosso e giallo per improbabili pennellate di arancione su volti ingrifati di modelli ragistrati in memoria, ma deformati dal degrado della prigionia. “Detenuto 2397, è ora di dormire. Luci spente, via pennelli e tele.” “Guardia carceraria Buongiovanni”, prossimo soggetto della prossima tela vergine.
Strano dolore. Non una fitta e neppure quella sofferenza sorda, intermittente che sfibra mentalmente e ha la meglio sulla volontà di contrastarla. Un insulto subdolo, segno di fragilità none latente, non esplicita. A sinistra, altezza del rene (ma poi è qui la sede del rene?) tutto è cominciato con una pugnalata alla schiena, appena chiusi gli occhi. La sveglietta luminosa proietta l’ora sulla parete. L’una dopo la mezzanotte”. Prima, nel dormiveglia, dolori sopportabili, a intervalli sempre uguali, ogni due inspirazioni. Poca cosa, forse lievi fitte intercostali di natura reumatica. Poi l’apocalisse e lo spettro di un’altra notte a occhi spalancati, la vista deprimente dell’abito di modesta fattura e di tessuto scadente, poggiato sulla spalliera di una sedia che avrebbe bisogno del restauro di un impagliatore, della testata in ferro battuto smangiato dalla ruggine, della coperta buttata in fretta sulla spalle nelle notti delle incursioni aree su Napoli, passate nelle cave di tufo dei ricoveri.
Una colica? In mancanza di precedenti vale il racconto di chi ne è stato vittima. Si, colica. C’è un antidolorifico nell’armadietto dei medicinali, accanto allo specchio che ha perso gran parte della capacità di riflettere? Giù le gambe dal letto, ma quasi impossibile la posizione eretta. La schiena rifiuta di reggere il peso del corpo, appesantito da alimentazione ipercalorica prolungata e rivela segnali di decadenza della colonna vertebrale. Sollevato a fatica il materasso la condizione della rete, deformata, irregolarmente sporgente in quasi tutta la trama, rivela un’altra causa di danni alla schiena.
– Appuntato, voglio parlare con il direttore
– E di che?
– È una questione privata
– Don Anto’, ancora non avete imparato. Dovete dire perché e percome
– C’è un materasso che mi buca la schiena. Passo le notti in bianco
– E per questo volete parlare con il direttore? Don Antò, ma facitece ‘o piacere
Ci sarebbe da riempire un modulo. Nome, cognome e matricola, motivo della richiesta, eccetera. Le faticose vie della burocrazia, così predice l’appuntato Caruso, avrebbero affrontato e risolto la “cosa” in tempi ragionevoli. Ragionevoli per chi?
Nessuna voglia di scrivere a casa quel giorno e neppure quello dopo. Che dire? “Cara Angiolina, ho un gran mal di schiena, la rete del letto è tutta ferri sporgenti che trafiggono il materasso e la carne…”
Il blocco di carta ruvida a righe si riempie di ghirigori scomposti, a tratti di scarabocchi trasformati abilmente in disegni, spesso di volti deformi. L‘esito evoca il tempo lontano dell’espressività artistica. Senza ragione la rinuncia, anzi coincide con la maledizione di una vita esclusa dal lavoro, dalla normalità, con l’arruolarsi nello sconfinato esercito di criminali che entrano ed escono dalle celle del carcere di Poggioreale.
Smaltito lo sfinimento della colica con una dose adeguata di buscopan somministrato in infermeria, la sorprendente nostalgia di colori e tele da dipingere. Tornare alla pittura, riannodare il rapporto con la magia della creatività, di notti senza tempo davanti al cavalletto?
— Tenete, appuntato. Sono duecento euro e questo è un elenco di cose da comprare. Tele e pennelli, colori acrilici primari, carboncini.
Smarrimento di fronte al nulla della tela vergine, La mano vaga da un tubo di colore all’altro si paralizza nell’incertezza, è tentata di stappare il contenitore del rosso, desiste, impugna il pennello a testa larga, in attesa di miscelare giallo e blu per diventare il verde malvisto dai pittori per nessuna compatibilità con altri colori. sembra perfino un errore non corretto.
E allora, riempire di asimmetrie il perimetro di questa macchia solare, includerla nell’ultimo spazio libero da scritte e foto di donnine seminude, tra un letto e il sovrastante, a testimoniare con il ritrovato estro pittorico un inedito percorso di rassegnazione attiva, sostenuta dalla speranza di riappropriazione delle dignità usurpata dallo squallore della detenzione.
Duemilatrecentonovantasette, numero di sicuro anonimato. Registra la presenza del detenuto ics, ipsilon, “pittore per non morire”.
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 18 giugno
Ashira
di Luciano Scateni
Un lungo fil rouge, anzi, nero come la pece, congiunge luoghi di evidente estraneità, ma in parallelo per quanto rappresentano della società mondiale impregnata di diseguaglianze, ingiustizia sociale e prevaricazione dei poteri forti sulle fragilità da loro indotte e stabilizzate. Ashira, Crotone, New York, esemplificano con le loro specificità la progressiva degenerazione dell’ordine primordiale che avrebbe garantito l’intera umanità con una gestione egualitaria delle risorse globali. Il pessimismo della ragione induce a negare un futuro diverso: a parlare il linguaggio degli ideali di sinistra, di parità universale dei diritti, è solo il papa “comunista” Bergoglio. I suoi antagonisti sono, oltre che troppi, indisponibili a ogni revisione del sistema che domina la Terra.
Ashira, duemilauno.
Un gran calcio spedisce il fagotto di stoffa in uno spiazzo con spuntoni di piante arse dal sole. La palla bitorzoluta rotola sobbalzando sul terreno irregolare, in discesa, si ferma a un niente dal margine estremo che precede un dirupo vertiginoso.
‘Mbuti insegue l’insegue, dribla pietre appuntite e sterpi, attento a non ferire i piedi nudi. Senza volerlo evita un paio di mine, una solo per pochi millimetri. Agguanta la palla un attimo prima che finisca nel vuoto e trionfante la mostra ai compagni di gioco. Se ne torna con flemma tutta africana. Non c’è motivo di affrettarsi. La partita è salva e così il risultato, a lui favorevole.
Il terzo passo gli è fatale. Il tallone del piede destro finisce sullo spinotto di una Washimps capace di uccidere un elefante e ‘Mbuti vola in alto, le braccia spalancate, nemmeno una smorfia di dolore. La mina non gli ha concesso neppure il tempo di gridare “mamma”. Quel che rimane di lui ricade sei metri più in là. Un tronco grondante sangue. Mahoni si lancia d’istinto in aiuto del fratellino. Sa di rischiare la vita, ha visto altri ragazzi che al posto di gambe, mani e braccia,
hanno poveri moncherini. Sa che la loro vita è affidata a un filo sottile, fragile, destinato a spezzarsi presto in un’area del mondo dove sopravvivere sarebbe un miracolo anche senza i venti di guerra. Il piede incontra una radice sporgente e l’urto provoca un balzo in avanti, un tuffo, le mani e la faccia avanti al corpo. Naso, mento, fronte e mani protese a proteggersi incontrano il terreno e una mina antiuomo che dilania la carne, frantuma le ossa, spappola il cervello di Mahoni. Quel che resta della sua generosa sfida alla morte finisce in un fosso imperfetto, scavato dal padre dei due ragazzi. Coperti di terra i corpi di ‘Mbuti e Mahoni saranno divorati dai giganteschi vermi che popolano il sottobosco al confine con la foresta di Ghittanau.
Un mucchietto di pietre sul tumulo, in equilibrio precario. Il ricordo dei ragazzi vivrà solo nella memoria dei loro piccoli amici, incapaci di sostituirli nella baby squadra del villaggio Ashira.
New York, autunno.
A sera si sfila dal braccio il gesso che durante le ore di “lavoro” lascia intendere a protezione di una frattura che non c’è e lascia libera la mano. Gene Mc Allum è ladro di destrezza. Viaggia in metrò, si apposta accanto alle porte d’uscita nelle ore di massimo affollamento dei treni, distoglie l’attenzione dei derubati disgustandoli con il tanfo del corpo e l’alito che puzza di pessimo
bourbon ingurgitato nelle prime ore del mattino. Pochi secondi prima di una fermata, si avvicina ai passeggeri, meglio se donne, pronti a scendere. Poggia il braccio immobilizzato dal gesso sulle borsette, apre cerniere e fibbie, sfila portafogli, lascia che scivolino nella larga tasca di una giacca sbrindellata, unta, maleodorante.
A sera è nel suo cantuccio, abbracciato al cartoccio che avvolge la bottiglia di alcolici da sette dollari comprata in uno spaccio dove si trova il peggio per etilisti, cognac distillato malamente, di marche improbabilmente francesi, petrolio spacciato per wiskey di malto. Il vento soffia su cartacce e fogli di giornale, buste di plastica. È gelido. Non rimane che vuotare la bottiglia e sperare che riscaldi stomaco e visceri. Il sangue è saturo da anni di alcol. Non sopporta l’insulto di un surrogato di brandy da vomito, di altissima gradazione. Il capo di Mc Allum cade con pesantezza sul petto, la schiena non regge più il tronco che penzola da un lato prima di abbattersi sul marciapiede. La tempia batte sullo spigolo alla base di una colonnina, all’ingresso di un casa pretenziosa. Un braccio copre una larga macchia di sangue. Ridotto così Mc Allum è un fagotto, uno dei figli di nessuno che popolano la marginalità di certa periferia della Grande Mela. Ora la sua mole ingombra il passaggio dei pedoni. C’è chi lo scavalca e chi lo calpesta, chi cambia marciapiede per non essere coinvolto, chi bestemmia contro la razza bastarda dei barboni. C’è chi si china e gli tasta le tasche sperando in qualche cent da rubare. C’è chi lo raccoglie. Qualcuno ha telefonato alla polizia, gli agenti hanno chiamato un’ambulanza, gli infermieri hanno chiesto in quale obitorio portare il cadavere, il medico di turno ha sbuffato, nessun parente ha rivendicato il corpo di Gene Mc Allum. Per lui neanche un Pater Noster.
Crotone, Calabria.
Quel giorno di Febbraio la città si rifugiava in casa, in qualche bar più accogliente. I ragazzi “filonisti”, marinata la scuola, non se la sentivano di vagabondare sul lungomare spazzato da un furioso maestrale, flagellato dalla grandine. Si rintanano nel cinema Olimpia, a far casino, a tifare per gli yankee in competizione sanguinaria con i cheyenne.
Luigi è tappato in casa, la testa tra le mani, i sintomi di una crisi depressiva in arrivo. Diciotto anni prima la notizia, in poche righe di un telegramma firmato dalla Siat Chimici Spa, azienda a capitale privato resuscitata dall’Iri: “Si prega presentarsi in fabbrica alle ore 8 del primo marzo…”
Quasi vent’anni a maneggiare sostanze tossiche. I primi sintomi di guai polmonari, nascosti per il terrore di dover lasciare il lavoro e diventare un uomo inutile. Diventa decotta la Siat, fa ricorso prima discreto, poi violentemente ampio, alla cassa integrazione. Dichiara lo stato di crisi, licenzia. Ha sette figli Luigi, il
mutuo della casa che incombe a ogni fine mese. La famiglia gli è ostile, non avvezza alla presenza ingombrante di un uomo senza qualità oltre i cancelli della fabbrica. Luigi tenta di uscire dallo straniamento con la ricerca di un lavoro. Che non c’è. Un parente gli dà una mano per qualche tempo, si carica di errori e debiti. L’insieme dei problemi lo rinchiude in una prigionia sofferta, senza vie d’uscita e finisce vittima di un bieco usuraio che lo strangola. Sopravviene l’ansia che diventa angoscia, vergogna, impotenza, impossibilità di uscire dal buio di un fallimento doloroso.
Oggi Crotone è livida. Stranamente non c’è nessuno in casa di Luigi. Ma c’è una trave nel sottotetto e attraversa lo spazio ingombro di vecchie cose, inutili. Lo spesso cavo di una linea dell’alta tensione oltrepassa l’asse di legno e diventa nodo scorsoio all’altro capo.
Un giorno senza qualità. Crotone, Calabria, Sud. Nessuno fa nulla per Crotone. Nessuno ha fatto nulla per Luigi. Niente per la Calabria e niente per il Sud, niente di niente per i sud del mondo molto più sud di Crotone.
Washington, Stati Uniti d’America.
Al ventunesimo piano del “Grattacielo delle Assicurazioni” gli stati maggiori di Nike, Coca Cola, Big Pharma pendono dalle labbra di Steve Hilton, guru del marketing, teorico e operatore pragmatico della rivoluzione che ha spostato il centro del mondo degli affari dal prodotto al marchio, come racconta mirabilmente Naomi Klein in “No Logo”. Il meeting propone ai big delle multinazionali strategie di autoassoluzione, per dimenticare la condizione di schiavitù
dei bambini di Paesi in estrema povertà che lavorano scarpe da ginnastica e altri prodotti grandi firme da compensare con lasciti consistenti alle organizzazioni che tutelano l’infanzia.
Al quarantaduesimo piano dello stesso grattacielo, è in corso un summit per affrontare la crisi dell’industria pesante Usa e riflettere sulle vie d’uscita dalle difficoltà che attraversano i produttori di armi. Al tavolo del confronto vertici militari, manager di settore, esperti di strategie di mercato. C’è diversità di vedute sui piani di sviluppo dell’industria bellica, ma unanimità sulla scelta di incrementare la spesa per gli armamenti, nell’ordine di molti milioni di dollari.
All’ottantaquattresimo piano della medesima torre, si disegna lo scenario della globalizzazione. Acquisito l’affare dell’occupazione economica dell’est europeo, gli occhi dell’espansione capitalistica osservano con interesse Medio Oriente e Africa.
Non si incontreranno mai i manager delle multinazionali, i guerrafondai, i petrolieri e gli strateghi del capitalismo espansionista. Finirebbero per guardarsi negli occhi, per confrontarsi con i sensi di colpa messi a tacere con la fede nel dio denaro. Forse nella loro cinica indifferenza per i problemi dell’umanità si potrebbe aprire una breccia che li costringerebbe a riflettere sulla tragedia di un bimbo che muore di fame e malattie ogni quattro secondi in qualche luogo del mondo, sulle povertà estreme dei senza dimora, la disperazione di uomini espulsi dal mondo del lavoro, di madri e figli uccisi da missili “chirurgici”, sui corpi straziati di ’Mbuti e Mahoni.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 11 giugno
Maddalena
di Luciano Scateni
Prendere, lasciare, andare senza ticket di ritorno. Vita tribale, l’odore aspro della foresta, il tempo di giorno e notte deciso dal volgere del sole da est a ovest, l’immersione totale in un progetto di autoesclusione dall’era di tecnologie invadenti. Se ci stai, benvenuta, se scegli la fuga rassicurante, auguri, va dove ti porta il no.
Ci vuole una solida base. Tronchi robusti, stretti l’uno all’altro da grandi canapi ritorti, per centottanta metri quadrati. La metà coperti, a protezione di vento e pioggia, gli altri accecati dal sole, illuminati dalle stelle, affogati nel verde di piante tropicali: il dondolo, telaio di bambù e sdraio di stuoia, un tavolo basso d’appoggio, un grande ombrello di rafia, una tettoia spiovente di canne a digradare sulla balaustra di tronchetti giovani, divelti dalla foresta che circonda la “casa”.
Mai in piena il placido fiume d’acqua cristallina, glaciale. Scende leggera lungo il palato e nelle visceri. Acqua generosamente pescosa, a tratti verde come il tappeto di alghe fluttuanti sul fondo, altrove intensamente azzurra, a sera tinta di un rosa denso dal sole, mentre cala veloce all’orizzonte, rasente ad alberi d’alto fusto con i rami arrossati dalle foglie d’autunno. Un’ansa quasi ad angolo retto coincide con la svolta brusca del percorso a valle del corso del fiume. Ho portato con me trenta barattoli da un chilo di acrilici bianco, nero, giallo, rosso, blu, tele e tavolette di spesso compensato, spatole e pennelli, carboncini e gessi, pastelli, un monumentale cavalletto. Ho portato con me carta e pennarelli, molta carta di pregio e tanti pennarelli, ho portato con me un reperto archeologico della diffusione, il numero 37 della Parlophone, fonografo a manovella, appena restaurato dalle mani miracolose di Geppino il “portoghese”, frequentatore assiduo del teatro san Carlo senza aver mai investito una lira in biglietti. Ho con me un paio di metri cubi di “78 giri” di lirica, jazz e musica leggera d’autore.
Ho lasciato all’azienda che raccoglie i rifiuti urbani i resti di un telefono cellulare: l’ho posto con amorevole cura sul marmo del davanzale che per sorprendermi affaccia su un abete natalizio assolato dall’alba a sera e venuto su fino al terzo piano, nonostante le origine alpine.
Ho mirato con cura al suo cuore tecnologico e ho picchiato duro. La prima martellata ha spaccato il display, la seconda, la terza, le altre, hanno incrinato il telaio, frantumato la tastiera, ridotto in briciole i circuiti, fratturato la batteria, crepato memorie e audio dispositivi.
Ho con me libri di storia, naturalismo e filosofia, manuali, atlanti, testi di astronomia, psicologia, romanzi, volumi d’arte. Dormirò quando gli occhi vorranno chiudersi, sarò desto per il resto del tempo: a meditare, osservare, a mandar via veleni, patologie mentali, la depressione.
Ho con me Maddalena. I suoi anni lievemente le stanno addosso, la pelle non ha segni di noia esistenziale, il sorriso comunica ogni volta inviti maliziosi a dimenticare il passato, dolori e ansia, sgarbi e rese ai prepotenti, scuse non dovute, desiderio di male, voglia di egoismo.
Ho con me la passione originata dalla riflessione su un rapporto esausto per una lunga parentesi di torpore comune, riesploso prodigiosamente e salito di tono, di intensità, di veemenza, di euforia.
Ho con me la vita e devo nulla a nessuno.
Dimmi, quanto mi ami?
Quanto ti amo… mah… tanto
Dillo meglio
Ti adoro, sei la mia vita, così?
Tutto qui?
Che altro… ah sì, non vivrei senza di te
Dove è finita la tua creatività?
E dove è finita, ma nella pochezza del vocabolario
O nella pigrizia?
Non mi appartiene, che dici…
Che mi deludi
Perché non ci provi tu?
Perché no…
Chissà, ho sbagliato a venire con te in questo paradiso della solitudine, torno a Seattle, addio
Buon futuro
Avevo dodici, forse tredici anni. Era il mio tempo dei sogni. Stentavo a prendere sonno. Avevo voglia di dormire, ma anche di non interrompere il percorso fantastico di storie virtuali eppure vicine alla realtà da esondare con prepotenza nell’anima e impedire alla macchina del sonno di fare il suo lavoro quotidiano. Un canion maestoso: grigi tenui i alternanza con grigi cupi, vicini al nero nelle gran di crepe che al loro culmine, accecate dal sole brillano nei minuscoli frammenti ferrosi sul letto dell’argilla ocra di superficie. Incontro picchi e precipizi vertiginosi. Respiro accelerato, incontrollabile, affanno da sfida all’ultimo video game, velocità esasperata, arresti imprevisti e lucide percezioni dell’intorno, giù, su, lateralmente. La quiete arriva imprevista, stupefacente, con un’immersione emotiva nel silenzio che azzera le intemperanze di neuroni iperattivi iperattivi, frenati a lungo da antico psicopudore.Una gola aspra, minacciosa, si slarga in un ampio recesso tra due ali di roccia disegnata dal vento per sollecitare fantasie visive e suggerire profili umani, corpi di animali preistorici, combinazioni astratte, nei suoi graffiti appena percepibili. Dalle grandi volte vengono giù massi di terrorizzante dimensione. Hanno dapprima occupato il fondo del crepaccio per diventare piramidi informi, raggiunti da pietre e terra. Immobile, statuaria, la figura di un uomo, avvolto in un mantello di lana greggia, la capigliatura incolta raccolta in un copricapo a larghe tese, si separa per magia dal sasso piatto su cui siede con la schiena superba, perfettamente eretta: è scura la pelle del viso, il naso adunco separa occhi obliqui, da mongolo, eppure verdi come giovani figli di abeti. Tra due pietre simmetriche arde la brace di un fuoco alimentato appena perché non muoia. Per ora è un inverno solo annunciato. Son via i mutiscofii, lungo canali di fuga istintivi che s’immettono nelle correnti ascensionali temperate e agganciano le terre del caldo, dove svernare. Le pinne dolgono infine di un viaggio senza scali in acque ostili di mari inospitali. Aspra, l’ascesa chiede fatica, ma regala in ogni tratto paesaggi d’incanto, colori sempre più accesi. Il volto di Maddalena è più ombra che luce, ma fiero. Bellissimo.
Ciao Mad, amo il tuo viso, per le rughe che lievi lo segnano, per gli occhi che accolgono ogni introspezione perché mi sia concesso di guardarti dentro e scendere nella tua anima.
Un sentiero, tra mille, per andare lontano e per sempre. Duro essere desti.
———————————————————————————————————————————————————————
Il Racconto di Domenica 4 giugno e di Domenica 28 maggio
Prima e seconda parte
JONICA – Prima parte
di Luciano Scateni
Sono lunghi e prensili i tentacoli della ‘ndrangheta e trasmettono con frequenza virale il dogma della violenza sanguinaria, il gene della prepotenza e del disprezzo per l’altro che non sia affiliato al proprio clan. Succede davvero che si spengano vite per un niente che nella testa malata dei boss diventa condanna di morte. Era così nella Sicilia di cosa nostra, nell’immondezzaio della camorra delle esecuzioni eseguite da manovali del crimine per una manciata di soldi. Il crimine non ha più confini, esteso con lunghi tentacoli da Nord a Sud del Paese e oltre i suoi confini. Pure una sua specificità più animalesca è ancora insita nei luoghi d’origine della malapianta. Per esempio nell’istmo dell’Italia dov’è più stretto lo stivale, sotto la tirannia della ‘ndrangheta.
È un mare generoso, anticipato da terra invece avara, non una goccia d’acqua di suo e da larghi lembi di sabbia impalpabile, bianca per lunghi tratti, altrove grigia, per prevalente presenza di minerali ferrosi: ricca di conchiglie striate, madreperlacee. Stupefacente diversità con la monotonia “adriatica” dello Jonio, in vista delle “Castella”, che s’inoltra nel mare con il maniero scelto per alcune sequenze della satira di “Brancaleone”, è l’oasi litoranea di spiaggia caraibica dirimpettaia di una scogliera sommersa che riserva ai sub ritrovamenti di anfore romane e ancore d’epoca nelle acque di suggestiva trasparenza. Non è terra di pescatori che per sporadiche eccezioni e di non antica tradizione, ché qui, un tempo, le marine erano rifuggite, esposte alle violente scorrerie di predatori.
Gli insediamenti abitati erano ritratti al culmine di luoghi aspri, preceduti da tortuose risalite segnate da stretti sentieri, lande che si negavano all’ evoluzione, chiuse in un ostinato isolamento, nel loro dialetto ermetico, in microcircuiti paesani governati da leggi non scritte, monopolio del capofamiglia di rispetto, imposte di generazione in generazione.
Così era organizzata la difesa da assalti e agguati proditori, improvvisi raid sulle coste violate di Calabria, nel ventoso golfo di Squillace, quasi mai quieto e temuto dai naviganti d’ogni tempo che molto hanno immolato al suo mare, come stupefatto può osservare, trovandone tracce, chi si immerge con respiratori e muta a buone profondità, in vista del capo Colonna e ancor più di isola capo Rizzuto.
Qualche rada casupola di marinai s’è vista circondare di blocchi cemento anonimi, edificati da capomastri incolti e firmati dalla genia di geometri non meno disinteressati all’estetica dei manufatti. Sono parallelepipedi mai definitivi, con le coperture forate da tondini di ferro arrugginiti, in attesa di armare superfetazioni abusive. Sulle spiagge, imbrattate dai bagnanti della domenica, si accumulano rifiuti d’ogni genere, animate nei week end da rivendite ambulanti di panini e bibite infilate in secchi colmi di ghiaccio. La Jonica parallela alla costa è stretta tra la ferrovia locale e le colline arse dal sole. Ai due lati del corso di borgate senza qualità, si susseguono botteghe alimentari, la farmacia e il comando dei carabinieri, annunciati da targhe in plastica, a sera illuminate da neon a luce fredda e la chiesa, dove dice messa un prete condiviso da altre frazioni del comune insediato al culmine dell’erta che s’inerpica ardita.
La «littorina» corre tra scarni filari di ulivi piantati nella terra a larghe zolle spaccate dal sole, che imbianca le chiome. Prima della distesa sabbiosa, un tratto di terra, più polvere che terra, consente miracolosamente di alimentare gigli di spiaggia e rovi spinosi. Qui la speculazione ha eretto casupole come celle di alveari in cemento e pretenziose villette con immancabili citazioni di orpelli moreschi o merli spagnoleggianti, cupole arabe, finte guglie, protette da pesanti cancellate che includono i pochi metri quadrati di terra brulla, interrotta da girasoli sofferenti.
L’insieme anticipa il disastro di sistematiche devastazioni, pomposamente definite “Costa Morena”, “Villaggio Magnolia” nell’illusione di ingentilire il massacro delle coste. La pericolosità della Jonica, incompatibile con la velocità di automobilisti spregiudicati è tragicamente visibile nelle edicole in memoria delle vittime della strada. Un paletto, infisso nel terreno ai margini della carreggiata, sostiene la piccola tettoia di metallo che protegge le fotografie deí morti, racchiuse in cornicette di plastica parzialmente coperte da fiori di campo appassiti. da garofani appassiti.
Inoltrandosi all’interno, anche solo per una decina di chilometri, non è raro incontrare le bocche d’acqua della Sila, leggera, fredda da far male ai denti. Sorprende la ricchezza del getto e fa riflettere su una terra che potrebbe conoscere picchi di fertilità, invece afflitta dalla siccità che condanna la fatica dei contadini. Laddove la proprietà dei terreni è in pace con la ’ndrangheta l’irrigazione è generosa. E’invece avarissima per chi rifiuta la protezione malavitosa.
D’inverno la vita è vuoto susseguirsi di mesi, apatica parentesi tra un’estate e l’altra, in attesa dei forestieri, delle automobili targate Torino e con targhe tedesche, svizzere, degli emgranti che tornano per le vacanze d’agosto.
Al primo sole che toglie dalle ossa freddo e umidità malamente contrastata con il braciere tra le gambe, zio Rocco scende alla marina e inizia il lavoro di rifinitura dello consunto gozzo che ogni anno fatica a rimettere in sesto perché possa prendere il mare. “Antonia” è il nome della barca. Ogni cosa è al suo posto. Sotto il telo impermeabile i remi, con l’impugnatura liscia come velluto dopo tanti anni dello sfregare tra le mani nelle manovre di allontanamento e avvicinamento nella piccola rada riparata dalla scogliera.
Il lavoro porta via due settimane piene, ma infine il legno prende contatto con l’acqua e il motore s’avvia borbottando entrobordo con qualche colpo a vuoto e un paio di preoccupanti arresti. Zì Rocco ha i pantaloni arrotolati fino al ginocchio. Il contatto con l’acqua ancora gelata gli ha procurato un brivido, che ricorda il rito di ogni nuova sortita stagionale in mare. Una gamba è già dento il gozzo, l’altra fa leva sul basso fondale per distaccarlo dalla riva. La mano governa il timone su rotte familiari, gli occhi attenti a semplici coordinate: il vertice di una collina, inconfondibile per la presenza di due querce appaiate, la casa colonica di don Pietro appena visibile oltre il generoso vigneto e la punta di “Le Castella”, protesa nel mare imbiancato dal libeccio.
Il mare. Di nuovo quel gusto di starci su con i propri pensieri e lo stupore per trasparenze incontaminate che consentono di riscoprire le larghe macchie verdi di alghe ondeggianti, gli intervalli della scogliera bianca dove saraghi e ombrine si aggirano sospettosi, le rocce ricoperte di muschio e patelle, colonie di ricci dalle punte candide.
Zi Rocco respira profondamente e corregge la direzione a memoria ogni volta che si fa strada il ricordo di una giornata di pesca abbondante, su una secca prodiga, o al limite di un’insenatura delimitata da formazioni scogliose a imbuto. Un paio di miglia prima della bella spiaggia che anticipa l’approdo nel porticciolo di “Le Castella”, le piccole imbarcazioni come il gozzo di Zi Rocco evitano il periplo di un promontorio e sfiorano di precisione le pareti interne dell’arco naturale che la gente del posto chiama semplicemente “grotta”, a capo chino per non batterlo sotto la bassa volta. L’anziano pescatore vi si infila di precisione, un remo pronto a far perno sulla roccia.
Appena riguadagnato il mare aperto la prua dell’“Antonia” ha un sussulto. L’urto non preoccupa eccessivamente il vecchio perché qualunque sia l’ostacolo con cui la barca è venuta a contatto non dovrebbe averla danneggiata. Lo sguardo segue per un attimo la sagoma del grosso fagotto, stretto da spago catramato, che dopo l’urto si è distanziato di un mezzo metro dallo scafo e che ora gira lentamente su se stesso.
Sarà lungo un paio di metri, largo meno della metà. Con un’ampia virata zì Rocco torna indietro tenendo il motore al minimo dei giri, finché il gozzo viene a trovarsi in prossimità dell’involto. Qualche colpo di remi sapiente e la fiancata della barca gli è addosso. Un tanfo orribile spinge il pescatore a mandarlo via con la punta di un remo. Poi ci ripensa. Vince il senso di nausea e annoda una corda allo spago, concede un buon margine alla fune e lo rimorchia in direzione della porticciolo di dove è partito. Per un momento gli vien voglia di mollarlo. Disgusta il fetore insopportabile e ha la meglio il timore di aprire l’involucro. La barca approda nel porto di “Le Castella”, protetto dal molo artificiale. Appena a terra zi Rocco dirige verso la stazione dei carabinieri perché se la sbrighino loro. Sulla spiaggetta ingombra di scafi tirati a secco c’è un fitto capannello a discutere di quell’involto serrato come un salame da una corda di canapa, di quelle che sono dotazione di barche da diporto. Gli uomini si tengono a distanza, respinti dall’acre odore che emana e più d’uno si aspetta di vederne uscire un corpo putrefatto, una carogna d’animale in disfacimento. E’ senza dubbio l’evento più eccitante capitato in paese dopo l’arrivo della troupe cinematografica che proprio qui ha girato alcune scene dell’ “Armata Brancaleone” che hanno movimentato la quiete primaverile del borgo marinaro. Il più fantasioso tra i commentatori è Peppe Cutino, giovane gestore del ristorante “La Scogliera” che non poche villeggianti giudicano affascinante al punto da concedergli un’intimità per nulla platonica.
Peppe ha vaga somiglianza con il saraceno che a mezzo busto, sulla colonnina di gres, domina la piazza del paese. Si accalora, gesticola, per far prevalere la sua ipotesi sul giallo del fagotto. “Non può trattarsi che di Carmelo Iapicca, di cui si è persa ogni traccia un anno prima”. Tutti sanno che il mafioso, originario di Cutro, ha sfidato don Ninì Calogiuri, padrone incontrastato del crotonese, intollerante di ogni trasgressione a una sovranità conquistata a colpi di lupara e di amicizie altolocate.
Zì Rocco trotterella al fianco del maresciallo Migliaccio, che precede due giovani carabinieri ancora pesci fuor d’acqua per il trasferimento traumatico dal Veneto alla Calabria. Si apre a ventaglio l’assembramento dei curiosi e T’appuntato Tonino Macri infila la lama di un lungo coltello, legato in cima a una canna, fra il telo e la corda.
I lembi del tessuto plastificato si aprono e scoprono due corpi nudi, addossati frontalmente, uniti in posizione oscena. Un uomo e una donna, l’uno corpulento, di media statura, capelli neri riccioluti, piuttosto lunghi, un intricato tatuaggio sul braccio sinistro che attorno al nome “Maria” dai caratteri svolazzanti, si aggroviglia in decorazioni floreali come una corona mortuaria; la donna, si direbbe giovane, è bionda, capelli lisci, molto corti. Per quel che consente di intuire il gonfiore della putrefazione era longilinea e prosperosa. Stretto da ferire la carne, un filo di ferro tiene insieme i due corpi all’altezza della vita, la testa dell’uomo poggia sulle spalle della ragazza.
Teresa, la sarta del paese, porge al carabiniere un vecchio lenzuolo che, steso sulla sabbia, accoglie i due cadaveri. Adagiato sul sedile posteriore della jeep, il macabro carica viaggia alla volta di Crotone.
SECONDA PARTE
La statale Jonica s’inerpica per la breve ma ripida salita che conduce alla deviazione di Isola Capo Rizzuto, un sito improvvisamente dilatato oltre l’angusto perimetro dell’antico insediamento da un’espansione residenziale per il turismo estivo che affastella case su case, villette, piccoli alberghi e camping, interi villaggi, senza alcun disegno urbanistico, indifferente al disordine, irrispettoso di vocazioni e tipologie secolari. Isola, nel suo caos incontrollato, accoglie sbandati e balordi d’ogni parte d’Italia e negli anni settanta diventa rifugio stagionale di terroristi e di frange sparse dell’estrema sinistra, di naturisti e omosessuali che si autoconfinano in campeggi magari poco organizzati ma tolleranti la loro diversità. In particolare si segnala un’estate, a ridosso dell’infittirsi di atti terroristici e della conseguente ventata repressiva. Il camping “Freedom” deve sopportare un vero assedio. Trecento uomini circondano la tendopoli, quattro motovedette puntano le mitragliatrici in direzione della spiaggia e due elicotteri volteggiano in cielo, picchiando all’improvviso sul campo con effetti terrorizzanti. “Freedom” è sgombrato per motivi di sicurezza, decine di ragazzi e ragazze sono rispediti ai luoghi di provenienza. Per una quindicina di campeggiatori senza documenti c’è il fermo di quarantotto ore, l’identificazione, la diffida. Venti sono denunciati per possesso di sostanze stupefacenti, due vengono arrestati per detenzione di armi e per tutti c’è l’invito perentorio a non mettere mai più piede a Isola.
Qualche anno più tardi è il paese intero a ribellarsi all’annunciato raduno di gay. Si organizza un corteo di protesta e alfiere del “no” è il sindaco, un comunista di vecchia data che si è ideologicamente formato in tante battaglie al fianco dei contadini, contro latifondisti arroganti e la polizia al loro servizio. Il far politica ha i suoi prezzi e il primo cittadino non se la sente di rischiare l’impopolarità con un atteggiamento libertario che la gente non capirebbe. Reagisce l’opinione pubblica nazionale, affiancata dalla grande stampa, i gay la spuntano e affluiscono a Capo Rizzuto, ma rinunciano alla minaccia di marciare in paese completamente nudi. I ragazzi di Isola vanno a spiarli di dietro il canneto che protegge il campeggio e la larga spiaggia su cui s’affaccia a sbalzo. L’adozione del nudismo è un segnale dell’atteggiamento esibizionista di una parte di omosessuali che però contagia tutti gli altri. Il racconto dei guardoni tiene banco tra i compaesani meno intraprendenti e si colora di invenzioni, forzature, interpretazioni soggettive. Perfino il parroco è costretto a occuparsene nell’omelia domenicale. Invoca i sentimenti del pudore, della morale, fino a soddisfare il bigottismo delle donnette che inginocchiate nelle prime file di panche rappresentano l’uditorio più assiduo e partecipe della chiesetta.
Oltre Isola, il rettilineo della “Jonica” corre parallelo al vecchio aeroporto, ridotto a pista per rari charter, a sporadico approdo di trasporti militari, a sede della sparuta combriccola di soci dell’aeroclub. La periferia di Crotone appare subito dopo il passaggio a livello che s’oppone a un accesso spedito alla città. Due ali di edifici, non belli ma dignitosi, sono il prologo della nuova edilizia che contrasta ostentatamente la costante dei due, tre piani del corso principale, rispettosi rispetto della vita sociale, una volta molto più quieta. Se ne scorgono le estreme propaggini prima che sopraggiungano ciminiere e sbuffanti campanili di fabbriche chimiche sorte in prossimità del porto, con i suoi carghi in attesa. La jeep infila di slancio il varco custodito dell’ospedale civile e aggira il corpo di fabbrica brulicante di visitatori, ciascuno appesantito da buste di plastica con generi di conforto per i degenti, sul volto la consapevolezza di accedere a luoghi di sofferenza. Sul retro dell’edificio un basso cubo di cemento ospita l’obitorio e l’appuntato dei carabinieri non nasconde il senso di sollievo quando si libera del carico, preso in consegna da un paramedico dalla faccia smunta, da becchino.
Non vi sono tracce di violenza sui corpi e neppure lesioni interne o tracce di veleni, droghe. In conclusione, il responso dell’autopsia è inequivocabile. Morte per asfissia da annegamento. L’età presunta dei morti è compresa tra ventidue e trent’anni, la permanenza in mare non dovrebbe aver superato i sei giorni.
Doppiata la punta della Campanella, il “Gabbiano” stringe a sinistra per portarsi velocemente a ridosso di Capri e costeggiarla fino al riparo del porto. Non è mare da traversate tranquille. Le onde crescono minacciose e le correnti insidiano la stabilità dell’imbarcazione da diporto. I suoi ottocento cavalli entro bordo riescono a sviluppare appena una metà della potenza accreditata e a bordo il governo del timone richiede la massima concentrazione per non offrire il fianco alle onde. Sul ponte è un’ impresa sopportare impennate e ricadute dello yacht, soprattutto quando il vertice di un maroso si congiunge con la coda riemergente dei precedenti.
L’avvocato, a gambe larghe, è saldamente aggrappato al corrimano d’ottone, in coperta, giaccone impermeabile chiuso al collo, a difesa del vento pungente e delle sferzanti raffiche d’acqua sollevate dalla prua che solca il mare in subbuglio.
Giuseppe Bonfiglio interpreta con convinzione il ruolo di padrino dalla irreprensibile copertura sociale.
Il suo studio legale è tra i più accreditati e la sede centrale, a Catanzaro, è stata largamente sopravanzata dalla succursale romana. Bonfiglio si è fatto un nome come esperto di una materia che appassiona categorie di imprenditori interessati alla legislazione sui finanziamenti speciali per incentivare l’industrializzazione del Mezzogiorno. Dietro la facciata dell’attività ufficiale, non priva di sostanziosi profitti, si nasconde la titolarità di una banca clandestina che rastrella le risorse finanziarie della mafia, remunerate con interessi molti più favorevoli dei tassi riconosciuti dagli istituti di credito. Il banchiere ombra è anche specialista di investimenti azionari e partecipazioni a società multinazionali in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti e nei paradisi fiscali. Somme stratosferiche finiscono nelle sue mani di cassiere eccellente. Il loro possesso, seppure per delega, lo pone al vertice di un potere economico occulto che è l’altra Italia, capace di competere con quella legale.
Vito D’Angiò è l’agente di Bonfiglio in America. Figlio di Cosimo D’Angiò, uno dei soci fondatori di “Cosa Nostra”, ha frequentato con profitto gli stage di perfezionamento in economia della Princeton Uníversity. Si è fatto apprezzare in ambienti dove si decidono le strategie finanziarie destinate a modificare le dinamiche dei mercati internazionali della valuta, dove si condiziona l’andamento di Wall Street e si influenza l’economia mondiale. Vito si muove con abilità nella giungla della borsa, mette a segno magistrali colpi nel pianeta azionario, garantisce al capitale investito dalla mafia profitti ingentissimi.
L’inesperienza e velleitarismo prematuro, l’inducono a tentare qualche speculazione per conto proprio, adoperando parte delle somme di Bonfiglio disponibili tra un’operazione e l’altra. È Mc Gregor l’uomo chiave di questo mercato clandestino del denaro. Come un vero banchiere, ma con vocazione spinta all’usura, l’uomo d’affari finanzia chiunque abbia necessità di forti somme ed è scrupolosamente rigoroso nell’accertamento della solvibilità dei debitori. Non ha mai fallito un’operazione di recupero del credito, talvolta ricorrendo a sistemi non esattamente ortodossi. Strozzino in smoking, ricorre in via del tutto eccezionale a finanziatori collaterali, per non impegnare troppo del proprio capitale. Vito è diventato uno di loro e l’attenzione del giovane non è sufficiente a evitare una brutta complicazione.
 Don Giuseppe Bonfiglio è invogliato da un informatore americano a comprare una quota della Ellison Chemical Company che ha messo in vendita il cinque per cento del portafoglio azionario per finanziarie la conquista di un mercato vergine dell’Europa orientale. D’Angiò prende tempo. I venticinque milioni di dollari necessari all’operazione dovrebbero essere disponibili, se una buona parte non fosse finita nel giro di Mc Gregor. I tentennamenti del giovane insospettiscono il padrino e lo spingono ad indagare. Gli riferisce Carmine Affaitati, dopo aver consultato un paio di amici di New York che della borsa, e d’ogni evento di rilievo del mondo economico americano, sono a conoscenza per ragioni professionali nella qualità di presidenti delle due banche più attive della città.Un emissario di Bonfiglio vola in America con il mandato di mettere le cose a posto e di impartire al “picciotto” una lezione che lasci il segno. Arrigò non è nuovo a questi compiti speciali e si prepara a eseguirlo come sempre con meticolosità.
Don Giuseppe Bonfiglio è invogliato da un informatore americano a comprare una quota della Ellison Chemical Company che ha messo in vendita il cinque per cento del portafoglio azionario per finanziarie la conquista di un mercato vergine dell’Europa orientale. D’Angiò prende tempo. I venticinque milioni di dollari necessari all’operazione dovrebbero essere disponibili, se una buona parte non fosse finita nel giro di Mc Gregor. I tentennamenti del giovane insospettiscono il padrino e lo spingono ad indagare. Gli riferisce Carmine Affaitati, dopo aver consultato un paio di amici di New York che della borsa, e d’ogni evento di rilievo del mondo economico americano, sono a conoscenza per ragioni professionali nella qualità di presidenti delle due banche più attive della città.Un emissario di Bonfiglio vola in America con il mandato di mettere le cose a posto e di impartire al “picciotto” una lezione che lasci il segno. Arrigò non è nuovo a questi compiti speciali e si prepara a eseguirlo come sempre con meticolosità.
Doghe di legno verniciato dappertutto e ovunque un vapore denso che invade i polmoni e penetra a fondo la pelle lucida di sudore: la sauna è luogo abituale d’incontro per chi risolve i problemi di linea saltando il lunch e liberandosi di liquidi in eccesso e tossine. Vito sostiene a fatica il dialogo con Robert Parrish, conosciuto all’ultimo party molto esclusivo dei Murdock, una delle famiglie emergenti della New York che conta. Parrish riprende il filo di una proposta già accennata tra un Martini e l’altro, un mese prima. L’idea è di dar vita, nei Paesi occidentali a reddito più elevato a centri del divertimento che, ispirandosi al celebre modello disneyano, estendano l’offerta a una nuova serie di videogame, a linee di bibite, dolciumi, abbigliamento, musica. Ma Vito non ha vocazioni imprenditoriali e dunque segue l’interlocutore nel suo ragionamento per cortesia più che per interesse. Continua a tirar sulla spalla il lenzuolo di lino, ormai madido di sudore, che nasconde il tatuaggio di cui ha pudore in un ambiente che assegna molta importanza ai dettagli prima di accreditare qualcuno nel mondo dell’high society. È un ricordo sgradevole quel segno indelebile, perché evoca il tempo dei rapporti con una parte del mondo popolato di italo-americani collegati alla mafia.
La sagoma di Arrigò appare nell’arco della porta scorrevole e si intuisce il suo disagio, come di chi è proiettato in una realtà impropria, estranea. Il fiduciario di Bonfiglio si siede in un angolo e Vito riconosce istintivamente che di lì non possono venire che guai. Parrish lascia la sala, Arrigò non aspettava altro. “Domani, al Derrick Club, dieci precise. Vito, Don Giuseppe non sarebbe contento se non venissi all’appuntamento.
D’Angiò lascia la sauna con addosso i ben noti sintomi di ansia che da sempre si localizzano alla bocca dello stomaco con dolorose fitte e bruciore. Sono appena le undici del mattino ma nella circostanza è tempo di antidoti e cioè di un robusto bourbon per cacciar via pensieri fastidiosi: se ne concede un paio da “Charlie” che lo guarda sorpreso ma senza commentare l’insolito orario per mandare giù alcol. La giornata vola via in tentativi purtroppo vani di mettere insieme la somma che don Giuseppe intende investire e l’appuntamento dell’indomani appare sempre più come una scadenza senza scampo.
Purtroppo per il giovane finanziere il fulmine non arriva solitario e anzi precede una tempesta che si chiama Diana Jackson. La ragazza avrebbe dovuto sposare un ricco industriale del Dakota già da sei mesi, per obbedire ai progetti del padre che in questo matrimonio intravede il doppio vantaggio di un sodalizio utile alle proprie attività e di un buonissimo partito. Solo che lei, nel frattempo, ha deciso di amare Vito e per sfuggire all’impegno preso dal padre ha escogitato un attendibile pretesto iscrivendosi a un corso di specializzazione universitaria che prevede la frequenza obbligatoria a New York dove può stare vicina a Vito.
A cena con Diana, ecco un appuntamento inopportuno in un momento che non si concilia affatto con la mondanità e i sentimenti. Ma non c’è modo di disdirlo e il giovane, puntuale, chiama la ragazza al video citofono, alle venti precise.
Nevil Bronson, designato d’ufficio a sposarla, non ha mai sospettato di Diana. Attribuisce il rinvio del matrimonio all’ambizione della ragazza di realizzarsi, per non subire il ruolo della “brava moglie che aspetta a casa il partner occupato in affari importanti”.
* * *
Sul jumbo della TWA il personale di bordo si adopera per rendere la transvolata gradevole ai duecentottanta passeggeri del volo New York-Roma HO/2341. Vito d’Angiò deve affrontare una questione che gli potrebbe costare molto più della rappresentanza finanziaria della Famiglia negli Stati Uniti. In gioco è la sua vita, se non riuscirà a sostenere un’autodifesa convincente. Il padrino ha vendicato in modo cruento sgarri meno gravi anche se nella circostanza esiste un rapporto effettivo con il figlioccio che potrebbe mitigarne l’ira.
Accanto a Vito siede Diana. Con questa fuga potrebbe mandare in malora il matrimonio e le strategie aziendali del padre.
Arrigò se ne sta in disparte e censura dentro di sé la fiducia accordata al giovane finanziere. Non se l’è sentita di risolvere in prima persona la questione e preferisce che sia don Giuseppe a decidere come riportare Vito all’obbedienza del giuramento di fedeltà nei confronti della Famiglia.
*
Catanzaro. Città depressa, sempre caotica, invivibile, soprattutto disordinata in centro. Vito si districa con difficoltà alla guida dell’Alfa della Hertz che soffre il continuo procedere a rilento in un groviglio di automobili. Finalmente è in vista la villa di Bonfiglio, fuori della bolgia, come una oasi di quiete. Don Giuseppe è intento a potare i rosai e così, con il lungo grembiule blu e il cappellaccio di paglia calato sugli occhi, si direbbe un professore in pensione piuttosto che il re di un grande impero economico.
“Vito, accomodati, entra pure in casa, ti raggiungo subito”.
Il giovane cerca di intuire dallo scarno saluto l’umore del padrino, ma è sempre stato arduo decifrare la sua espressione ermetica e rinuncia.
“Vito, lo sai, amo poco parlare. Ti ho fatto venire fin qui per dirti che sei fortunato. Metto tutto nel dimenticatoio con un colpo di spugna, Vito, mi capisci? Ma è il primo e l’ultimo che ti concedo. Sistema ogni cosa. Tre giorni di tempo ti dò. Ora va, goditi la primavera calabrese con la tua femmina e quando torni a Nuova York telefona per dirmi che è tutto ok”.
Calabria da favola in questo momento di piena primavera che addolcisce i colori e veste di verde anche la terra brulla che l’estate brucerà inesorabilmente. Vito ha parlato alla compagna del suo Jonio, di terre generose e del mare incontaminato, delle splendide barriere naturali di ginestre dall’intenso color giallo e di odori, sapori altrove introvabili. Prima di rientrare in America vuole proprio che Diana veda i luoghi tante volte raccontati, forse enfatizzati dai ricordi dell’infanzia.
Capopiccolo, a ridosso di Isola, è un breve promontorio di sabbia e scogli di cui Vito conosce ogni centimetro. La stradina di terra battuta finisce con l’inizio della spiaggia, spesso tormentata da un soffocante scirocco, ostile ai piccoli gozzi dei pescatori, non al punto di scoraggiare brevi tragitti sotto costa per ritirare le reti sostenute a galla da bianche taniche di plastica.
Mimmo Schillaci era ancora in pantaloni corti e scalzo quando Vito lo ha salutato, fantasticando dell’America, prima della partenza. Ora è un omaccione temprato dalla vita di mare e il segno della sua mediterraneità è nel ventre gonfio, che trabocca oltre la cintura stretta sotto l’ombelico. Il riconoscimento, scarni racconti di vita, come usa fra gente di mare: la barca di Mimmo è a disposizione dell’amico “americano”. Gira tranquillo il vecchio diesel e Vito ritrova il gusto di stringere la barra consunta del timone, l’odore pungente della nafta che stagna sul fondo della barca, l’aria frizzante sul viso, l’attenzione alle coordinate che indicano la rotta più breve. Diana è gradevolmente sorpresa delle piccole cose di un mondo così distante dalla sua cultura di newyorkese e scopre divertita un inedito Vito. Dietro gli scogli del “cervo”, la spiaggetta “della creta”: sullo stretto arenile incombe una collinetta che frana a ogni acquazzone e deposita sul fondo del mare una coltre di pietre friabili che i ragazzi, d’estate, recuperano per ricoprirsene il corpo fin quando il sole l’essicca stirando la pelle che si imbianca fino a screpolarsi. Nella piccola insenatura, ben riparata alle spalle e sui due lati, il sole si fa sentire. Si spoglia Vito e Diana lo imita eccitata dall’idea di poter raccontare di aver fatto l’amore sulla sabbia di una costa che sembra fuori del mondo e invece non dista più di cinquecento metri dai casolari che incombono sulla collina di arenaria.
* * *
Nicola e Donato sono cresciuti assieme. Figli di due fratelli, hanno percorso in parallelo il cammino di scavezzacolli litigiosi e violenti, che forniscono ai genitori non pochi motivi di apprensione e qualche problema con i carabinieri. Fantasticano spesso di donne e di spavalderie da bravacci. Talvolta fanno seguire ai pensieri azioni violente, gratuite. Si eclissano appena possibile, per sfuggire al lavoro della campagna e uno dei luoghi d’incontro è lo spiazzo ombreggiato ai margini della proprietà dei genitori, dominato dagli ulivi secolari che con le loro antiche radici frenano in qualche modo il movimento franoso della collina. I due fratelli depongono ai piedi della pianta i fucili con cui si accompagnano nella stagione della caccia.
Don Giuseppe Bonfiglio non è riuscito a convincere l’assemblea dei soci che lo ha delegato a gestire i profitti della Famiglia e il verdetto non offre margini a deroghe. Vito deve essere eliminato, perché inaffidabile e perché sa troppe cose. La questione è assegnata a Carmine Affaitati che offre ampie garanzie di efficienza e riservatezza.
La partenza di Diana nel frattempo ha fatto perdere la pazienza a Nevil Bronson quando gli hanno riferito che si è involata con un certo Vito D’Angiò per l’Italia. L’industriale affida a Steven Bradley, uno tra i migliori investigatori americani, il compito di riportare Diana negli Stati Uniti e di non andare troppo per il sottile con il bellimbusto che l’ha convinta a seguirlo. Steven non volta le spalle a diecimila dollari. New York, Milano, Lamezia Terme. Mette piede in questa parte d’Italia deciso a risolvere rapidamente la questione.
Nicola e Donato Mazzara percorrono in equilibrio precario il viottolo in discesa che porta alla spiaggetta sottostante, attenti a non smuovere i massi friabili che la pioggia ha eroso alla base. L’uno dà di gomito all’altro quando oltre una stretta curva si scorgono i corpi di Vito e Diana, nudi e intenti a fare all’amore.
I due cugini finiscono il percorso con mille precauzioni per non richiamare la loro attenzione.
“Nicò, che puttana. Te la faresti, eh?”
“Me la farei? Ce la facciamo”
Vito tenta disperatamente di tenere a bada gli energumeni, ma di fronte ai fucili spianati non può che rassegnarsi e trattenere la furia che lo assale, soprattutto quando a turno costringono la ragazza a subire la loro libidine. Li minaccia.
“Fosse l’ultima cosa che faccio sulla terra vi scoverò e vi farò pentire di essere nati, bastardi”.
Sarà forse per questo giuramento di vendetta, o per la consapevolezza di averla fatta grossa, ma Nicola e Donato hanno davvero paura e il panico li spinge alla follia. Costringono i due giovani a immergersi in mare e li annegano tenendo le teste sott’acqua fino all’asfissia. Il filo di ferro è ben stretto attorno ai corpi, avvolti nel telo di plastica portato sulla spiaggia da una mareggiata. Il pesante involto è disposto nel gozzo e, una volta al largo finisce in acqua.
Gli inquirenti battono due piste titola la “Gazzetta del Sud” e in sommario sono indicati moventi e ipotesi sugli esecutori del delitto: “La mano della mafia dietro il duplice omicidio?” “Sotto interrogatorio esponenti della ‘ndrangheta calabrese, ma non si esclude la tesi del delitto su commissione per motivi passionali”. “Una strana presenza, quella di Steven Bradley, detective di New York”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 21 maggio
Luna argentata
di Luciano Scateni
Tribù nascoste al mondo, scovate da esploratori e colonizzatori, sfruttatori di risorse, rivelano il buono della mancata contaminazione da luci e molte ombre del progresso. Modi di vita istintivi, semplici, totale solidarietà nella gestione del poco che offre la natura, rispetto della saggezza e delle barbe bianche dei grandi vecchi, cura del corpo affidata alla conoscenza terapeutica delle erbe, culto del sole e della luna metronomi incontestati di alternanza delle stagioni: l’invasione degli “evoluti” scompagina la storicità del sistema tribale. Accade che la serenità di Magnolia, per il suo uomo “luna argentata”, ingiuriata da un “evoluto” riceva la purificazione secondo le regole della vendetta, proprie della tribù.
Cosa c’è nell’animo di “Magnolia”, cosa negli occhi di fanciulla senza infanzia lo sa soltanto il suo dio che misericordioso le indica la via dell’eternità per toglierle dalla pelle e dalla testa dolori, paura, impossibilità di sorridere.
Il villaggio di Kalampuri ha un centinaio di case-capanna raccolte attorno a un breve spiazzo di terra battuta che rari, ma intensi piovaschi, hanno impoverito di argilla, fino a scoprire aguzzi terminali di roccia ricca di ferro, striata di minerali rosso cupo, rugginosi. È senza un capo la comunità di Kalampuri. Maluti, mitico capo tribù, è morto intempestivamente, quando il giovane Buwati iniziava appena a studiare per diventarne l’erede e non aveva ancora superato le prove previste da secoli per dimostrare di possedere doti di condottiero.
Il veleno di una vedova nera era da troppo tempo nel sangue del vecchio guerriero, dal tempo dell’ultimo raid nel fitto della foresta, a caccia dí cibo per il villaggio. Seduto con la schiena poggiata a un “albero della tristezza” Maluti era cosciente a metà, spossato dalla febbre del delirio e dai crampi che tormentavano i polpacci e a risalire tutta la muscolatura prima di arrivare a fermare il cuore con uno spasmo letale.
“Che vita la mia?” chiede a se stesso Buwati. In stato di allucinazione da coca mette in circuito memorie e memorie, che si inseguono velocemente, dolorosamente nitide: padre e madre uccisi da un branco di leoni affamati quando ancora non si teneva in piedi da solo, l’adozione di una donna incapace di mettere al mondo un figlio, il faticoso percorso per lasciarsi alle spalle la vulnerabilità di senza famiglia, il dolore per la separazione violenta dagli affetti primari, la lotta per compensare la fragilità della solitudine. Altri pericoli miracolosamente scansati. Tutto alle spalle nel pieno della maturità. Infine l’amore di Magnolia “luna argentata”. Alta più di ogni altra, fiera, saggia come nessun’altra del villaggio. “Luna argentata” perché l’amore, la prima volta, era stato illuminato da una metà lucentissima dell’astro, in una notte d’incanto anche per le fiere e i rapaci, straordinariamente quieti, quasi consapevoli del rito che univa il suo corpo scultoreo alla giovane compagna.
Magnolia partorisce un figlio prima che gli dei della natura gli regalino Buwati, possente, protettivo, consapevole di essere destinato al comando.
È venuto di lontano l’uomo con la larga barba bianca e i suoi disegni pieni di linee incomprensibili, di rapidi coloratissimi schizzi. Si chiama Fabrizio e parla fitto, troppo per il compito del traduttore che s’affanna a sunteggiare senza perdere nulla d’importante del rapido profluvio di argomentazioni a favore della nascita di un nuovo villaggio ai margini della foresta, da costruire con strategie di congiunzione fra criteri antichi e adattamenti alla modernità.
“Magnolia” ascolta affascinata lo straniero di aspetto imponente, le dita scarne, ben curate, gli occhiali tirati via dal naso e sistemati tra i capelli ricci, il cappello a metà tra casco coloniale e paglia di Firenze. Lei si è allontanata dal villaggio una sola volta, per un viaggio fantastico, infinito, attraverso terre spaccate del sole, brevi intervalli di verde e laghetti di minime dimensioni, quasi pozze d’acqua che abbeverano gli animali per brevi periodi dell’anno, appena ingrossate da piogge scroscianti, ma di breve durata. La madre l’ha lasciata andare di malavoglia. É la figlia più grande, o meglio la meno piccola e appena uscita dalla pubertà ha partorito un figlio, invano scoraggiata dalla madre, sformata da troppe gravidanze e costretta a procurare il cibo per tutti dopo la morte del marito.
La vecchia ‘Ngami si è lasciata convincere a sperimentare la medicina dei dottori dopo aver inutilmente sperato che lo stregone guarisse la tosse che le schianta il petto e tinge di rosso la saliva. Le hanno detto che a Koinà c’è un santone vestito di bianco che fa miracoli con certi suoi rimedi moderni e prima di lasciarci anima e corpo la donna si avventura in un faticoso viaggio accompagnata dalla giovanissima nipote che per senso del dovere ma intimorita dal “mistero” di luoghi che non conosce. Cosa troverà a Koinà? Chi c’è stato racconta di case su case e di gente addosso alla gente, di frastuono assordante, di automobili e motorette che corrono pericolosamente tra i passanti. La città si annuncia con il profilo di tetti e terrazze così denso da nascondere l’orizzonte e il tramonto che Magnolia non manca di vedere ogni sera, appena oltrepassato il perimetro del villaggio, dove la foresta s’interrompe per dar spazio a una radura sconfinata. Di lì apprezza il chiarore accecante che accompagna la rapida discesa del sole oltre l’orizzonte. Tocca a lei, alla sua inesperienza, il ruolo di guida e la scelta di continui aggiustamenti di rotta. Una volta entrata in Koinà chiede a mendicanti e ambulanti che stentano a vendere la loro povera merce fuori del perimetro che racchiude il caos della città.
Lo studio del dottor Tamuri è in cima alle scale di un piccolo, pretenzioso edificio bipiano dove convive con un imprenditore del mattone arricchito dalla crescita urbana di Koinà e dalla trasformazione sociale che spinge gli abitanti a nuovi modelli di vita proposti dalle suggestioni di programmi televisivi.
Bravo medico Tamuri, ma privo di etica professionale e ancor meno di moralità. Visita con scrupolo la vecchina e la diagnosi, poco impegnativa, è di pleurite mal curata che ha letteralmente rovinato un polmone. Antibiotici, riposo, buona nutrizione e “tornerai come nuova”. Lo sguardo del medico si è già posato un paio di volte sulla bellezza sensuale di “Magnolia” e la giovane donna si è sentita addosso quegli occhi libidinosi, paralizzata da un disagio sconosciuto, destabilizzante. Vorrebbe sottrarsi ai complimenti dell’uomo, guardare altrove, essere in un altro posto, ma la vecchia ‘Ngami sembra sia orgogliosa di una nipote che suscita interesse in un uomo tanto importante. Tamuri racconta di certi suoi giri nei villaggi per dare una mano a quanti non conoscono ancora i prodigi della medicina moderna.
“Verrò anche da voi, presto”. La mano si posa sul capo di Magnolia, scivola sulla spalla e sul braccio nudo fino a incontrare la mano e la stringe. Il pollice carezza il palmo e sfiora le dita prima di lasciarla.
Finalmente la via del ritorno, in corpo emozioni forti, smarrimento, ricordi troppo freschi per tornare alla serenità di sempre. Il caos della città, il traffico, le ragazze vestite con gusto, ben pettinate, indosso abiti sgargianti che modellano le forme fino alle anche per ricadere ampi sulle caviglie; magazzini affollati, banchetti in strada con ogni bendidio, automobili rumorose e ciclomotori, biciclette, l’insegna di un cinema all’aperto, bar sempre pieni di avventori e sguardi sfacciati dei ragazzi, occhiate di sufficienza di certe donne meglio vestite. Povertà. Bambini in abiti laceri chiedono qualche soldo ai passanti, dappertutto facce scavate dalla fame e dalla fatica. In un negozio di oggetti per lo più sconosciuti a Magnolia, le immagini di un televisore acceso che ammicca da un luogo pieno di luci e colori, animato da ballerine mezze nude e musica di accompagnamento a tutto volume.
“Ma cosa è meglio…l’isolamento del villaggio, i suoni familiari della foresta, i giochi rumorosi dei bambini zittiti dai vecchi, le capanne buone solo per dormire e fare l’amore, i pericoli della boscaglia che precede a est la grande distesa di alberi secolari… o le suggestioni della città?”. Luna argentata si perde nel labirinto di pensieri contaddittori.
Sconcerta l’aspetto di Kalampuri. Magnolia lo giudica per la prima volta misero, angusto, arcaico, tagliato fuori dal mondo che corre verso il futuro, in lutto doloroso.
Maluti se n’è andato con la dignità del capo invitto, che il veleno ha piegato a fatica e spento la sua fierezza, perfino la resistenza al dolore. In punto di morte il vecchio capo ha radunato i saggi, le donne più avanti negli anni e Buwati, destinato alla successione.
“Il dio che protegge la nostra terra mi chiama e mi offre il privilegio di raggiungerlo nelle terre lontane dove non c’è bisogno di cacciare per sfamarsi e dove crescono alberi sempre carichi di frutta, dove da una pianta colorata d’oro sgorga un nettare che disseta e nutre e libera il corpo da ogni male, la mente da pensieri funesti. Chiederò ai nostri dei di accogliere tutti voi quando il suono del vento tra le foglie annuncerà la partenza dalla vostra terra e dagli affetti di questa vita. Buwati, dico a te. Il destino ti ha sottratto il tempo necessario a completare pienamente la tua maturità. Tra qualche istante ti lascerò e dovrai imparare in fretta a guidare il villaggio con saggezza e con la forza che chiede il ruolo di mio erede. Ora rivolgi gli occhi al cielo e invoca tutte le divinità perché proteggono il mio lungo viaggio”.
Il dottor Tamuri mantiene la promessa e annunciato da un mercante di cianfrusaglie che batte a tappeto tutta l’area, arriva a Kalamburi nel bel mezzo di una pioggia torrenziale, insolita per violenza. Il villaggio sentenzia che la coincidenza è di buon auspicio. Significa che il medico porta con sé la fertilità.
In una capanna di maggior ampiezza si improvvisa l’ambulatorio e un prezioso bidone d’acqua è sacrificato per le esigenze del dottore. Tamuri osserva chiunque voglia sottoporsi al controllo della magia moderna, propina farmaci e dispensa generosamente consigli. Chiede poi di Magnolia.
“È una ragazza prosperosa. E’ venuta al mio studio di città con la nonna e le ho promesso che l’avrei visitata. L’aspetto non mi è piaciuto del tutto e vorrei capire se ha qualche male nascosto”.
Esattamente il contrario: è proprio lo splendido aspetto di “Luna argentata” che gli è rimasto nella mente e ha provocato una strana eccitazione di cui non è riuscito a liberarsi.
Ora gli è davanti, con gli occhi bassi, che guardano le irregolarità del terreno e più in là, il cesto capovolto su cui poggiano oggetti sconosciuti e scatole con scritte incomprensibili.
“Come ti chiami, quanti anni hai?”
Non risponde “Magnolia”. Non sa neppure perché, ma d’istinto sente di doversi difendere dall’omaccione occhialuto che prende le mani tra le sue e l’avvicina a sé. Sente il respiro pesante dell’uomo, lo sguardo addosso, l’acre odore di sudore che gocciola dalla fronte e si perde nella polvere della capanna. I seni di “Magnolia” sono acerbi, il corpo snello ancora non denuncia le deformazioni che la vita del villaggio provoca in tutte le donne dopo i quindici anni e l’esito della gravidanza. Il medico prova a distogliere lo sguardo, a impegnare la mente in pensieri lontani dal desiderio di far sua la donna che gli sta di fronte. Prevale l’eccitazione. L’urlo di “Luna argentata” arriva alle orecchie di Buwati e sembra il grido di un’animale ferito a morte. Il giovane capo di Kalimburi irrompe nella tenda e capisce in un attimo cosa è accaduto. La sua donna è in terra. la veste lacerata, il segno di un graffio prolungato tra i seni.
Il medico ha gli occhi accesi di libidine, non meno di paura. Si ritrae sul fondo della capanna, saggia la resistenza della parete d’argilla, tenta una via di fuga, ma il suo tempo è andato. La lama affilata del machete di Buwati punta dritta al suo cuore e lo spegne.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 14 maggio
INCANTO FLEGREO
di Luciano Scateni
Il Padre Eterno, in un impeto di divina creatività ebbe alta ispirazione nel prolungare le meraviglie del golfo di Napoli, al litorale da Bagnoli al Capo Miseno, per molte peculiarità perfino più fascinoso. L’uomo non ha capito di che dono fosse investito e di una meraviglia della natura non ha saputo trarre vantaggio. Nonostante l’incuria, l’oziosa passività nell’ottimizzare questo ben di dio, i Campi Flegrei sono comunque una delle proposte più avvincenti dei dintorni di Napoli. Andarci, per credere.
È magia ovunque nel territorio dei Campi Flegrei. Navigando, incontri corsie d’acqua blu intenso, azzurro luminoso, verde smeraldo. Sfiori scogli lavici porosi o piatti, levigati dall’impeto del mare, di un biancore accecante, per lampi di luce che il sole spara bucando l’acqua di superficie, mossa appena dal grecale delle prime ore pomeridiane.
In prossimità di estese secche, creste spumeggianti si alternano a livide depressioni color lavagna dei fondali ricoperti di alghe violacee. Fascino alternativo, egualmente emozionante soprattutto in autunno inoltrato, è offerto dalle giornate con forti folate di libeccio che gonfiano altissime onde e da terra offrono suggestioni spettacolari ma arrecano rinnovati timori a chi naviga. Impegnativo e ostile, il “mare di sotto”, che pescatori esperti pronosticano per cicli di tre giorni, costringe all’ ormeggio le “cianciole”, in attesa di quiete notti non stellate, le più favorevoli alla pesca.
Sono terra stregata i Campi Flegrei. Se la sfiori con la prua della barca parallela alla costa, sorprende la metamorfosi camaleontica del tufo che muta colore per assecondare il tragitto a centottanta gradi del sole nell’ arco totale del cielo. Bruno all’ alba, macchiato di verde scuro per muschi intrisi di salsedine e dorato al mattino, vivido, dove attecchisce la vegetazione marina che lo ricopre tenace, giallo, straripante energia, appena prima del ritrarsi del sole quando ruba alla tavolozza il rosso tiziano riflesso nell’ acqua e accende i toni rapidamente cupi del mare.
 Questa terra è sapori e odori antichi nelle povere case della cosiddetta architettura spontanea, circondate da orti e pergolati di viti generose, assolate dall’ alba al tramonto, cariche di acini che finiscono in bianchi soavi e rossi cardinalizi per celebrare la “Falanghina” e il sontuoso “Pere ‘e palummo”.
Questa terra è sapori e odori antichi nelle povere case della cosiddetta architettura spontanea, circondate da orti e pergolati di viti generose, assolate dall’ alba al tramonto, cariche di acini che finiscono in bianchi soavi e rossi cardinalizi per celebrare la “Falanghina” e il sontuoso “Pere ‘e palummo”.
E’ antica armonia il succedersi di terrazzamenti arditi che compensano l’andamento brusco delle colline e guadagnano buona terra vulcanica per i filari ordinati di pomodori e verdure rigogliose.
Inquietanti sono gli sbuffi nervosi di gas che imbiancano i margini della solfatara, le sponde di pozzanghere limacciose dove ribollono i fanghi e s’impennano magmi emessi da piccole bocche eruttive.
L’aria si satura dell’ odore pungente dello zolfo, testimone di quanto si muove nelle visceri della terra flegrea per congiungersi a più consistenti profondità con la linfa esplosiva dell’ area vulcanica del Vesuvio.
C’è magia nelle storie che i vecchi raccontano. Dicono di relitti affondati dinanzi alla spiaggia di Baia, dove i sub raccolgono preziosi reperti di merce perduta dalle navi romane. Sono imponenti i resti del porto e delle ville nobiliari. Teste, busti e corpi quasi intatti di statue, custoditi dal mare per oltre duemila anni, emergono ad opera degli archeologi con sospetta tempestività, quando è tempo di avanzare richieste di finanziamento per proseguire nelle esplorazioni.
Affascina e atterrisce la profondità del lago d’ Averno, regno di Plutone, di dove la leggenda racconta che chi ha meritato la dannazione eterna accederà agli inferi per via diretta.
Che altro, se non la magia, accompagna il visitatore nell’antro della Sibilla e lo avvolge nel buio interrotto da oblique lame di luce che cadono dall’ alto.
A sorvolare i Campi Flegrei in aereo, nel finale della tratta Milano-Napoli, c’è di che stordire i sensi. Da altezze ridotte, in avvicinamento a Capodichino, è spettacolare la successione di immagini delle isole di Ischia, e Procida: scavalcata la collina di Posillipo, del lungomare, appena sfiorato della via Caracciolo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 7 maggio 2017
Genevieve
di Luciano Scateni
Storie da “Vita in diretta”, da pomeriggi con Barbara D’Urso. da gossip di settimanali patinati editi da Cairo. Storie di tutti i giorni, concluse con la disinvoltura di un’alzata di spalle, ma almeno estranee alla cronaca di violenze dei maschi ripudiati da fidanzate, mogli e amanti. Storie di ordinaria routine in un tempo che tutto permette e tutto nega. Storie banali, esemplari di diffusa anarchia dei comportamenti, ma anche di contrasto a rapporti affettivamente finiti e tenuti in piedi come prigioni a vita. “Per quieto vivere” e “non dar scandalo”.
Dita nervose, agili. Volano sui tasti. Sembra non sappiano dove fermarsi, eppure il complesso disegno delle note carezza con precisione maniacale ogni frem dell’immenso tesoro di creatività che Rudy ha nel Dna. Neppure uno sguardo alla terza fila, accecato dalla tagliente dello spot proiettata sullo Steinway e le mani bianchissime, sull’abito appena stirato con amore dalle mani d’oro di Maria, preziosa collaboratrice domestica, sulle scarpe lucide che riflettono i monumentali piedi del pianoforte.
Nella poltrona in prima fila Geneviève ascolta le note che conosce a memoria. Nessuna emozione per il fluire frenetico dei percorsi mentali che Rudy interpreta lasciandosi andare al piacere dell’improvvisazione, a costo di sacrificare l’impianto originale di “We insist” per esibire la perfezione tecnica che solo orecchie educatissime possono cogliere.
Le dita che stringono il velluto del bracciolo assecondano con impulsi muscolari il fluire delle note, in sequenze di colore mediterraneo che anticipano variazioni surreali, raffinatissime. Solo chi frequenta il jazz le percepisce.
Geneviève ricorda l’ambiguità dei duecentoventi giorni vissuti accanto al concertista. Giorni di sconforto e di esaltazione, di fatica e momenti di depressione, spesso contrastanti: il lavoro massacrante di perfezionamento dell’esecuzione e la voglia di lasciare tutto, di ritrovare la propria dimensione, un futuro altro.
Senza senso sopravviene il ricordo della piccola casa che s’affaccia sull’acqua quieta del mare verde smeraldo, trasparente fin sulla rena scura, sfiorata con un impercettibile fruscio. Per qualche attimo Rudy smarrisce la padronanza delle note da inseguire con la massima concentrazione, delle frasi musicali nervose, ad alta sonorità e dei pianissimo in alternanza non preordinata. Responsabile Geneviève?
 Di nuovo elementi di disturbo. Le facce nelle prime file, gente che frequenta i concerti perché è chic, il buio senz’anima del loggione, dove lo ascolta chi ama il jazz, l’atipicità dell’auditorium di palazzo De Benedictis, senza precedenti di james session, l’odore intenso del retropalco, zeppo di vecchie scene e arredi polverosi accumulati negli anni, il contrasto con l’effluvio intenso di un roseto agli esordi della primavera, nel giardino che circonda il villino in costiera amalfitana, con il profumo del corpo e dei capelli della compagna.
Di nuovo elementi di disturbo. Le facce nelle prime file, gente che frequenta i concerti perché è chic, il buio senz’anima del loggione, dove lo ascolta chi ama il jazz, l’atipicità dell’auditorium di palazzo De Benedictis, senza precedenti di james session, l’odore intenso del retropalco, zeppo di vecchie scene e arredi polverosi accumulati negli anni, il contrasto con l’effluvio intenso di un roseto agli esordi della primavera, nel giardino che circonda il villino in costiera amalfitana, con il profumo del corpo e dei capelli della compagna.
Il cuore di Geneviève rallenta, quasi si ferma per pochi attimi. Riprende il battito regolare quando le dita di Rudy riprendono a muoversi sulla tastiera con precisione, sicure, agili, obbedienti, perfettamente sincrone con il virtuosismo delle migliori performance.
Una notte all’Excelsior, dopo il concerto, vale il costo di una matrimoniale a 5 stelle. Manda via le tensioni di mesi vissuti con reciproca sopportazione. Ma un’ora d’amore, è tempo che non cancella il buio di mesi d’incomprensione, di fasi d’intolleranza, il problema insoluto di storie in parallelo solo per assuefazione alla vita in due, che ha funzionato a letto, dove la compatibilità sessuale ha messo in parentesi la stanchezza di un rapporto squilibrato: inconciliabile il successo d’artista di Rudy con il ruolo complementare di Geneviéve, divergenti i percorsi culturali, gelosie incrociate, lui pianista idolatrato dalle donne, lei bella e corteggiatissima.
Dorme poco e male la compagna del jazzista. Lascia il letto senza il minimo rumore, indossa l’abito della sera prima e chiede alla reception di chiamare un taxi. “Viale Etruria, di fronte al cinema Ariston e in fretta, per quanto è possibile” Tra le doti dell’esperto tassista c’è anche la discrezione e non indaga sull’insolito abbigliamento della passeggera, in nero, lungo, a quell’ora che precede l’alba.
“Va bene qui, ma non vada via”. Geneviève schiaccia il pulsante del citofono che non ha mai premuto, combattuta tra la correttezza del rapporto con Rudy e l’attrazione per l’uomo che avrebbe voluto incontrare prima di legarsi a lui. Nessuna risposta. Il ritorno all’Excelsior è una nuova mortificante sconfitta. Dorme ancora Rudy e non lo svegliano neppure i rumori inevitabili della compagna che mette in valigia quanto le appartiene. Si cambia in bagno, esce in silenzio, s’infila nel taxi in sosta davanti all’albergo e chiede di dirigersi nel centro storico dove a diciotto anni ha vissuto la prima esperienza sessuale con una ragazzo di Guadalupe, animatore di un villaggio vacanze sulla costa Smeralda.
Nella hall un uomo di aspetto gradevole, elegante, ostenta livelli di sicurezza da autostima. Le si avvicina con un sorriso e con l’aria da seduttore che Geneviève ha subito più volte per essere avvenente e involontariamente provocante. “Quanto?” le chiede, convinto che sia un’escort. Lei non sa davvero cosa le impedisca di rispondergli di andare al diavolo e si avvia all’ascensore con lo sconosciuto. Si augura che non sia un depravato e tenta di convincersi che la punizione a cui va incontro mandi via il senso di colpa per il mancato coraggio di concludere il rapporto di comodo con il compagno.
“Se n’è andata e avrei dovuto farlo io”. Rudy sa di accettare la scelta di Geneviève con sollievo, libero dal disagio della prima mossa che avrebbe portato comunque a un’inevitabile separazione. Di Daniela non le ha mai parlato e le ha nascosto di averla portata con sé in alcune tournée all’estero. “Dani, libera stasera? Sì? Alle otto, ristorante dell’Excelsior”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 30 aprile 2017
ALMA
di Luciano Scateni
Pericoli di dispotismo parafascista pesano sulle coscienze di chi sa e ricorda il buio che privò gli oppositori di regimi tirannici della libertà. Incombono sull’Europa le minacce del lepenismo, di Paesi della Comunità xenofobi, avidi di euro e ostili all’accoglienza di chi fugge dalla propria Terra per non morire, di spinte a minare la Ue con nuovi exit. Non va meglio nel mondo, alle prese con megalomani da ricovero che governano gli Stati Uniti, Russia e Cina, la Corea del Nord e con il fanatismo terrorista dell’Isis. Voci di dissenso, antagoniste, sono represse con il carcere e la morte. “Alma”, è un tributo a quanti “resistono”, uomini e donne che ebbero la meglio sul fascismo di casa nostra e il nazismo.
Alma è piccola. Di statura è normale, anzi alcuni centimetri oltre la media: la sua figura è snella nell’insieme e generosa solo dove si riconosce la femminilità. Alma è piccola perché puoi tenerne l’anima in un palmo della mano e il cuore nell’altro e ascoltarne il linguaggio dolce e saggiare il sapore della lealtà, inebriarti di odori rari, emozionanti, della vocazione all’amore, della generosità, di un culto mistico per chi ama, ma anche l’opposto: rigidità estreme nel punire ogni trasgressione e intolleranza, prossima al piglio vendicativo. Allora. fugge via l’immagine della donna bambina da stringere tra le braccia e carezzare con dita leggere che acquietano la paura di essere adulta, di perdere la protezione di braccia forti.
Alma è una creatura del Sud del mondo, partorita in una povera casa di Ushuaia, nella Terra del Fuoco, da una donna consumata da infiniti parti.
La bimba, prodigiosamente precoce a dispetto della pochezza ambientale, canta ogni cosa le arrivi alle orecchie dalla vecchia radio a valvole che gracchia ogni volta che la sintonia si allontana dall’emittente locale musicalmente suddita del sound anglosassone. Straordinarie, per chi ha educazione specifica e orecchie buone, sono la “quadratura” di Alma e soprattutto la naturale tendenza a reinterpretare quel che impara velocemente, forse indotta ad aggiustamenti dall’uso approssimativo della lingua per lei ostica.
L’ascoltano in estasi Aurora, la madre, fratelli e sorelle, le vicine di casa. L’ascolta Pedro, uno dei pochi che lasciano periodicamente l’angustia di Ushuaia e possono raccontare di Buenos Aires, del mondo, delle meraviglie della modernità.
Pedro è diventato venditore di cinema per passione. Ragazzino, non perdeva uno solo dei film proiettati nella piazza, sul lenzuolo tutto pieghe, teso tra i balconi di un paio di palazzine adiacenti. Prima di tifare per gli indiani aveva amato ogni prode yankee vincitore di “impari” sfide con i pellerossa e aveva rigato le guance di lacrime per storie d’amore con finali quasi sempre tragici. Massimo gaudio lo traeva dalla raffinata comicità di Buster Keaton e divertimento spensierato dalle comiche di Stan Laurel e Oliver Hardy. Pedro è stato dalla parte dei comanche quando un tracotante palazzinaro, per un compenso da fame, ha tolto alla sua famiglia il terreno coltivato da generazioni, per farne case alveare: esattamente com’è avvenuto nelle terre abitate da sempre dagli indiani.
A poco più di vent’anni, in tasca poche monete per non morire di fame, Pedro ha provato a scoprire l’America, ovvero cioè le suggestioni delle grandi metropoli, della mitica capitale.
Buenos Aires, 1952, Plaza de la Concordia, una sera piovosa di ottobre al “Cafe Moreno”, tavolo d’angolo, accanto alla grande vetrata di dove si domina l’intero emiciclo della piazza e la fontana con i delfini congiunti sul dorso a innaffiare la vasca piena sul fondo di cartacce e foglie morte: Pedro ha lo sguardo fisso sulle insegne della pubblicità. “Casablanca”, propone una locandina-invito. “La Warner Bros Corporation presenta l’ultimo capolavoro di Humphrey Bogart. Per prenotare proiezioni rivolgersi a Martino Diaz / tel. 85 17 21”.
Pedro lo legge come un messaggio destinato alla sua vocazione e lascia cadere la moneta nella fessura del telefono protetto dal caos sonoro del bar da una cabina in vetro usata per segnare con numeri e nomi, parolacce, disegni osceni e proposte indecenti.
“Il signor Diaz?”
“In persona, chi siete?”
“Mi chiamo Pedro, Pedro Sanchez e vorrei sapere se posso venire a trovarvi. Cerco lavoro e mi piacerebbe fare qualcosa nel settore”
“Pensate, che sia un produttore, un regista o che so io?”
“No signore, non voglio fare l’attore, farei qualunque cosa per stare a contatto con il mondo del cinema”
“Richiamatemi domani”.
Don Martino Diaz ha indosso una stanchezza antica. Sulle spalle gli pesano quarant’anni di fatica, messo a lavorare dal padre in una bottega di falegnameria dove sapeva quando gli toccava entrare, mai quando sarebbe uscito.
Aveva diciotto anni ma ne dimostrava sei o sette di più quando un cliente del padrone, giudicandolo sveglio e intraprendente, gli aveva proposto di cambiar vita.
“Sono il concessionario di un paio di importanti case cinematografiche americane e cerco un giovane sveglio che giri l’Argentina quanto è lunga e larga per vendere i film alle sale di proiezione. La percentuale è buona e ti darei un fisso per le spese”.
Subito sì. Martino aveva dimenticato di aver vissuto solo dentro quella maledetta bottega per sei anni della sua giovane vita, di non conoscere molto di più delle strade intorno alla falegnameria e all’abitazione.
Con i miseri sottratti al ménage familiare compra un abito, modesto ma dignitoso, una paio di scarpe più apparenza che sostanza, una camicia bianca e un cravattino stretto a righe oblique, punto di partenza per quarant’anni di vagabondare, sempre alle prese con la modesta diaria, costretto a dormire in pensioni di terz’ordine, a mangiar poco e male.
Duro il mestiere di venditore, di persuasore ostinato dei gestori di sale cinematografiche incapaci di distinguere un capolavoro da un bidone e di prevedere i tempi di programmazione dei film.
Diaz avrebbe mollato anche prima ma si libera del faticoso mestiere solo quando una delle compagnie di cui aveva venduto tonnellate di pellicole gli offre di dirigere il lavoro commerciale da una comoda poltrona dell’ufficio nella Plaza de la Concordia, a condizione di scegliere un successore in gamba.
Diaz non ha cultura cinematografica. La sua è piuttosto un’infarinatura acquisita sul campo, ficcata nella memoria grazie tante schermaglie ingaggiate per vendere pellicole, spesso di dubbia qualità. Comunque, per far colpo su Pedro, riesce a imbastire due o tre domande da competente, tese a scoprire se è davvero spinto da passione per il cinema o l’ha inventata per ottenere il posto di venditore della Warner Bros e di un altro paio di società di produzione.
Pedro intuisce la pochezza della cultura cinematografica di don Martino e per averne conferma inventa una risposta qualunque alla domanda su Chaplin. Diaz non fa una piega.
Il giovanotto diventa il migliore sulla piazza e il conto in banca va su, addirittura s’impenna quando alla Warner può unire il patrimonio di colossal e film cult della Columbia Picture.
Ushuaia è lontana in principio e il giovane agente di commercio, oltre pochi, dolorosi ritorni, ne sta lontano per mettere da parte qualche soldo da investire nel perfezionamento della competenza e delle tecniche di vendita. Pedro spende molte energie nella cura delle relazioni nell’ambiente del cinema e in qualche anno di lavoro può contare su importanti rapporti con gente del gran mondo. Gli è fedelmente amico Vasco Gutierrez, principe senza rivali di lave story che inumidiscono le gote di milioni di donne e non meno Carmen Larosa, donna in carriera che produce il sessanta percento di film record di incassi. Con Victoria Gomez è altra cosa. Lei è la più sensibile musicista argentina e non solo per Pedro: sue le migliori colonne sonore, sue quasi tutte le canzoni di successo, sua la scuderia di interpreti più amati dall’intero Sudamerica.
Victoria ha nel cassetto una decina di arie composte per sé stessa in anni di contiguità con l’impegno politico.
 Nel patio del giardino fiorito dove si impegna a mandar via stress, amarezze e malumore, siede al piano e Pedro la guarda intensamente, scoprendo ancora una volta di amarla da troppo tempo per tener nascosto quel che sente. Gli occhi si incontrano ma in quelli della donna non c’è amore. Il suo sguardo oltrepassa Pedro e si perde nell’idea di una voce capace di entrarle nell’anima per cantare questa musica come fosse la sua stessa, appassionata, esaltata da suono della fisarmonica di Astor Piazzolla.
Nel patio del giardino fiorito dove si impegna a mandar via stress, amarezze e malumore, siede al piano e Pedro la guarda intensamente, scoprendo ancora una volta di amarla da troppo tempo per tener nascosto quel che sente. Gli occhi si incontrano ma in quelli della donna non c’è amore. Il suo sguardo oltrepassa Pedro e si perde nell’idea di una voce capace di entrarle nell’anima per cantare questa musica come fosse la sua stessa, appassionata, esaltata da suono della fisarmonica di Astor Piazzolla.
Victoria ha rispetto e amore per quelle righe piene di note, struggenti all’esordio, via via rabbiose, aspre, di quelle parole che promettono agli oppressi la rivolta, ai poveri giustizia, vendetta ai martiri. “Teste chine mai più / che la schiena stai su”, ha scritto per sé la musicista. “C’è una luce lassù / e piove su di noi… dal blu” racconta invece la cover che svetta nella hit parade da diciotto settimane.
“Trovala tu, Pedro, cerca per me una voce e un’anima che sappiano dire al mondo che il popolo non s’è arreso, che i sentimenti della rivoluzione non sono spenti e che la dittatura non è eterna. Aiutami a trovare il coraggio di disconoscere questa canzone orrendamente commerciale.”
Alma, chi altri. Vola la leggenda della sua voce calda, intensa, valorizzata da un’incredibile estensione e da un rapporto personalissimo con il ritmo, le pause, gli improvvisi cambi di timbro, un’eleganza scenica che solo i grandi chansonnier francesi posseggono. Pedro racconta a Victoria di Alma e le promette di proporle la sua musica perché diventino energia da far paura alla dittatura.
Alle 20 dell’ultima domenica di maggio, odorosa di terra appena sfiorata da una pioggia lieve, quasi invisibile, si allontanano gli ultimi chiarori di un giorno nell’insieme radioso, nemmeno una nuvola da est a ovest. Nel centro storico di San Julian uno per volta, separati, uomini e donne siedono sulla pietra lucida che addossata ai muri della case e della vecchia chiesa dell’Addolorata disegna un coro intorno alla rosa dei venti, al centro della piazza dei “Conquistadores”. Dalla locanda, di dietro le fettucce colorate che respingono gli assalti di mosche fameliche, spuntano come congiurati due uomini e una donna. Portano fuori una rozza pedana, un altoparlante da comizio con la grande tromba grigia e un microfono antidiluviano.
In ultimo appare una ragazza straordinariamente bella, in abito nero, lungo oltre le caviglie, senza linea. Su quel corpo giovane, prosperoso, anche stracci sembrerebbero un abito da sfilata. Nessuno può incontrare gli occhi di Alma. In quei volti sofferenti, nei cuori feriti, la giovinetta vede volti e cuori di eroi che hanno sfidato il regime fino a morirne.
“Teste chine mai più / che la schiena stia su…”
Dai vicoli che s’immettono nella piazza, dalla chiesa violata, dalle porte spalancate a calci di alcune case, schizzano fuori decine di divise della Guardia National, pistole in pugno e pesanti mazze nere. Autoblindo leggere e camionette rombanti, impazzite, scatenano un carosello mortale. Non c’è scampo e qualche bandiera rossa tirata fuori di sotto i letti, sollecita ancor più la violenza della policia. Una ventina di uomini, molte donne, qualche vecchio, finiscono nei cellulari della milizia. Sono quindici i feriti, due gravemente. La polvere sollevata dal raid sale in vortici come spinta da un tornado, le grida dei feriti, quelle di paura, gli ordini urlati dai militari, risuonano impressionanti. In terra una figura in nero. Le mani avvolgono la testa, le ginocchia sono serrate al petto. Accanto, il microfono.
Sangue, di sotto la gonna, dove il ventre la gonfia appena.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 23 aprile 2017
Pischedda
di Luciano Scateni
Vittime e carnefici. I maschi del Sud, per antica genesi di un machismo da uomini delle caverne, avevano della donna l’idea animalesca dell’ “uso” a proprio piacimento di corpo e anima. Usarle violenza, pretendere di essere servito e riverito come il dio della casa era implicito nel contratto di matrimonio e così la clausola tacita di proprietà privata. Tonio è uno di loro, allevato in una società malata di anti femminismo, in complicità con l’ottusa formulazione di sentenze assolutorie del “delitto d’onore” Una patologia tipica del Sud di un secolo fa? Il femminicidio, oscena definizione di delitti che segnano con un tragico vulnus il nostro tempo è ben oltre i confini geografici dell’Italia a sud di Roma e di quel tempo lontano. Racconta una faccia del Paese univoca, anzi no, sbilanciata in direzione opposta al Mezzogiorno. Donne insultate, sfregiate, uccise a coltellate, quasi ogni giorno. Uomini che impugnano come allora la clava di cavernicoli.
Hanno un cedimento innaturale le gambe di Pischedda e non fosse per il tuonare della doppietta che il paese avverte con sinistra familiarità, si direbbe che la giovinetta ceda al peso della cesta che porta sulla testa, poggiata su uno straccio arrotolato, colma di panni lavati, ancora intrisi d’acqua. La povera veste che indossa si tinge di sangue sullo stomaco e poco più su, dov’è il cuore ferito a morte. Gocce rosso fuoco scivolano sul vestito e la polvere le assorbe, si scurisce. Pischedda s’inginocchia e la testa si piega da un lato. Il collo non ha più forza per reggerlo. Mentre finisce in terra, il viso nella polvere, la giovane donna guarda Toto di sotto in su, smarrita. Avesse ancora qualche attimo di vita gli chiederebbe “perché?”, ma l’anima l’abbandona e il corpo si spegne. S’irrigidisce, le gambe si scoprono fino alla piega delle ginocchia dove le calze di lana nera, spessa, confinano con la pelle lattea. Le mani, nonostante la violenza dell’impatto con il terreno, stringono ancora i bordi della cesta. Sono di nuovo sporchi calzini e mutande, un paio di camicie finiti in terra.
 Toto riconosce in un attimo il peso della storia amara della sua terra e la maledizione di riti che gravano sulla testa degli uomini nella Sicilia dei delitti d’onore. Era ancora un moccioso quando ha vissuto l’emozione per un frammento di stella che striando d’argento il cielo senza luna, in un’estate impietosamente calda, gli ha suggerito l’idea impressionante dell’infinito. Fu della madre il monito a non lasciar cadere le stelle senza aver formulato un desiderio. Toto ricorda. “Ho desiderato di non somigliare a mio padre”. Lo scoprì rozzo interprete di maschilismo autoritario, viziato da bieca arretratezza.
Toto riconosce in un attimo il peso della storia amara della sua terra e la maledizione di riti che gravano sulla testa degli uomini nella Sicilia dei delitti d’onore. Era ancora un moccioso quando ha vissuto l’emozione per un frammento di stella che striando d’argento il cielo senza luna, in un’estate impietosamente calda, gli ha suggerito l’idea impressionante dell’infinito. Fu della madre il monito a non lasciar cadere le stelle senza aver formulato un desiderio. Toto ricorda. “Ho desiderato di non somigliare a mio padre”. Lo scoprì rozzo interprete di maschilismo autoritario, viziato da bieca arretratezza.
Questa notte Calampiso è più ostile del solito. Tra le dune infiorate dai gigli della sabbia e il malodore di rifiuti non rimossi da tempo, soffre il vuoto totale in cui naviga senza bussola, esaspera il senso di non appartenenza alla vicina Trapani, nonostante sia lì, dietro l’angolo, l’assenza di percezione che appena dopo la costa scogliosa, oltre le rocce porose di arenaria svetta Erice, miracolosa terrazza della natura sulle Sicilia delle Egadi e sul mare blu dov’è profondo, trasparente a riva, abitato da alche verde intenso e colonie di sarpe argentate.
Questa notte Calampiso è accesa dalla luna che attraversa trasparenze uniche nei cieli lungo le coste nel Mediterraneo. Si leggono con dolore le ferite inflitte dall’uomo alla montagna per tracciare a vantaggio dell’automobile solchi spregiudicati nella vegetazione dell’ ampia macchia degradante fino al mare, tutelata, ma solo in teoria.
È arcigno il profilo della vetta, simile alla punta triangolare di una lancia. A toto sembra che voglia sfidare il cielo. Lungo il versante meno ripido si staglia la sagoma di una torre, tozza costruzione sovrastata da un tondo belvedere, luogo di avvistamento contro le incursioni saracene, malridotto eppure pretenzioso per essere il rifugio di pastori, ché a loro basta un albero frondoso per tetto e un letto di paglia. Prima di andare in malora fu casino di caccia di certi signorotti di San Vito Lo Capo che si appostavano in agguato tra rocce e cespugli nella stagione delle favorevole al ritorno dalla svernare di uccelli d’ogni specie.
La cinghia della doppietta ha buona presa sul tessuto grezzo della giacca di Toto Greco, attento a tenere la canna del fucile rivolta a terra. Il giovane affronta col piglio eccessivo di chi ha fretta il sentiero che ripido porta alla torre e l’impennata dell’erta gli mozza il fiato. Si lascia cadere ai piedi d’una pianta d’ulivo monumentale, folta abbastanza da contrastare le folate di aria umida che salgono dal mare.
Era già buio quando ha oltrepassato il corpo senza più vita della sua donna, senza guardarlo, per non urlare. Buio nella sua povera testa, pesante come mai la doppietta: pensieri angosciosi, in terrorizzante disordine.
Pischedda è stata la sua donna da sempre, dal giorno del concepimento. La prima femmina dei Cunzo avrebbe sposato il primo nato dei Greco, questa la decisione dei patriarchi delle due famiglie consacrata con una stretta di mano e poche parole. Dei dettagli si sarebbero occupate le donne, brave a contrattare diritti e doveri. Né scritto, né ricordato a voce, il codice d’onore si tramanda da secoli, di maschio in maschio, da femmina a femmina. Pischedda non oserà incrociare lo sguardo di chicchessia e terrà comportamenti da vedova in grazia di dio, fino al giorno delle nozze. Toto potrà concedersi qualche trasgressione veniale, ma di soppiatto. A lui l’onere di proteggere la reputazione della giovane fidanzata, fino al sì sull’altare e anche di più dopo il matrimonio.
D’istinto o forse per una imminente consapevolezza dei cambiamenti che anche qui aprono qualche spiraglio nel muro delle peggiori tradizioni, Pischedda, sente che il suo tempo non è più nella claustrofobia esistenziale di Calampiso, confine estremo dell’arretratezza, ma almeno un po’ nel nuovo che muove il resto del mondo.
Non sono innocenti certe sue occhiate, niente di più, ai coetanei all’uscita della messa o nell’attraversare la piazza circondata da un lungo sedile di pietra dove i maschi si danno appuntamento con la speranza di vedere passare le ragazze del paese e specialmente la gettonatissima Pischedda, in uscita domenicale sul corso, scortata dall’intero clan dei Cunzo. Toto finge di non accorgersene, di non sentire chi sussurra malignità e volgarità.
C’è però un confine invalicabile anche per Toto e lo oltrepassa una masnada di perdigiorno che addossati alla recinzione dei giardini comunali sparlano della sua promessa sposa a voce alta, con linguaggio a dir poco colorito. Toto ascolta tutto per caso, seduto a pochi passi di distanza, la testa affondata nella “Gazzetta dello Sport”. Forse qualcuno dei perditempo sa che è lì e lo provoca con il racconto di appostamenti dietro una larga pianta di fichi, proprio di fronte alla casa bianca come il sale dei Cunzo, di dove… “Picciotti e che spettacolo, meglio che al cinematografo…” Tutti si eccitano, quasi come nelle sedie di legno dell’Odeon ansimano per le immagini porno che al mattino intorno alle 10 il cinema proietta per qualche studente filonista e una masnada di bighelloni.
Il gruppetto di denigratori, frustrati e rosi dall’invidia per il giovanotto a cui sarebbe toccata in moglie la florida Pischedda, indugiano uno più dell’altro a raccontare della giovanetta esibizioni visibili da tutti nel riquadro di una larga finestra della camera da letto. Dicono di uno spogliarello a favore dei guardoni, di una spregiudicatezza che “altro che bottana, bottanissima è”. Oltre misura i commenti di Rosario, detto “o saracino” per via di occhi e capelli nerissimi e di una pelle scura tutto l’anno: “L’ho incrociata nella piazza del mercato quella sfacciata, l’ho guardata dritto negli occhi e mi ha ricambiato, come a dire ci sto, ci sto. Di Salvatore ho fiducia, tutti ne abbiamo, no? Lui giura di averla strapazzata, una volta che tornava dal fiume con la cesta dei panni sulla testa. Giura che non ha detto un ah, ma di fatti ne ha fatti e come”. Calogero: “E allora… se vogliamo dirla tutta… vi ricordate la storia di quel figlio di una mignotta che venne da Palermo per farsi i bagni di mare e fu trovato con la “signorina” sulla spiaggia a fare porcherie?” Fortunato: “Non mi fate parlare per sant’Ignazio, questo è passato remoto, ma ora, ora, che è promessa sposa… non ci crederete, ma c’è una storia torbida tra lei e uno zio, ancora giovane, un gallo che ha beccato in molti pollai. Lo hanno visto entrare in casa di Pischedda, un pomeriggio. C’era solo lei e lo hanno visto uscire dopo un’ora. Era tutto spettinato…”.
Un calcio rabbioso di Toto e la vecchia porta della torre cede gemendo. Ripone la doppietta al posto suo, agganciata con la tracolla ai crocchi neri infissi nella parete imbiancata a calce.
Tornava dalla fonte di pietra grigia Pischedda, dove tutte le donne del paese strofinano la biancheria da lavare. Toto non ha voluto incontrare i suoi occhi: ha puntato il fucile al petto della ragazza, l’indice spinto su un grilletto, poi sull’altro, quasi leggermente, come se cosi i pallettoni possano far meno male. Non si ferma neppure un istante. Va, con i suoi passetti corti, da femmina. Lo sguardo si perde nella luminescenza di Sirio e si offusca, si perde nella fissità di pensieri cupi.
La rocca divide in due la sagoma della montagna e sporge dalla roccia tanto da rincorrere all’orizzonte due metà gemelle, una a est, l’altra a ovest.Gli storici narrano di incursioni saracene neutralizzate da una infinita catena di torri d’avvistamento che da luoghi strategici della Sicilia metteva in guardia le popolazioni costiere per centinaia di chilometri, fino alla Campania, e oltre.
Il sentiero s’impenna ardito e taglia fiato e gambe di Toto. Dentro le mura a secco della piccola costruzione è disordine e degrado. Lungo il perimetro delle mura si sono accumulati polvere e frammenti di pietra caduti dal soffitto, segnali d’incuria prolungata Un angolo è ingombro di attrezzi agricoli. L’unica finestra si apre all’esterno. E’ senza infissi, protetta da un’inferriata di cui è rimasto solo uno spuntone eroso dalla ruggine. Toto si toglie la coppola e si libera della giacchetta, buona per tutte le stagioni, scura di sudore, intrisa di un greve odore di tabacco, arrotola le maniche della camicia di flanella. Sfila dai larghi passanti la cintura di cuoio, l’avvolge attorno a quel che resta della grata e la ferma con un nodo. Ammucchia le pietre più consistenti alla base della finestra e vi monta su. Circonda la gola con la cintola e stringe la fibbia con forza. Sente che le vene pulsano fino a scoppiare. Si scopre a pensare di non aver pensieri e di non aver paura, ma solo fretta di farla finita. Il calcio alle pietre è deciso.
Da questo momento la vecchia torre e il mare in cui si protende sarà “Calampiso”, la cala dell’impiccato. Ne avranno paura i picciotti di San Vito e i vecchi trasformeranno la tragedia in una favola triste, raccontata ai maschi del paese. Il prologo a loro modo:: “Puttana Eva, tutto per una sottana, ah… in una serata poco stellata. Il mare era liscio come l’olio… il rudere della torre aveva un’impressionante cupezza, la luce fredda della luna lo colpiva con perfida precognizione. Era la fine di un agosto macchiato di nuvole che correvano veloci a scavalcare la montagna…”.
……………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Pasqua – Domenica 16 aprile 2017
P & P – Paco e Peppino
DI LUCIANO SCATENI
I grandi che hanno regalato righe poetiche alla canzone che “leggera” è insolente etichettare, condannano agli esami di riparazione gli autori attratti dal volo dei gabbiani, infilati tra un rigo e l’altro per emozionare chi li ascolterà. Paco è un gabbiano e il racconto che segue non accompagna note struggenti sul filo sempiterno dell’assonanza amore-cuore.
Racconta un’adozione reciproca del gabbiano di Palinuro e del suo compagno di pensieri, di un’empatia che solo i bambini vivono in pura solidarietà, priva di riserve e ambigui propositi. La dedica è per tutti i gabbiani che la supponenza dei parolieri d’élite ha condannato all’oblio per ostilità ai sentimenti semplici, collettivi, dei comuni mortali.
Paco se ne sta pigro a un niente dai larghi e quieti approdi del mare, ritto sulla sabbia che il sole fa brillare nei minuscoli frammenti ferrosi e prende colore dove è lambita dall’acqua delle piccole onde terminali.
Un bell’esemplare Paco. Fiero nel portamento, agile, un’andatura decisa e rapida in prossimità di un traguardo che somigli a qualcosa di commestibile. Pigra altrimenti, sempre solenne.
Applicato con severa disciplina agonistica, il beach baseball è invenzione estiva di Tellis and Frank, gemelli scozzesi, due gocce d’acqua, volti e fisico in fotocopia se non fosse per un codino di capelli rosso fuoco annodato solo sulla nuca del primo. La mazza del battitore è la gamba di una sedia sfasciata per vecchiaia. Stracci compressi, avvolti in un lembo di plastica spessa, volano dal lanciatore al battitore e perdono brandelli di stoffa ad ogni tiro. Paco si muove con acume tattico. Affronta le fatiche del percorso, tutto dune di sabbia bruciata dal sole, e compie un largo giro di accerchiamento. Memorizza i tempi di latenza tra un lancio e il successivo, attento alla palla che sfuggita al battitore, rotola in terra. Ci si tuffa su. Lo stop indispettisce i gemelli e mette fine al match. Il confronto prosegue con la consueta competizione di nuoto pinnato sulla distanza di una cinquantina di metri, valutati a occhio, con partenza dal gozzo “Gite quotidiane alle grotte”. Ha la meglio non di molto Tellis che in debito di fiato si stende sulla sabbia accanto al fratello. Per pochi minuti perché è tempo di mettersi al lavoro e di imbarcare sul gozzo, che monta una provvidenziale tenda parasole, una combriccola di salernitani invogliati dal poster promozionale esposto nella bacheca all’ingresso del palazzo della Provincia. Promuove le immagini delle grotte “Argento”, “Sangue”, dei “Monacelli” e della spiaggia del “Buon dormire” dove “Da Salvatore” si può apprezzare uno squisito spaghetto all’astice nella conca di acqua verde smeraldo, sovrastata da roccia brulla, macchiata di giallo da ciuffi di ginestre in fiore.
La barca rientra sul far della sera, quando il mare si è acquietato e la navigazione per circumnavigare il Capo non è più a rischio. Gli ultimi raggi di sole, prima che si inabissi all’orizzonte, illuminano da ovest la cima della collina. Volenterosi scalatori concludono il cammino dove si erge una delle mille torri in posizione strategica per avvistare le incursioni dei pirati saraceni e dove svetta il faro. Il mare ingoia il sole e in pochi secondi lo tinge di rosso. Paco pensa a sé, alla diversità della solitudine, scelta d’istinto, evidente nello sguardo mesto, di gabbiano solitario, specialmente a sera, quando i suoi simili, in gruppo, apprezzano la frescura che manda via il caldo accumulato nell’intera giornata di sole agostano, impietoso se picchia da cieli blu senza il filtro delle nuvole. Poteva socializzare Paco e far vita d’insieme, godere i vantaggi della solidarietà di razza e di una facile scelta della partner con cui mettere su famiglia. Poteva, non avesse amato l’indipendenza, non avesse ambito indagare un mondo altro, quello degli strani esseri che lo popolano e che gli sembrano ostili, senza un perché. Quante perplessità prima di superare la consapevolezza che gli uomini ostacolano la promiscuità, le compatibilità, quante notti insonni, animate da incubi. Sassi schivati a stento, gli inutili appelli gutturali per dire “Buoni,, cerco solo pace, coesistenza, amicizia”. Il miracolo dell’accoglienza si deve a un bambino, creatura senza pregiudizi. Peppino ha ricattato i genitori: “Non mangio, non voglio più bene”, e ha conquistato il diritto a ospitare Paco nella sua vita di gioco.
Nel Marzo di quest’anno, dal clima anomalo, il cielo è stato impietoso con il Cilento con le sue primavere solari. Grandi nuvole gonfie d’acqua hanno cavalcato le vette dei monti Picentini per tre settimane, senza sosta, e hanno sommerso Palinuro con bombe d’acqua. Hanno bestemmiato i contadini, e non meno i pescatori, impediti a compiere il lavoro di ogni giorno.
La piccola conca protetta dalla scogliera artificiale del molo ha retto a stento la furia delle onde. La barriera di protezione, scavalcata, ha impattato con violenza su gozzi, motoscafi e yacht ancorati nel porto e ha danneggiato i più esposti. Vacilla, sulla ghiglia piantata nella secca appena fuori della rada, il relitto di un cargo affondato nel pieno di una tempesta che molti hanno paragonato alla violenza del tifone subito dalla nave governata al timone da Palinuro. Con le fondamenta piantate nella pietra porosa che sostiene la collina di argilla, la casa di Peppino ospita reti e nasse, vecchi remi, attrezzi utili nelle battute di pesca, tirate fuori quando si parte di notte e si contrasta il freddo con dosi generose di un vino corposo, aspro, che accompagna la sostanza del formaggio di pecora e fette di pane nero, raffermo.
Tra le lamiere rugginose del relitto, quando è passata la bufera e il mare si è placato, nuotano saraghi e ombrine. Da tane protette, sporgono le teste aggressive delle murene, bocche spalancate su file di denti aguzzi orientati all’interno del palato. Un morso e la preda è senza scampo. Per liberarsene non resta che strappare la carne addentata. Ne fanno le spese polpi e polpesse, amputati di tentacoli.
Paco frequenta d’abitudine il tratto di mare che s’infrange sulle ferraglie del relitto: d’interessante c’è che, pur in regime di subordinazione con i vip del mare, nuotano in branchi fitti, con moto ondulatorio, i più piccoli abitanti del luogo, preda facile di gabbiani e altri predatori alati.
Peppino, in Marzo, è costretto dalla pioggia battente a guardare il mondo di qua dalla finestra ben chiusa della cucina. Non ha giochi con cui trastullarsi e unico passatempo, non a caso come figlio di pescatore è nella cura dei piccoli attrezzi per la cattura di cefali e perchie, polipetti e crostacei. Paco gli è noto da sempre, non solo per il piumaggio atipico, grigio carico da tacchino né per le dimensioni da superdotato e neppure per la lunghezza sproporzionata del becco. Ne riconosce lo stile di volo, l’abilità nell’economizzare lo sforzo muscolare per le cabrate e anche di più nelle lunghissime, perfette picchiate sul pelo dell’acqua, quando con le ali immobili, la posizione aerodinamica delle zampe raccolte, aderenti al corpo, è d’esempio per le evoluzioni eleganti degli alianti. Anche a Paco è familiare la sagoma esile di Peppino, magro come lo sono i bambini che vivono all’aria aperta, mangiano l’essenziale, preferiscono pane e olio al posto delle merendine di produzione industriale.
La prima volta di Paco e Peppino fu una volta di Marzo, infine di una settimana di pioggia e di magra per il gabbiano affamato.
Al mattino, quando il cielo si riprende il suo tempo di quiete e l’acqua caduta abbondante diventa pozzanghere tutt’intorno alla casa, le ultime gocce scendono lente dalle foglie ruvide della lantana appena fiorita: Peppino caccia granchi con un’arma di sua invenzione, un fil di ferro sottile ma rigido, capace di infilarsi nelle fessure profonde degli scogli. La punta in cima all’attrezzo gli serve per forare la corazza dei crostacei e strapparli al loro rifugio. Uno, bruno, macchiettato di arancio, di insolite dimensioni, agita le tenaglie annaspando in un disperato tentativo di difesa. Immobilizzato, crocefisso, si prepara a morire. Paco, planato accanto a Peppino si avvicina a piccoli, incerti passetti. Con brevi movimenti del capo, una specie di tic, sembra chiedere il permesso di liberare il granchio dalla prigionia a cui è costretto, per farne un gustoso boccone. Un’occhiataccia gli consiglia di mettere via la vocazione di cacciatore e si dedica all’alternativa non meno soddisfacente di nutrirsi senza fatica con il pesce di scarto catturato da Onorato, abile pescatore di Palinuro, padre severo di Peppino. Non finisce di stupirsi per la mansueta familiarità del gabbiano con il figlio che lo ha reso domestico e portafortuna della “Nina”, vecchia gloriosa cianciola che Paco segue nelle faticose nottate di pesca, appollaiato sulla prua.
La mattina successiva a un’uscita notturna per mare Peppino ha faticato a lasciare il letto, per compensare le ore di sonno perdute. Prima ancora di obbedire all’invito di mamma Rossa di far colazione si affaccia alla finestra che si apre sulla spiaggia, dove Paco ha marcato il suo territorio. Paco non c’è, neppure sul bordo della “Nina” a secco, di dove scruta i dintorni per piombare nell’acqua trasparente del porto e tuffarsi su pesci che nuotano vicini alla superfice del mare. Perplessità e timori di Peppino crescono con il trascorrere delle ore.
Nel tardo pomeriggio Paco atterra accanto all’amico e non è solo. A pochi passetti di istanza lo segue timorosa una graziosa femmina di gabbiano. Sembra impaziente di riprendere il volo. Paco struscia il becco sulla mano di Peppino, lo guarda dritto negli occhi e se potesse gli direbbe addio. Si volta verso la compagna e all’unisono spiccano il volo. Chissà per dove.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 9 aprile 2017
NINNILLO
di Luciano Scateni
Gli occhi di Ninnillo sono saraceni. Vicini, neri come la lava residua di antiche turbolenze che hanno scosso il vulcano decapitato, separato in due picchi impari, l’uno squarciato da una bocca animalesca, dentata, aggressiva, l’altro ridotto a una ferita, incapace di reggere perfino un innocente respiro allo zolfo delle sue visceri attive. La pelle di Ninnillo è consumata dal sole, satura di pigmenti che attribuiscono al piccolo uomo del Cilento somiglianze con i fratelli africani in faccia al Mediterraneo.
L’anima di Ninnillo vive di pensieri che il mare accarezza come una madre e di lealtà per l’ambiente che generosamente l’ospita, quando l’acqua paralizza i muscoli, con il gelo dell’inverno o nelle stagioni del tepore che invitano a interminabili esplorazioni di fondali rocciosi del Tirreno.
Il coraggio di Ninnillo stupisce perfino i due o tre amici a cui è permesso di partecipare alle spedizioni di caccia alla cernia. Sembra loro impossibile quel temerario scivolare dentro crepe di scogli larghe appena quanto il suo esile corpo, oltre anfratti profondi e bui, imprevedibili tane dove s’annidano murene, saraghi e ombrine. Ma ora non ne esce più Ninnillo .
Cominci a pregare e conti: centodieci, quindici, venti, trentacinque. Speri che non sia finito in labirinto infido. Qualcosa sporge infine dal pelo dell’acqua sferzata da potenti colpi di coda. E’ la seconda immersione. L’esito della prima è nella fiocina piantata nelle branchie di una cernia che a occhio misura sessanta centimetri per cinque chili di peso. E’ quella cercata da Ninnillo, quella promessa a Serena Bianchi, giovane, dolcissima romana, che ha promesso una cena di pesce ai suoi amici della capitale.
Nuota solitaria Serena, entrando in acqua con un tuffo da professionista. È campionessa italiana di “crowl” per sordomuti. I suoi occhi esprimono sentimenti e idee più, meglio delle parole.
“Com’è stamattina?” chiede Nicola a Ninnillo spinge in acqua un guscio di legno ai limiti del galleggiamento. In risposta non più di un “Humm” che può voler dire “bene, male, così, così”. Per saperne di più si deve aspettare con pazienza la fine del rito di vestizione che il giovane pescatore compie abitualmente con gesti lenti, mentre respira profondamente per ossigenarsi. Infila una canottiera con le maniche lunghe fino al gomito e una paio di calze di lana rozza verde militare che aiutano l’ingresso del piede nelle pinne cotte dal sole, spaccate in un calcagno e in prossimità di un alluce. Ninnillo usa la saliva per evitare che il vetro della maschera si appanni nel brusco alternarsi dal caldo al freddo dell’acqua e intorno alla vita fissa una corda lisa in più parti con un cappio dove infila il coltellaccio da cucina ben stretto, con il manico in posizione per agevolare la presa.
Nicola e gli altri non hanno mai capito come Ninnillo riesca a caricare un fucile a molla parecchio più alto di lui, operazione ripetuta più volte in acqua durante la battuta di caccia. Intorno alla vita, fermato da una sagola, aggancia un ampio cerchio di fil di ferro e c’è da scommettere che la spedizione subacquea non si concluderà prima di averci infilato tutto il pescato, fino a non avere più spazio libero, neppure un centimetro tra una preda e l’altra. Non era spavalderia l’annuncio che sarebbe risalito solo dopo aver catturato Peppina e Concetta, cernie del peso richiesto dal ristorante “La Scogliera”, esemplari che Ninnillo ha visto crescere in tane che ritrova agevolmente tra gli scogli della secca in direzione del porto.
Nessuna meraviglia se attorno al predatore cilentano sono nati miti e leggende, quasi sempre ispirati a imprese particolari, a volte senza riscontro nell’accaduto. A primi turisti attratti dal mare purissimo della costa cilentana, Nicola, inseparabile partener di scorrerie per mare, ha raccontato di una maternità miracolosa da cui sarebbe stato generato Ninnillo e ha arricchito il racconto con dettagli suggestivi. “È, figlio di una cernia, è nato nella grotta della fertilità, a cento metri di profondità nel mare verde smeraldo nella baia del saraceno. Sua madre? Una cernia gigantesca e prolifica, di nome Oceania”.
E’ un’estate calda da non respirare, con il sole impegnato a bruciare anche le pelli più assuefatte. Torna al paese don Gennaro Masone, figlio del figlio di Pasquale, un povero d’altri tempi, povero da non possedere che una camicia e due scarpe sfondate, fame quanta se ne vuole, emigrante in America con il piroscafo della speranza stracolmo di povera gente.
“Don Gennaro”, gli dice Nicola, “Venite dall’America, terra ricca e non solo di dollari. Conoscete il grande Hemingway? Avete letto i suoi libri, uno dei più noti, “Il vecchio e il mare”? Quel vecchio ha vissuto qui, era il padre di Ninnillo e ha portato il segreto dell’accoppiamento con la cernia con sé, nella tomba, in fondo al mare dove è sparito per sempre”.
La leggenda, diviene racconto per la penna ambiziosa del maestro elementare, pubblicato da una casa editrice salernitana di libri scolastici. La modestia culturale di Ninnillo in continuum con la sua innata ingenuità, lo smarriscono fino a convincerlo che sia stato davvero generato dalla madre cernia. E così che finisce per disconoscere le lezioni di vita ricevute dal mare, gli ammonimenti a non sfidarlo. Dimentica quasi di essere un uomo e comincia a pensare e a vivere come un pesce. Più in acqua che a terra. Chiede al suo esile torace di sopportare apnee oltre la sua capacità polmonare e l’exploit di spingersi a profondità incompatibili con la natura umana. Intorno a lui si incrementa il club di fan, una tifoseria incosciente, esosa, incontentabile. Lui non si pone più limiti nella sfida a quei fondali conosciuti metro dopo metro.
“E sotto da troppo tempo” dice Nicola. Rosario ed Enzino annuiscono. E’ Alfonso il più lesto a stringere tra i denti il boccaglio e andar giù lasciandosi alle spalle gorghi d’acqua ad ogni bracciata, le bombole agganciate alla meglio sulla schiena, la maschera appannata e un’ansia crescente, il cuore in subbuglio. Nessuna risposta allo strattone del cordiglio legato da Ninnillo in superficie a un asse di legno bianco, relitto di una barca scaraventata sugli scogli da un mare arrabbiatissimo e alla base del fucile. Niente in vista, se non la coda della sagola che spunta da una tana. Appena dietro una quinta di roccia liscia e candida, “gli scogli bianchi per chi ha confidenza con quei fondali”, un braccio e la mano stretta attorno al coltello, mossa appena dalla corrente di forza discreta in quel tratto di mare. Romeo non si chiede se Ninnillo è ancora vivo. Con difficoltà e uno sforzo sovrumano riesce a disincagliare il corpo dagli spuntoni di roccia che lo trattengono e se lo tira dietro, su per i venti metri che lo separano dal pelo dell’acqua.
E’ la seconda embolia per Ninnillo, la supera con l’aiuto della camera iperbarica. Quando supera la crisi, Nicola lo assale. “Va in acqua un’altra volta, una sola, e ci lasci la pelle”.
Il predatore del Cilento rinuncia alla pesca, va in depressione, impara il mestiere di meccanico di auto. Agli amici sembra che a tratti sia fuori di testa. Esagera spesso con un vinello indigeno, ingannatore, bevuto a grandi sorsate come fosse acqua, per sete, forse per disinnescare la memoria, per non dannarsi con il ricordo delle imprese migliori di sub, per lasciarsi andare alla nostalgia per qualche ora trascorsa in silenzio accanto a Serena, dopo le ore di pesca. Già, Serena. Gli ha scritto da Losanna, dove ha scelto di vivere. Serena non sa della débacle del suo “petit saraceno”, dell’eroe del mare che non è più, di sguardi spenti e notti senza sonno e sogni che non fa più di emulare il padre, la sua pesca leggendaria di un pescecane grande oltre due metri.
E, certo, non ricorda l’emozione di un amore nato e concluso in un week end d’agosto.
……………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 2 aprile 2017
CADUTA LIBERA
di Luciano Scateni
Ebbrezza di sfidare la paura, il rischio, la gravità. In parallelo l’impresa del librarsi oltre l’ostacolo di un atleta, con la perfetta congiunzione di forza fisica e mentale, Altri destini. Il precipitare a testa in giù di un rapace regale, colpito a morte dalla cartuccia di un cacciatore ignorante. Il buio senza via d’uscita in una spelonca esplorata sfidando il pericolo di vita. Quattro mini racconti di realtà che per metà sfiorano l’horror fantasy.
a. L’atleta non potrebbe improvvisare alcun gesto, neppure i ritmi del respiro. Sul prato, accanto alla fossa un tempo colma di sabbia grigia, ora accoglie la ricaduta in giù un soffice materasso, imbracato nella fodera azzurra di plastica; sulla pista il saltatore scandisce mentalmente i secondi e trova la concentrazione nella quiete della consapevolezza di farcela.
b. Muscoli e cervello, nervi e cuore, si preparano allo stallo, all’attimo che ben conoscono i piloti delle pattuglie acrobatiche quando puntano il muso dell’aereo dritto verso il tetto del cielo e al momento ics convenuto bloccano l’erogazione di potenza dei reattori. Il caccia continua a salire per inerzia, fino al punto morto. Cerca e trova l’equilibrio fra spinta iniziale, resistenza dell’aria e forza di gravità.
a. C’è da smaltire lo stress delle prove precedenti. L’atleta porta in alto le gambe, ben dritte, ad angolo retto rispetto alla schiena, al collo, alla testa che aderiscono al fondo della pista. Le fasce muscolari dei polpacci, delle cosce, assecondano le contrazioni chieste dallo sforzo imminente, ma subito dopo abbandonano la tensione, mandano via ogni residuo di fatica, vis dalla punta dei piedi scalzi.
b. Vibra il sediolino avvolgente, il pannello computerizzato dei comandi lampeggia e sono segnali rassicuranti. Il secondo pilota orienta il parasole snodabile, serra continuamente le mascelle, ripete un secco ok ad ogni richiesta di controllo, spera di poter compattare gli organi interni che di qui un momento saranno chiamati a sopportare un incredibile choc dinamico e avverte come sempre una febbrile accelerazione del pensiero. La tensione per l’evento si alterna a rapidissimi flash sul privato.
… Potenza, ok… Bene, andremo a Vienna per il capodanno… velocità. ok… portare le rose, da quanto tempo l’ho detto… altimetro, Roger…
L’antenna che precede l’acciaio affusolato della cabina punta l’infinito e sfida come in un assalto di fioretto i limiti del possibile. L’impennata toglie il respiro, contrae le visceri, ferma il cuore. Nervi e muscoli sono impegnati ad assecondare il volo, quasi come hanno insegnato al ciclista che poggia il corpo con leggerezza sul sellino quando è chiamato a superare un pendio ripido.
a. Ora l’attrezzo, amico e ostile quanto mai può immaginare la gente che lassù, sulle gradinate, aspetta di vivere l’emozione del volo oltre l’asticella. La stessa che spinge in alto il saltatore.
b. Il jet ripiomba in giù a bucare il soffice candore di un denso banco di nuvole. Riprendono a ruggire i motori, gli strumenti di bordo segnalano la velocità del tuffo. L’anima è quasi fuori del corpo, risucchiata dalla maestosità dello spazio
a. Le gambe impongono ai piedi un’oscillazione in sincronia contrapposta con il movimento pendolare delle braccia. Il respiro è in sincrono con l’escursione delle due fasi. Le mani stringono a tenaglia l’asta, lo spasmo coinvolge ogni centimetro del corpo Il cervello, in quei pochi secondi, vive la dissociazione che sovrappone la posizione statica nell’atto della rincorsa alla sensazione di percorrere i passi studiati mille volte, in allenamento compiuti con il carico di pesi nella cintura zavorrata. Via…le dita vibrano all’unisono con l’asta. Un piccolo sbuffo, una mano tra i capelli, la maglietta spinta nel pantaloncino, dietro la schiena, lo sguardo sulla punta delle scarpette e in alto ancora sulla punta dell’asta che si pianterà alla giusta distanza dall’attrezzo per far volare l’atleta. Sullo sfondo il sonoro degli applausi al lanciatore che ha concluso la gara, ma bem presente la ricerca di tutta l’energia necessaria, le dita virtualmente incrociate, flash sul gradino più alto del podio, i titoli dei giornali sportivi, la mesa in onda adel salto in televisione, gli anni duri degli allenamenti senza la garanzia di risultati da record, disillusioni ed esaltazioni: Ora. Passi più lunghi, attenzione alla spinta, la schiena arcuata, ecco la maledetta asticella e “dío, com’è su”. La testa, il collo, le spalle, passate oltre l’asticella…gambe raccolte, in alto il bacino, un colpo di reni. Quante volte un salto è fallito per un niente. Per il popolaccio o un piede che tradiscono. Ma anche quante volte lo scavalcamento per un millimetro, un niente.
b. Finalmente, lasciarsi andare. Atterraggio morbido, il contrario di quanto raccomandano gli istruttori di volo che vogliono un impatto deciso che agevola la frenata…ma chi ha voglia di un altro contraccolpo. Il carrello vibra, ancora cinquecento metri. Roger.
a. L’impatto con il soffice tappeto è inebriante e la schiena si piega istintivamente per agevolare la capovolta ai margini del materasso. Le mani salgono oltre la testa e si congiungono in un applauso liberatorio e riconoscenza per l’imponderabile genetico che ha predisposto il saltatore all’impresa di oltrepassare i confini delle possibilità umane.
c. Un falco plana con regale dignità, ed è volteggio elegante nel cielo limpido, appena striato di bianco da un caccia supersonico che brilla come un punto d’acciaio colpito dal sole.
Sussulta il falco, prima della caduta. Poi il secco segnale sonoro dello sparo, che l’aria trasmette con il solito ritardo.
Il corpo dell’uccello rimbalza sulla roccia, si fratturano le ali, una striscia rosso sangue finisce in una macchia larga che lambisce una foglia scurita dall’autunno.
Nell’enciclopedia della natura il falco merita venti righe tipografiche. La didascalia, accanto all’immagine a colori, è mal stampata. Il profilo del falco è molto fiero.
d. Lo speleologo inizia la discesa e la luce della superficie si spegne progressivamente. Nella grotta naturale è insopportabile l’umidità, l’ossigeno scarseggia e i limiti delle volte appena si intravedono. Un varco in basso. Il fascio di luce della torcia anticipa i passi incerti, la punta degli scarponi frena il corpo che il tracciato in discesa sbilancia in avanti.
Per quanto, andare avanti così. Fin dove sfidare il ventre sconosciuto di questa terra violata milioni di anni fa da chissà quali eventi geologici.
Un passaggio, finalmente.
Il diaframma argilloso è sottile e sotto, per quanti metri il niente? Le mani brancolano nel disperato tentativo di aggrapparsi a un appiglio. Il fascio di luce della torcia impazzito illumina il vuoto. Il vetro, la lampadina, vanno in pezzi nell’urto e i frammenti restano imprigionati nella mano dell’esploratore laggiù, in fondo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 26 marzo 2017
LA VIA TORTUOSA VIA DEL NARCOTRAFFICO
DI LUCIANO SCATENI
Nessuna inchiesta potrà mai svelare il numero e l’identità degli insospettabili che lucrano con profitti invisibili, per vie indirette protette da granitica omertà e puntano milioni di dollari sulla ruota del più allettante moltiplicatore di ricchezze. Non lo sapremo mai. Le bocche dei trafficanti di droga sono cucite con il fil di ferro, a protezione di un circuito impenetrabile. Altro, esito di coraggiose inchieste, è la dimensione del fenomeno, delle dinamiche che gestiscono il collaudato monopolio del turpe mercato.
NAPOLI
A maggio, se la primavera tarda a scalzare freddo e piogge invernali, le nubi offuscano l’azzurro del cielo e incupiscono il verde della natura, ingrigiscono prati e boschi, alvei di fiumi, intere colline, fioriere sui balconi e piccoli vasi accanto agli usci di case ai piedi di edifici antichi che s’affacciano direttamente su stradine disegnate per camminamenti umani e non altro. A maggio, ancora foglie sofferenti di ipocondria meteorologica. Grigioverdi, scolorano in più punti, s’accorciano nei bordi scuri, orli di innervature in attesa di recuperare forma e colore.
La linfa, al primo sole di stagione governa il nuovo ciclo di fioritura, scoraggia passi impietosi sull’erba, allontana forbici che recidono e prova a mandar via veleni infiltrati nella terra, impurità dell’aria. La suggestiva brevità dell’alba è asincrona rispetto al sonno di primo mattino cercato per compensare tante. Il parco si sveglia.
Nel grande letto di nozze Maria, lasciata sola, ha sofferto e consumato minuti, ore fra tremiti e paure, silenziosi vaniloqui e profezie negative, doloranti memorie, recenti inquietudini, pause di illusoria rimozione del disagio e sgradevoli ritorni all’irrequietezza. L’odore del caffè in cialde è imparagonabile all’aroma che i chicchi ben tostati emanavano prima di finire nel macinino, ridotti in polvere per la caffettiera napoletana, ma almeno la tazza in porcellana trattiene il calore e va giù piacevolmente nello stomaco vuoto. La notte di lavoro, appena andata via, ha lascito sul tavolo di lavoro un ingombro di fogli appallottolati per continui ripensamenti.
Sulla scocca della macchina per scrivere, gli spazi minuti fra due tasti l’incavo dove scorre il rullo inchiostrato su cui è rimasta incompiuta l’ultima pagina scritta, tracce di cenere e di polvere imputano a Maria peccati di pigrizia nella cura delle faccende domestiche. Dalla finestra socchiusa, s’infila il fresco pulito di prima mattina, e arrivano gli ultimi fischi del merlo che si prepara a cacciare gli insetti per i piccoli appena nati. La messa in moto delle prime auto che si dirigono ai posti di lavoro disturbano come sempre la concentrazione necessaria per riannodare il filo conduttore della narrazione e la creatività, la costruzione di una scrittura molto personale.
Il basco che Pasquale indossa è un tangibile ricordo del viaggio di nozze a Parigi, acquistato sul lungo Senna dopo la visita al Louvre, alle opere del periodo blu di Picasso e all’autoritratto di un artista a lui sconosciuto, che si è raffigurato con il basco messo in testa di traverso come usano fare i pittori. Il cappello contiene a stento la massa di capelli brizzolati di Pasquale e gli conferisce un’aria da bohémien. La fitta rete di rughe risparmia solo gli zigomi prominenti che accentuano la magrezza del volto. Il corpo si è asciugato con l’avanzare degli anni e per la fatica senza soste di un lavoro umile che gli ha consentito un tenore di vita modesto, molto dignitoso e qualche risparmio per tirare su i tre figli. Il brav’uomo inizia prestissimo a occuparsi di tenere al meglio il parco a cui è assegnato. Un sacchetto della spazzatura, squarciato, vomita rifiuti, Pasquale impreca contro il servizio di raccolta che li ha lasciati accumulare da tre giorni. In cima alla spazzatura, in un miscuglio repellente nuotano una busta di latte, foglie di lattuga, tovaglioli di carta sporchi di sugo e il foglio piegato in due di una lettera con l’indirizzo scritto a mano, a prima vista con una stilografica. Pasquale fa prevalere la curiosità sulla discrezione. Il foglio all’interno della busta è maltrattato, ma la grafia di chi ha scritto è chiara, decisa. La data è recente e il. contenuto propone un interrogativo che sconcerta Pasquale.
“…è stata una piacevolissima gita. Peccato davvero per il mancato rendez-vous ché ha guastato un fine settimana fantastico. Sento il bisogno di rivederti al più presto. Mi manchi molto e chissà se la prossima volta ci riuscirà di vedere gli amici che dovrebbero contattare Berlino per il nostro viaggio. Spero tu sappia che ora puoi contare pienamente su di me e che potremo centrare l’obiettivo che ci unisce”.
Precedono e seguono queste righe che sembrano in codice, poi banalità e convenevoli. Soprattutto è strano che la lettera sia indirizzata all’ingegner Walter Donise da un certo Herbert Klotzinski: alcune frasi si direbbero proprie del linguaggio tra innamorati. Tra omosessuali?
A Pasquale per un momento sembra di veder confermate le impressioni sull’ambiguità dell’ingegnere che conosce bene da molti anni.
* * *
BOLIVIA
 Le foglie quaggiù sono di un colore indefinibile, di forma regolare, sottili, e diffondono negli sconfinati campi un odore penetrante. Si direbbe di muschio e cannella, un odore dolce e contemporaneamente aspro, selvatico, mieloso.
Le foglie quaggiù sono di un colore indefinibile, di forma regolare, sottili, e diffondono negli sconfinati campi un odore penetrante. Si direbbe di muschio e cannella, un odore dolce e contemporaneamente aspro, selvatico, mieloso.
I raccoglitori hanno le rozze camicie di tela intrise di sudore, a chiazze sul dorso e intorno alle ascelle, sul petto, dove la stoffa incontra lo sterno.
I più portano a metà fronte un fazzoletto arrotolato che impedisce ai capelli lunghi e neri di ricadere sugli occhi e trattiene le gocce di sudore. Un doppio nodo li ferma dietro la nuca. I piedi sono malamente protetti da sandali di cuoio, le mani mostrano il tormento di mille impercettibili ferite provocate dal taglio delle foglie più giovani, affilate come lame. Sorveglianti armati controllano il lavoro di raccolta retribuito a cottimo, condizionato da produttività esasperata, pena il licenziamento. Molti raccoglitori sono giovanissimi, il corpo immaturo e volti invecchiati precocemente dalla fatica.
Ai margini del campo sostano camion decrepiti, sgangherati da infiniti percorsi su piste malandate. Gli autisti aspettano a lungo il carico e il via per un nuovo trasporto fino all’immenso capannone dove le foglie si ammassano in attesa di un primo trattamento a cui provvede una trentina di donne di tutte le età che iniziano il lavoro alle sei del mattino e lo finiscono alle cinque del pomeriggio. Gli stessi camion le riportano ai villaggi di provenienza e il tragitto è occasione per recuperare qualche energia in vista delle fatiche domestiche. Le foglie cadono una a una nelle ceste, selezionate per grandezza e integrità. Finiscono nella grande vasca al centro del capannone dove sono rimestate fino a lasciare terra e polvere sul fondo.
Attorno al perimetro interno della “fabbrica” una serie di cavalletti sostiene larghe ceste di fibra intrecciata su cui si poggiano le foglie ad asciugare. Un tanfo insopportabile appesta ogni cosa. Il caldo umido, tropicale, ristagna nel locale dove inizia il lungo viaggio delle droga in mezzo mondo.
BERLINO OVEST
 Dove la Bunderstrasse si slarga per ospitare i tavoli all’aperto, riparati da eleganti ombrelloni e illuminati da lampioni di antica foggia, una storica birreria promette la scelta fra le migliori marche nazionali nazionali ed estere. Sul boccale campeggia un coloratissimo stemma con due leoni simmetrici che poggiano una zampa su una botticella da cui sgorga spumeggiante birra e riempi un boccale tra le mani di una stupenda mano femminile avvolge con voluttà. L’uomo che sorseggia la Lowenbrau alla spina ha l’aria dell’impiegato che a fine settimana prende la sbornia rituale e lascia a casa la noia di una vita senza imprevisti e con uno stanco rapporto matrimoniale.
Dove la Bunderstrasse si slarga per ospitare i tavoli all’aperto, riparati da eleganti ombrelloni e illuminati da lampioni di antica foggia, una storica birreria promette la scelta fra le migliori marche nazionali nazionali ed estere. Sul boccale campeggia un coloratissimo stemma con due leoni simmetrici che poggiano una zampa su una botticella da cui sgorga spumeggiante birra e riempi un boccale tra le mani di una stupenda mano femminile avvolge con voluttà. L’uomo che sorseggia la Lowenbrau alla spina ha l’aria dell’impiegato che a fine settimana prende la sbornia rituale e lascia a casa la noia di una vita senza imprevisti e con uno stanco rapporto matrimoniale.
L’amicizia con un colonnello dell’esercito della Germania orientale, carico di medaglie e desideri repressi dì benessere materiale, gli ha consentito di entrare a Berlino ovest senza troppe difficoltà e di incontrare il mediatore italiano di un affare che spera gli renda tanto quanto basta a passare nella zona occidentale con un congruo conto banca. Il volo della Lufthansa ha rinnegato la tradizionale puntualità, ma per responsabilità indipendenti dalla compagnia aerea. Il ritardo si deve allo sciopero del personale di terra e l’aereo ha decollato con trentacinque minuti di ritardo. Il comandante ha recuperato qualcosa, ma qualcosa ha perso di nuovo nell’avvicinamento alla pista d’atterraggio che la torre di controllo gli ha interdetto per dieci minuti in attesa di trovare il varco utile nel traffico intenso. L’albergo è frequentato in prevalenza da uomini di affari e da partecipanti a quattro diversi convegni. Il rendez vous con il mediatore avviene come previsto.
VENEZUELA
Dodici chilometri ad ovest di Caracas, ma è più corretto dire ad ovest dell’area metropolitana della capitale del Venezuela, ai margini di un’imponente superstrada dal manto appena rifatto, scuro come la pece, è netta la linea gialla che delimita la corsia d’emergenza, appena realizzata; da sud ovest il vento di libeccio s’arresta contro la nitida barriera di calcestruzzo attorno all’agglomerato industriale che denuncia esplicitamente il trapianto nella terra del merengue di un’impresa tedesca che esibisce il marchio di fabbrica al culmine d’una torre d’acciaio e vetro fumée, regno del management aziendale. Dal belvedere è ben visibile il disegno dell’intero insediamento che il verde macchiato di fiori circonda con generosità attenuando la spigolosità degli impianti di produzione e il rumoroso andirivieni di camion e auto di servizio. Magazzino e reparto spedizioni spuntano dall’insieme dello stabilimento come una proboscide protesa in direzione dello svincolo della viabilità interna che immette nell’Avenida Santa Maria, di là della barriera che pone al riparo da sorprese quanto non deve essere riservato.
* * *
Lo schema del traffico di droga non conosce anelli deboli nella catena di complicità internazionali. La “roba” filtra indisturbata attraverso gli smisurati confini del Venezuela, nei varchi controllati da personale compiacente. Sono quasi tutti colombiani i corrieri della droga.
Lungo le ripide pareti d’argilla delle colline che circondano Caracas, di notte centinaia di ranchitos, sconfinato presepe della marginalità, brillano come un firmamento nelle notti senza luna. Migliaia di baracche, casupole, catapecchie affastellate l’una a ridosso dell’altra, sono intrise di odori umani, del tanfo di fogne a cielo aperto, di pozzi neri traboccanti liquami, di sudore e miseria. Dalle misere abitazioni filtra la luce di lampadine accese in permanenza. La gente dei ghetti non paga bollette, ruba semplicemente l’energia elettrica con allacciamenti volanti e abusivi alla rete. Furto è anche il prelievo di acqua dalle conduttore municipali. L’abitare da terzo mondo di migliaia di clandestini incombe sul tortuoso alveo di un fiume in piena, un fiume di cemento e nastri d’asfalto brulicante di umanità e automobili. I venezuelani danno i numeri quando azzardano la conta delle anime di desperados, colombiani e indios che affollano i ranchitos. All’anagrafe non v’è traccia di un paio di milioni di abitanti di questo formicaio senza identità.
Il Venezuela accoglie da sempre la consistente colonia di italiani che s’arricchiscono per doti di intraprendenza e trafficano, mettono su imperi, mantengono intere stirpi di parenti rimasti in patria a custodire terre e paesi semivuoti dove affluisce il denaro accumulato dagli emigranti. Non per tutti è ricchezza, soprattutto per gli ultimi arrivati che spesso finiscono per arrangiarsi con traffici oltre il lecito.
La repubblica presidenziale fa perno come in più terre di questo emisfero sui militari, sulla policia e i vigilantes fedelissimi al regime. Li trovi per ogni dove, ti senti osservato, spiato.
Caracas è città blindata, specialmente in centro, dove ha sede il “Congresso” che svetta con i pinnacoli dell’edificio centrale in stile coloniale, la
sede del consiglio municipale, nella piazza Bolivar dove la statua dell’eroe nazionale sembra vigilare su turisti e indigeni mentre godono la frescura del verde fitto che avvolge grandi fontane invase dal muschio.
La middie class di Caracas, nonostante il gran caldo, indossa giacche invernali, di foggia approssimativa. Le donne non dismettono mai pesanti pullover lavorati con i ferri. Giovanotti e senioritas esibiscono versioni tropicali del casual marcato Benetton, Stephanel, Lacoste ma il gusto dei più sembra aver subito influenze nordamericane e dunque prevalgono i tessuti sintetici, accoppiamenti azzardati di colori, scarpe per ogni stagione, accessori orrendi, cravatte inguardabili, calzini bianchi, corti.
Attorno al “Congresso” di tutto: lacrimevoli mendicanti, sciuscià in attesa di rari clienti, la banca “Ipotecaria de Caracas”, pittori della domenica e miniaturisti che riproducono composizioni floreali su specchi di piccola dimensione. Qualche panchina appartata calamita gruppetti di beoni. Di sotto cartocci stropicciati spunta il collo di una bottiglia, in mano tengono bicchierini di plastica che si riempiono di continuo, furtivamente.
Sui volti sofferenti e negli occhi acquosi l’alcol ha fissato l’impronta di solitudini desolate ed esclusioni dal vortice della ricchezza intrisa di petrolio che il Venezuela ha esportato. Quasi l’unica risorsa del Paese. Lungo la levigata Avenida, che collega l’aeroporto alla capitale, filano veloci le Buick e monumentali Ford, in un caos di sorpassi a cui contribuiscono le automobili italiane, Fiat 127, vecchie 131. Gli uomini dei taxi offrono simpatia a buon mercato ma fino al momento di riscuotere. Diventano allora ladroni come i conducenti ateniesi e gli abusivi napoletani. È’ sempre una corsa special e se il tassametro segna 20 bolivar te ne chiedono 50. Irregolari sequenze di modesti insediamenti urbani sono le quinte povere del velleitario verticismo dei grattacieli. Con una pietosa ipocrisia formale si tenta di attenuare il generale grigiore con la pitturazione di facciate degli edifici prospicienti le vie principali, ad opera di giovani artisti locali
La noche migliora tutto e l’Avenida Bolivar assume suggestioni notevoli. L’habitacion del Caracas Hilton Hotel, dall’alto di una delle due torri alberghiere, domina gli scenari notturni. Ai suoi piedi manda bagliori l’azzurro di piscine illuminate a giorno e poco discosti sono in piena attività i courts del tennis club. Oltre, è in contrasto un’ampia zona d’ombra, rotta a tratti dai fari di auto che sfrecciano a velocità proibite. Dentro le visceri di questo ventre che pulsa è tutto meno luccicante.
La hall dell’albergo Estrellita è una piazza d’armi caotica, invivibile. Nell’habitation, che avrebbe necessità di urgente restauro, accanto al letto c’è un tavolino traballante. Sul piano un secchiello da ghiaccio contiene una bottiglia di vino bianco e alla base un biglietto del direttore il bienvenido all’ospite che a giudicare dalla polvere che si è accumulata manca dalla stanza da parecchi giorni. Il bagno è da discreta pensione tre stelle e l’acqua del rubinetto ha un sapore sgradevole. Ma ancor prima di accedere all’appartamento è tassativo riempire un complicato modulo e versare il corrispondente di due giorni di permanenza come cauzione. La misura si colma dopo una consumazione in uno dei bar che s’affacciano sulla piscina, di giorno meno attraente del previsto. La bibita deve essere pagata in contanti, preferibilmente in dollari e non addebitata sul conto come usa in ogni albergo, sotto qualunque latitudine. Neppure il tempo di incavolarsi e il fattorino è alla porta, ricevuta alla mano, per incassare l’importo del drink consumato cinque minuti prima. La porta della stanza si chiude dietro di lui con un tonfo sinistro.
Il Daily Journal annuncia raffinate pietanze italiane “…very near the hotel Tarnanaco”, presso “Il Cortile”, dove si possono gustare “the best italian specialites in the town”. Nel piatto navigano quindici rigatoni conditi da un’un’imitazione patetica del ragù. La pasta è scotta e il vino “blanco”, presentato come Pinot, è identico al confratello cileno, in verità non male, servito nella plaza del Congresso.
A “Las Mercedes”, quartiere commerciale dominato dal “Tamanaco”, il tassista finge smarrimenti e smemoratezza e prolunga la corsa di almeno un quarto d’ora. Il tassametro gira. Lungo i viali animati da invitanti insegne luminose di discoteche e birrerie, tacchi a spillo, coloriti olivastri e forme tozze, passeggiano le sehoritas che vendono se stesse fino all’alba, quando l’ultimo adescamento è mirato alla richiesta di un passaggio verso la povera periferia, dove colonne di jeep trasferiscono le contadine stagionali ai luoghi di lavoro: la temperatura media oscilla fra i 32 e i 38 gradi, con minime escursioni tra giorno e notte. Il cielo è raramente terso e lascia cadere una pioggia fitta e minuta che fatica a bucare la coltre di umidità. Lungo le principali avenidas gli orologi digitali scandiscono il tempo e sembra un continuo monito presidenziale alle produttività. Il caldo non è opprimente, forse per effetto dell’aria condizionata che ti piove addosso dappertutto e asciuga il sudore, le mucose. Alberghi, negozi e ristoranti sono filiali dell’Antartide.
Alla fine del soggiorno, la “cuenta” e l’Hilton sforna una striscia della stampante lunga un chilometro. 1l “compudore” è impazzito e riporta all’infinito l’importo di due telefonate. Controlli su controlli, una via vai di addetti sempre più blasonanti, l’errore salta fuori, le scuse no.
La via d’uscita da Caracas ripropone i termini di forti contraddizioni fra l’antica opulenza del centro e la desolazione dei ranchitos. Sullo sfondo di un cielo lugubre, che minaccia tempesta, le sagome delle “Torri del Silencio”, altissime. Sono lo scandalo nazionale. Rischiano di crollare alla prima scossa di terremoto. Che fare? Abbatterle, è la soluzione estrema, o consolidarle, ed è la tesi che prevale. Saranno segate alla base, sospese su supporti provvisori e ripiantate al suolo su solide fondamenta. Le Torri si chiamano del silenzio per il singolare uso dei suoi piani bassi. Inizialmente erano luoghi di malaffare, dove trovare un paio d’ore di piacere a pagamento. Le donne per catturare i clienti sussurravano inviti a voce bassa per non offendere il moralismo dei vicini. Di qui la definizione “Del silencio”. S’incrociano bus sgangherati, strapieni, sporchi. Nel 1974 la municipalità aveva acquistato tremila nuovi automezzi per il trasporto urbano ma neppure uno ha mai percorso le strade della capitale. Sono spariti semplicemente, dieci a dieci, fino all’ultimo, e con loro è sparito anche il procuratore delle provincia di Caracas. In compenso la prima linea del metro è considerata monumento nazionale. Non c’è tributo all’opulenza come in quella moscovita, con i suoi specchi, i legni pregiati e i fregi in stucco dorato. Piuttosto è la replica di fredde sotterranee della penultima generazione. Nella stazione di plaza Bolivar la grande vetrata multicolore manda bagliori da cattedrale. La diffusione del malcostume ha indotto a inventare un dispositivo di accesso alle stazioni che impedisce la frode. Alle barriere di ingresso un congegno di sicurezza vieta di superare il controllo se non s’infila il biglietto in una fessura. In caso contrario, una sirena assordante segnala l’infrazione.
Nelle vicinanze della stazione del metrò si staglia il palazzo della Camera e del Senato. È’ bianco come la neve, cancellate e fontane sono per estremo contrasto di un nero totale, lucido.
All’interno del complesso stupiscono gli ordinati filari di altissime palme, dritte come pali dell’illuminazione. La sala dell’esecutivo si divide in tre navate, quella centrale è dominata da una volta affrescata, di inconsuete dimensioni ed effetto prospettico. Descrive la guerra di liberazione guidata da Simon Bolivar. La ricostruzione, fedele, si direbbe da cronista, si deve al racconto diretto di uno dei sopravvissuti. Fuori dal Campidoglio venezuelano la piazza è animata e si fanno ammirare le bellissime indios dai capelli corvini, raccolti dietro la nuca.
Sui muri del giardino pubblico una sarabanda di scritte murali. Uno dei graffitti dice: “Dio, salvaci dalla nostra indole” ed è un esorcismo contro la storica pigrizia sudamericana. Sulla strada della “Guaina”», di nuovo, ossessionanti, i ranchitos. Alla domanda “Si possono visitare?” il tassista scuote la testa come avesse a che fare con un matto: “Entrare nei ranchitos… senor… impossibile”. Il rischio di esser accolti a colpi di pistola non è la sola ragione che sconsiglia l’azzardo. Lassù la gente ce l’ha con il mondo intero. Le fragili costruzioni poggiano sul niente e alla fine della lunga stagione delle piogge, in dicembre, non resta che contare i morti. Le frane trascinano a valle dieci, venti, cento casette e i loro abitanti. In un solo disastro sono _morte cinquemila persone. Oltre la montagna, in vista dell’oceano, le faraoniche trivelle sono pezzi di archeologia che la vecchia guardia della compagnia petrolifera di Stato descrive ai visitatori come le guide dei musei magnificano le opere esposte. Recitando a memoria una filastrocca di cui non colgono neppure più il senso.
Di là dalle migliaia di ettari che ospitano gli impianti di pompaggio, larghe distese di macchia verde, i pascoli di floridi bovini e uno squarcio tra la vegetazione dove alberelli rinsecchiti, si direbbero fossili, accolgono una rara specie di neri avvoltoi che da secoli si posano solo qui per lenire la fatica delle trasmigrazioni e di ali pesanti come piombo. Di là dalle centinaia di ettari di verde ci sono le piattaforme d’estrazione, ancorate al fondo di un mare blu che le ospita con rassegnazione. L’oro nero ha prodotto per decine di anni ricchezza folle, Cadillac di lusso degli abitanti di Caracas e “graspaciel” di quaranta piani. La gente dei ranchitos è arrivata a migliaia, poi milioni, con l’illusione di bagnare almeno un dito nel petrolio.
Neppure la guardia nacional si avventura su per le vertiginose scalinate, unica via di approccio ai desperados che per mille tortuose discesine si infiltrano in città per rubacchiare. Caracas si difende come può. Villette e palazzi somigliano a prigioni, finestre e balconi sono protetti da solide sbarre. Dicono i venezuelani che fino al terzo, quarto piano, servono a difendersi dai ladri, mentre ai piani più alti impediscono ai bambini di spiccare voli mortali nel vuoto. La maggior parte dei ragazzini, cresciuta nella cultura dei cartoni animati d’azione, s’illude di essere come super-man che tutto può, anche volare dalla finestra. Il regime, soprattutto ai tempi della dittatura militare, ha provato a liberare i dintorni della città dalla pressione degli “invasori”, li ha spinti oltre il confine. Solo che la linea di frontiera è infinita e impervia. Indios e colombiani sono sempre rientrati e occupano ogni volta le loro stamberghe.
I bambini non conoscono alternativa ai tuguri che gli adulti indicano come una sorta di terra proibita per gli estranei, dov’è garantita l’impunità dopo i rapidi raid in città.
Piove. Continua a venir giù l’acqua e lo sguardo delle donne è accigliato. Quasi tutte vestono a lutto. Ognuna ha un fratello, un parente, un amico, finiti nel magma viscido delle grandi frane. Su per un passo di montagna senza sentieri tracciati, due colombiani marciano sicuri e silenziosi. Negli zaini nascondono stracolmi di eroina per milioni di dollari. Altri li hanno preceduti, altri li seguiranno. Si dirigono verso casa, ammesso che i ranchitos si possano chiamare così..
Una vecchia, dignitosa Ford, è in attesa sotto una cavalcavia, con il motore acceso. Sulla fiancata del camioncino campeggia l’insegna dell’impresa di pulizia specializzata nel settore uffici e industrie.
Sono le tre del pomeriggio. Nel casello, all’ingresso dello stabilimento, Simon è nervoso. Non che disprezzi i bolivar ricevuti puntualmente, tre volte più del salario di guardiano, ma è non riesce a liberarsi della paura di essere scoperto, licenziato, arrestato. Il camioncino passa indisturbato il controllo e si dirige a velocità moderata verso il magazzino. La droga è nei sacchetti della biancheria pulita. Giuseppe, immigrato da Matera da una decina di anni, la stipa nell’armadietto personale. È l’ultimo a lasciare il locale e chiude la porta scorrevole, protetta da una doppia serratura.
Il carter del macchinario va via in un attimo, il cacciaviti gira senza fatica e i quattro piccoli perni escono dall’impanatura agevolmente, scoprendo la piastra d’acciaio ben serrata al supporto da bulloni. All’interno, tre grandi incavi separano i congegni meccanici e lì vengono sistemati i sacchetti di eroina, fissati alla parete liscia con larghe bande di nastro adesivo. Su un angolo della cassa di imballaggio, l’uomo traccia un segno indelebile, difficile da individuare tra le venature del legno, ma inequivocabile per chi conosce il messaggio in codice.
BERLINO OVEST
Nell’hangar dell’aeroporto di Berlino Ovest il doganiere controlla secondo le regole
dell’indagine campione la merce appena sbarcata dal Jumbo della compagnia venezuelana di bandiera.
Hanz Voller ha ottenuto di entrare in servizio proprio nell’arco della giornata in cui è previsto l’atterraggio del volo bisettimanale da Caracas. Apre cinque delle venti casse e non gli si può certo imputare negligenza, ma verifica solo le cinque balle non segnate, vista i pass e avvia la merce al reparto consegne. Nell’officina collaudi dell’azienda a cui è affidata la rappresentanza dei macchinari, Franz apre una delle casse e stiva i sacchetti di droga in uno degli imballi vuoti che contrassegna vistosamente. Lo richiude con cura e sigilla i documenti di accompagnamento dei macchinari. Un furgoncino si muove in sincrono con i gesti di due operai che affastellano le casse vuote nella strada senza uscita alle spalle del deposito. Due manovali si avvicinano e le caricano rapidamente. A marcia indietro, il piccolo automezzo s’allontana.
NAPOLI
Il racconto di Maria è all’epilogo:
“L’ingegner Donise è irrequieto. Getta via `Der Spiegel’ che finisce con le pagine spalancate accanto alla poltrona nella stanza d’albergo che ha raggiunto in taxi dall’aeroporto. Si alza dal letto e infila le babucce di carta sui è impressa la sigla `LIS’ dell’hotel, apre il frigo-bar e afferra una bottiglia di birra. La spuma trabocca dal bicchiere e si slarga sullo chassis del televisore. Il primo sorso lo disgusta. L’ingegnere dà un’occhiata all’orologio. Deve muoversi se non vuole rischiare che il traffico gli giochi brutti tiri.
L’uomo con cui deve incontrarsi non è quello che si dice una persona gradevole, ma è sicuramente l’uomo giusto per portare a conclusione un’operazione complessa e rischiosa. Quando i due si lasciano, il percorso occidentale dell’affare ha passato la mano alla zona est di Berlino.
Donise ha in tasca la ricevuta di una rimessa a suo nome e la sua parte è di un quarto dell’intero importo, depositato in una banca lussemburghese. Nella hall dell’albergo si trattengono le mannequin che tra poco sfileranno nella sala Mirage, per presentare la collezione di uno stilista francese che la Germania ama da tempo.
Sono donne che evocano il lusso, e giri mondani di altissimo livello. L’ingegnere si chiede se siano anche abbordabili e a quale prezzo. Nel bar c’è la solita atmosfera di finta intimità, grazie a luci molto soft, alla musica lieve, melodica. Il secondo stinger è andato giù nello stomaco quasi d’un sorso. L’agenda, poggiata sul tavolino accanto al bicchiere, gli ricorda l’impegno di comunicare l’esito della operazione.
In successione, telefona al direttore del marketing dell’azienda tedesca da cui dipende ed è un colloquio di lavoro. L’interlocutore non immaginerebbe mai di fornire inconsapevolmente la copertura al traffico di eroina che i macchinari spediti dal Venezuela hanno permesso con molteplici complicità.
La comunicazione successiva è l’annuncio del rientro a Napoli per l’indomani mattina.
MOSCA
 Attorno all’hotel Rossia i pittori itineranti interpretano le cupole d’oro e d’argento della piazza rossa, quelle del Cremlino ancora illuminate dal sole. Una ragazza dipinge con la spatola e sono forme e colori netti, quasi geometrici. La scatola degli oli è larga e alta. In superficie i tubi variopinti poggiano su di un ripiano di compensato. Nella parte inferiore, ben ferme, le bustine di eroina.
Attorno all’hotel Rossia i pittori itineranti interpretano le cupole d’oro e d’argento della piazza rossa, quelle del Cremlino ancora illuminate dal sole. Una ragazza dipinge con la spatola e sono forme e colori netti, quasi geometrici. La scatola degli oli è larga e alta. In superficie i tubi variopinti poggiano su di un ripiano di compensato. Nella parte inferiore, ben ferme, le bustine di eroina.
Un giovanotto allampanato sembra vagare senza scopo. Ha gli zigomi paonazzi, irritati dal vento tagliente che agita le bandiere del Rossia, il grande albergo per stranieri e gli alberi secolari che lo circondano. I capelli sono biondissimi e arruffati. Gli ricadono sulla fronte e sugli occhi, le mani affondano nelle tasche del giaccone. Si ferma alle spalle della ragazza e scruta il suo lavoro. Azzarda un commento ed è anche la parola d’ordine richiesta. Non c’è altri nei dintorni. La ragazza avvolge un piccolo quadro in un foglio di giornale e lo consegna al giovanotto che paga il dipinto con duecentocinquanta dollari ricevuti da un turista in cambio di rubli, al mercato nero. Fra la tela e il cartone, nella parte posteriore della cornice, cinque dosi di eroina”.
NAPOLI
Pasquale accende con un fiammifero da cucina un foglio di giornale attorcigliato e dà fuoco al mucchietto di foglie secche raccolte ai margini della strada. Non c’è vento, nessun rischio.
Lo spazzino, spingendo la carriola, risale il parco tante volte percorso sotto il sole e la pioggia.
Maria è al balcone, una sigaretta fra le labbra, i capelli ancora disordinati, lo sguardo rivolto al mare che stamane sembra incendiato da una luce accecante. Il racconto è finito, l’ansia l’ha lasciata.
Pasquale la saluta con rispetto, ma nel cenno del capo c’è una qualche indulgenza a un rapporto confidenziale. Dopo tanti anni s’è fatto l’idea di essere “uno di famiglia”.
Avrebbe voglia di condividere con Maria i pensieri sulla strana lettera trovata fra i rifiuti, ma perderebbe il vantaggio di continuare a curiosare indisturbato tra le cose gettate via che rivelano piccoli e grandi segreti della gente del parco.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 19 marzo 2017
DENIS & FRANCOISE
di Luciano Scateni
Gli esperti pensano che il surrealismo sia una diretta emanazione della creatività. A torto o a ragione? Il mini racconto a cui danno il titolo due nomi d’oltralpe può forse sconcertare chi ha confidenza con la scrittura “soggetto, predicato verbale, complemento oggetto”. Eppure, adottata la variante di parole su parole che si presentano alla scrittura in apparente anarchia, il gusto di sequenze a prima vista senza senso, rivela interessanti, fantasiose associazioni, da “subire” senza opporre resistenza. Tutto vero? Di seguito la controprova
Denis è un nome diverso da Francoise e Francoise a me, a voi, forse non dice nulla.
Per Denis è un viso, forse un cervello e gesti, bugie, il gusto della sorpresa. Lacrime e bestemmie, voglia, ovviamente di far l’amore e disgusto per l’incenso e vigliaccheria, patriottismo e lampi di follia, un incerto incidere sulle punte, il racconto di un’opera prima, cronistorie d’ammazzamenti e fotografie delle Alpi senza neve e una lettera mai spedita, alvei di fiumi verdi di schiuma e bianchi d’invidia, profumi d’inverno, occhi biondi e trecce tristissime. Versi di canzoni antiche, rivissute con commovente adesione, ance di oboe e nuvole oltre le ciminiere spente, caschi gialli e mute mongolfiere, la Guzzi del ’68, cornici in ghisa di Lefkas, affilate poppe di gozzi, “Carmela” scritto in blu marino, avamposti di iceberg insanguinati e la bora che andava a cento all’ora, whisky appena distillati, ambra e giade, fulmini a ritroso, “La pelle”, tredici ore di dolore, smalto nero sulle unghie di Rosa e invadenti carezze, libri sul pavimento, alto fino al soffitto, occhiali per i raggi di Venere, un cobra in agguato. E uccelli di cristallo, onde opache di stagni e grida di ladri smascherati, paura delle rose, stazioni nel caos.
Parole dentro parole, the split brain, àncore di velieri, ruote di diligenza, perle macchiate di sangue, inchiostro di seppia, grammofoni a tromba. Specchi del settecento e negli specchi facce di mimi impropri, parlanti, profili di puttana, il parto trigemino di neonati svedesi, gocce di miele con retrogusto di nespole made in Japan, il blu di “Volare” e il sassofonista bianco, mantelli di masnadieri, l’Odissea e notturni di Armani, undici apostoli, il narghilè, due virgole, l’impronta di stivali dello zar. Chiavi per la porta del Vulcano, un’inverosimile equazione, una pillola nucleare, acqua del cielo riflessa sul culmine di botti di rovere e depositi di pioggia sahariana sul davanzale di marmo rosanero, insolenti svastiche e tre volte la lettera «h», il tempo in display, processioni e insulti, seni d’adolescente, il lancio finlandese del giavellotto, sussurri di slanci vietati, echi nel cuore di Erinni, overdose di lamenti, escursioni erotiche, il camoscio e grappe clandestine, squadriglie acrobatiche, il tricolore abusivo attorno al ventre del sindaco donna, spider in sorpasso, velli d’argento, fili d’Armenia, teste di tartufo irpino, il
Macassar, otto coppie di sposi, fotografi di piazza nascosti dal panno nero, la nudità di Anita, l’Étoile di Vigevano, rose verdi e indios di Maracay, un atollo spazzato via per veder l’effetto che fa un’ atomica lasciata scendere da cieli azzurri, Picasserie e le diete di Ugolino, il tango cinese, Garibaldi conteso, laghi di pietra, il fish eye della Contaflex Zeiss.
Cernie incinta, accecanti occhi di bue su caschi di partigiani, diamanti tagliati in sedicesimo, trombe d’auto rauche e marinai sull’attenti, l’Acropoli e il trio Lescano, microfoni nascosti, Leningrado alle otto di sera e accenti circonflessi, flamenco e anticicloni, sette uomini in piazza S. Babila, spavaldi, la Comune, pattini di ghiaccio sul niente, il mito di Abdul Jabbar, le vittime di Erode, la costa scoscesa-incontaminata di Scozia, ali di falco e pitture sui volti di attori ungheresi, maschere aggressive di pellirosse.
Fuori, sui prati di castelli della Loira, setter sazi e bracchi affamati, cinghiali sdentati, maiali con maschere di politici, tombe profanate e cadaveri in polluzione, pedofili bastonati, sbuffi di Solfatara, missili iracheni, il Mar Nero e gerani spogli, killer calvi e il circo di Mosca. Aureole di Madonna, contraccettivi, donne diseredate, Flashing Madows, vele di “star», aquiloni galleggianti nell’ozono, il ghibli silenziato dal controvento, un repassoir di Maria Antonietta, corazzate Potiomkin, casseforti scassinate, referendum sull’acqua alta della laguna, Biennali podistiche, la Fenice rigenerata, percussioni di Brunamonti, genio bolognese del parquet.
Marzo e l’ibernazione di Burghiba, Luciana Castellina, piccoli di foca arpionati, cori di castrati, Dixieland e  dracme cartastraccia, veli di omertà, vergini prostitute e sprazzi di paranoia, fughe di Weber, una rosa sul Tibet, trance involontarie, chele di granchi bisessuali, merli di torri maltesi e labirinti di Oreste, le turbe di Mabuse, il bello di barattare il bigottismo con l’esuberanza di Belzebù, flash di luna, Maddalena in clausura, le catene di Sebastiano, roghi per i Beati e cieli pazzamente radiosi per assassini ladri mentitori blasfemi e violenti infingardi stupratori pettegoli sodomizzatori tiranni digiunatori unni, plagiatori pessimisti e collaudatori, saturnini, guardie svizzere e transessuali, confessori, regine e puritani, agenti di borsa e peronisti, guardoni, imbecilli, masturbatori, attori e sommelier, portieri di notte, ottimizzatori, cronometristi, lanciatori di biglie, disinfestatori e marines, becchini che scavano fosse nel mar Baltico, collezionisti di alabastro e lavagna, elefanti bicolore, conchiglie viola, planetari di plastica, orche masochiste, batiscafi in orbita, tentazioni congelate, criptotangheri, mengheliani, post-freudiani, cafoni, ancelle di Dallas, pedinatoti di fedifraghi, sbandieratori suonati, pugili atterrati e femmine di Oceania, baldracche di Scampia, trentenni psicotiche, eroine violentate, stolte estetiste e furbe arrampicatrici.
dracme cartastraccia, veli di omertà, vergini prostitute e sprazzi di paranoia, fughe di Weber, una rosa sul Tibet, trance involontarie, chele di granchi bisessuali, merli di torri maltesi e labirinti di Oreste, le turbe di Mabuse, il bello di barattare il bigottismo con l’esuberanza di Belzebù, flash di luna, Maddalena in clausura, le catene di Sebastiano, roghi per i Beati e cieli pazzamente radiosi per assassini ladri mentitori blasfemi e violenti infingardi stupratori pettegoli sodomizzatori tiranni digiunatori unni, plagiatori pessimisti e collaudatori, saturnini, guardie svizzere e transessuali, confessori, regine e puritani, agenti di borsa e peronisti, guardoni, imbecilli, masturbatori, attori e sommelier, portieri di notte, ottimizzatori, cronometristi, lanciatori di biglie, disinfestatori e marines, becchini che scavano fosse nel mar Baltico, collezionisti di alabastro e lavagna, elefanti bicolore, conchiglie viola, planetari di plastica, orche masochiste, batiscafi in orbita, tentazioni congelate, criptotangheri, mengheliani, post-freudiani, cafoni, ancelle di Dallas, pedinatoti di fedifraghi, sbandieratori suonati, pugili atterrati e femmine di Oceania, baldracche di Scampia, trentenni psicotiche, eroine violentate, stolte estetiste e furbe arrampicatrici.
E Denis è solo un nome. Diverso da Francoise.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 12 marzo 2017
LA PUBERTA’ DELL’INFANTE SIRIGNANO
Un brano tratto dal nuovo libro di Luciano Scateni “Su e giù con la morte”, Alessandro Polidoro editore
 Lassù, di là dalle nubi spesse come talco, gira senza pause la ruota della fortuna, ma per Giampiero dei Sirignano s’è fermata in bilico tra “che culo, hai vinto un miliardo” e “jella nera, hai perso”.
Lassù, di là dalle nubi spesse come talco, gira senza pause la ruota della fortuna, ma per Giampiero dei Sirignano s’è fermata in bilico tra “che culo, hai vinto un miliardo” e “jella nera, hai perso”.
La sua vita di nobiluomo, con possedimento campagnolo in Terra di Lavoro e magione d’epoca nel decumano maggiore di Partenope, attraversa spavalda il ventre molle della fortuna e non è detto che ne esca sempre baciato in fronte. Egli è di casa negli studios Rai di Cinecittà, dove regna lo star system, è ospite ambìto dei tele schermi in format semiseri o decisamente frivoli che inducono a lacrime e letizia i pomeriggi e le prime serate delle brave massaie. Narrano con tecnica collaudata e in dosi intensive amori contrastati, infelici, tradimenti che inducono a commozione gli animi specialmente sensibili; catturano l’audience in fasce di fruitori con modesta dotazione culturale. Propongono spazi di comicità cabarettistica di outsider della risata, e una valanga di thriller e action movie d’importazione (che quelli di casa nostra sono patetici), incursioni in soggiorni coatti su isole deserte, virtuosismi di irresistibili star della fiction che operano in sala parto, pronto soccorso, sala operatoria.
Tra amici, parenti e fan, il Sirignano è abituale destinatario di commozione muliebre per quel suo permanere nella dorata condizione di ricco single, matrimoniabile al mille per mille che la previsione funesta di una cartochiromante- astrologa ha però definito, ahilui, “a termine”. La megera, senza attenuare il verdetto, ha predetto «Creperai di morte violenta».
* * *
Come descrivere la pubertà dell’infante Sirignano: momentaneamente drammatica per una concomitanza di eventi funesti. Colpiti da mali fulminanti, volano in cielo in ravvicinata successione, sorella e fratello. Il “signorino” è consolato da generosi amici di famiglia, sostituti di padre e madre che se ne vanno contemporaneamente nel mondo dei più, schiantati con l’auto sul tronco di un platano secolare.
Un paio di potenziali concorrenti alla faraonica eredità familiare non hanno mai visto la luce, aboliti dal ginecologo Faustirti con studio di abortista clandestino dirimpettaio del lungomare napoletano, “cucchiaio d’oro” in operosità perpetua e il vizietto di palpare proditoriamente esuberanti clienti incinte. I numerosi raschiamenti d’utero di casa Sirignano si devono alle capaci e intemperanti sacche riproduttive del fu padre-patriarca. Il nobile signore, barone per antica discendenza, ha trombato femmine di pari grado, sguattere e meretrici del “29”, bordello sito all’esordio della via Nardones, tutto mattonelle in ceramica a disegno floreale, piastrelle finto Vietri nei cessi e micidiali sgradevoli odori, propri di ogni casino che ospitava con cadenza bisettimanale baldracche gialle, nere e pallide, emananti effluvi per abbondanti spruzzi di Chanel taroccato. L’insana promiscuità di sudore e profumo impregnava anche i divani rompi-chiappe a molle scoperte e luride passatoie scardinate dai tacchi ferrati di militari in libera, godereccia uscita, appena smaltite le iper-dosi di bromuro dispensate per dovere d’ufficio dal caporale di turno, misogino per invidia. (…)
Il Racconto di Domenica 5 marzo 2017
MOHANI
di Luciano Scateni
Nel segno del fantastico, dettato dall’immaginario, l’incubo di una notte in gran parte insonne, abitata da intervalli a occhi aperti, scanditi dal disarmonico tum-tum del cuore in fibrillazione, ancora dentro la trama di un evento portatore di angoscia e non solo per un finale apocalittico.
La quiete dell’oceano ha un che di assolutamente eccezionale per il contemporaneo calare di ogni vento e l’insolita stasi delle correnti. Intimorisce quest’anormalità della natura ma ancor più quando il mare comincia a gonfiarsi di molto lontano, saranno duecento miglia al largo, in seguito a un moto profondo attivato da un sobbalzo di Giove che ha subito solo gli ultimi esiti dello scontro fra galassie, agli antipodi dell’universo.
L’acqua d’improvviso s’impenna per onde dapprima morbide in cima, tondeggianti e alte dieci, dodici metri, che s’abbattono sul mare dinanzi ancora calmo, sollevandolo in picchi che infine si rompono e originano creste spumeggianti per rifluire in gorghi e vortici ribollenti. Bianchi cetacei gareggiano in velocità con il sommovimento per sfuggirvi, son travolte le specie di caratura fisica inferiore e le chiome fluenti delle alghe, le più esposte ramificazioni del corallo. L’aragosta-guida è alla testa di una colonna senza fine di disciplinate seguaci e tenta inutilmente di mutare direzione, avanzando sul fondo verso oriente. Si oscura il cielo invaso a folate da nubi fosche che si rincorrono l’un l’altra sicché il sole, laddove non le incontra, precipita dal cielo sul mare e l’inonda d’irregolari bagliori. Volano basso i coprilek rapaci e sfiorano il culmine delle onde, librando veloci le ali, in tipica posizione d’agguato dei predatori che fiutano il tempo della caccia.
Le anarchie del mare in subbuglio precedono la retta scomposta dell’orizzonte e minacciano da presso gli ultimi lembi di tranquillità nel tratto al riparo tra due punte rocciose che chiudono la baia delle Orche, su cui incombe l’altopiano di Miar dai contorni levigati e le alte sponde a picco sulla distesa di sassi che digrada fin dentro l’acqua, dove si tinge di verde per muschi secolari, colorandone la trasparenza. Un masso conclude sfrontato il vertice di un lato dell’altopiano ed è osservatorio privilegiato di un’area che abbraccia parte dell’oceano, un movimentato arcipelago a ovest e alle sue spalle le valli che anticipano la base della Grande Montagna, le foreste impenetrabili su cui si eleva la vetta più alta e innevata della catena di Kon-ju.
Il piede poggiato a una breve rientranza della pietra costringe una gamba a piegarsi, non impegnata in posizione di sostegno, l’altra è ben salda e con ogni muscolo in tensione: la struttura di Ohigawi si evidenzia senza dover nulla indovinare perché il corpo è completamente nudo, ad eccezione di un minuscolo perizoma, in questa stagione che abbrevia l’escursione tra temperature del giorno e della notte, senza mai scendere al di sotto di ventuno gradi. L’uomo osserva sgomento il fenomeno ignoto e gli sembra che la furia del mare possa montare fin lassù e sommergere l’altopiano. Fugge via veloce e nonostante la mole sembra sfiorare il terreno mentre supera di slancio ogni asperità e trova con sicurezza l’appoggio laddove non c’è nulla che possa ferire i piedi scalzi. Dietro una macchia fitta di piante intricate e rovi pungenti, si apre nella parete rocciosa un’ampia caverna e i suoi profili sono irregolari, qua e là interrotti da ciuffi d’un erba a foglie larghe che terminano con un lungo filamento rigido. L’antro è profondo e appena rischiarato da una stretta feritoia in alto, dove la parete si assottiglia fino a fendersi a favore della luce. Alla base della cavità naturale la roccia s’interrompe di tanto in tanto e lascia posto a una terra, sabbiosa, soffice, di un bel color ambra che fuori, per effetto del sole, assume toni molto più chiari. Ohigwai entra trafelato e si dirige a destra, dove la spelonca si ritrae in una cavità meno ampia che protegge bene dal freddo e a notte consente di tener lontani gli animali mediante una barriera di legna accesa. I residui della combustione mandano ancora qualche bagliore e di là dalla brace i giacigli di fogliame, tenuto assieme da lacci di ginestra, mostrano ancora l’infossamento dei corpi che vi hanno giaciuto.
Mohani e il piccolo Tonkay sono fuori e Ohigawi ne è sgradevolmente sorpreso. Quel mare in tumulto è nei suoi occhi. Forse si è ancora più infuriato, forse le onde si sono innalzate fino a minacciare l’altopiano e la valle alle pendici della Montagna.
L’uomo tende l’orecchio e per un attimo gli sembra di sentire il rombo dell’acqua che ricade dopo aver alimentato onde gigantesche, mentre si avvicina al breve lembo di riva e rimonta lo sbalzo dell’altopiano. Quand’è fuori della caverna l’ansia svanisce in parte. I suoni sono quelli di sempre: versi di animali e ora un diffuso stormire di foglie che annuncia la fine della bonaccia e restituisce vita alle piante, soprattutto alle cime di quelle che svettano oltre la barriera compatta del sottobosco.
Mohani deve essere a prendere acqua dal ruscello che corre un paio di chilometri oltre il margine della boscaglia, sgorgando tra due pareti ripide di roccia per riperdersi di nuovo tra i massi, fino a sfociare in mare dopo essersi aperto una varco tra le grosse pietre ai piedi dell’altopiano.
La serenità d’animo di Ohigawi è di breve durata. C’è nell’aria un improvviso incrociarsi di voci di animali, isterico, già ascoltato in altri momenti che hanno anticipato eventi catastrofici. Urla di dinosauri, garriti striduli e versacci d’uccelli di ogni tipo, qualche ruggito lontano, dicono che il mondo vivente è in allarme. Il presagio contagia l’uomo e l’induce a affrettare il passo, a cercare con lo sguardo Mohani e Tonkay.
Un lungo ramo flessibile con la punta sottile sfiora di pochi centimetri una spalla del cavemicolo e, s’infila sibilando nel terreno. Un attimo di smarrimento e i suoi occhi si assottigliano per difendersi dalla luce abbagliante, per individuare il pericolo. Di dietro un masso isolato vien fuori un uomo di proporzioni inconsuete. La capigliatura è folta e fluisce sulle spalle poderose, le braccia si discostano dal corpo per l’impaccio dei bicipiti che incontrano i pettorali nei punti di maggior rilievo. I fianchi stretti mettono in evidenza le gambe muscolose, le mani enormi stringono l’impugnatura di una clava nodosa tenuta in posizione aggressiva con un angolo che porta la cima dell’arma a superare trasversalmente la spalla sinistra. Ohigawi non sa darsi una spiegazione dell’atteggiamento minaccioso dell’omaccione che avrà visto una decina di volte in tutta la sua vita, senza dargli mai pretesti di inimicizia. Infine un sospetto gli suggerisce sconcertanti motivi di paura. Forse è Mohani che l’uomo vuol portargli via e il figlio maschio, bellissimo.
Il problema è sfuggirgli e continuare le ricerche e non c’è altro sistema che scommettere sulla corsa, contando sulla minore velocità dell’antagonista, sfavorito dalla mole fuori di norma.
 Ohigawi guizza a zig-zag per i primi cinquanta metri e nulla vale a Kriop ergersi a braccia e gambe larghe nel tentativo di bloccarlo. Cosi il gigante torna sui suoi passi e dietro il cespuglio dove l’aveva costretta, legandola strettamente, distesa, ritrova Mohani atterrita e accanto a lei il figlioletto piangente. La trascina brutalmente, il piccolo Tonkay tra le braccia, fmo alla caverna dove prima o poi Ohigawi tornerà. Kriop ha imparato presto a far valere la forza. Fin da piccolo si è reso conto di poter dominare i coetanei incutendo timore grazie alla statura e alla muscolatura superiori alla media. Ha scoperto che è molto comodo confiscare agli altri ciò che gli occorre, piuttosto che procurarselo da solo. Non ha mai perso tempo per strappare un rapporto sessuale alle donne. Ha preso quelle degli altri con la violenza, ha razziato il cibo procacciato con fatica dai cavernicoli, ha usurpato antri e spelonche, introducendo in una società primordiale, fondata sul rispetto istintivo, il principio del potere che scaturisce dalla violenza e dalla sopraffazione.
Ohigawi guizza a zig-zag per i primi cinquanta metri e nulla vale a Kriop ergersi a braccia e gambe larghe nel tentativo di bloccarlo. Cosi il gigante torna sui suoi passi e dietro il cespuglio dove l’aveva costretta, legandola strettamente, distesa, ritrova Mohani atterrita e accanto a lei il figlioletto piangente. La trascina brutalmente, il piccolo Tonkay tra le braccia, fmo alla caverna dove prima o poi Ohigawi tornerà. Kriop ha imparato presto a far valere la forza. Fin da piccolo si è reso conto di poter dominare i coetanei incutendo timore grazie alla statura e alla muscolatura superiori alla media. Ha scoperto che è molto comodo confiscare agli altri ciò che gli occorre, piuttosto che procurarselo da solo. Non ha mai perso tempo per strappare un rapporto sessuale alle donne. Ha preso quelle degli altri con la violenza, ha razziato il cibo procacciato con fatica dai cavernicoli, ha usurpato antri e spelonche, introducendo in una società primordiale, fondata sul rispetto istintivo, il principio del potere che scaturisce dalla violenza e dalla sopraffazione.
Ohigawi raggiunge il ruscello senza più fiato, con qualche ferita ai piedi e alle gambe che si è procurato nella concitazione della corsa. I richiami non danno alcun esito. Mohani non è venuta al ruscello.
Intanto ha acquistato forza il vento che agita le cime degli alberi, solleva nubi di terra, increspa l’acqua del fiumiciattolo e innervosisce sempre più gli animali. Il cielo incupisce per cumuli che avanzano veloci e qua e là s’infiammano di lampi. I tuoni si susseguono con schiocchi secchi, ravvicinati e lunghi strascichi rombanti. I felini schizzano via dalla boscaglia e si disperdono in cento direzioni, guidati dal senso istintivo della sopravvivenza.
Ohigawi non ha più scelta, non può che tornare alla caverna. Il vago disagio per l’improvviso mutare delle condizioni atmosferiche diventa panico al pensiero di quel mare che incalza con crescente veemenza e si sovrappone alla paura per la sorte di Mohani e Tonkay dopo l’incontro con il minaccioso Kriop.
Sul limitare della caverna Ohigawi si ferma e resta in ascolto per cogliere ogni segno di presenza. Il pianto di Tonkay, inconfondibile, conferma l’ipotesi peggiore e cioè che il figlio e la sua compagna siano nelle mani di Kriop. Il cavernicolo entra con cautela ma sa anche di non poter indugiare oltre: il mare ha scavalcato la barriera dell’altopiano e l’acqua comincia a lambire il sottobosco, a poche decine di metri dall’antro. Ora le minacce sono due e Ohigawi non sa davvero quale sia la peggiore, da quale riuscirà a sottrarre se stesso e i suoi. Su un anfratto della parete rocciosa in cui si apre la caverna un temibile triu-là è raggomitolato in posizione di attacco.
L’uomo decide di rischiare. Chiama a gran voce Mohani per attirare l’attenzione di Kriop. Questi si precipita fuori della spelonca brandendo la clava e mentre si avventa su Ohigawi il triu-là spicca un gran balzo e gli piomba addoso, ficcandogli gli artigli nella schiena. L’uomo si dimena e riesce a scrollarsi di dosso il felino ma a costo di terribili ferite che gli squarciano la carne. Si gira per affrontare la belva, rotea la clava per colpirla e non ha neppure il tempo di concludere il gesto. Il triu-là punta alla gola di Kriop e la squarcia orribilmente. L’uomo si abbatte rantolando. Ohigawi profitta della lotta tra il felino e il rivale e raggiunge Mohani e Tonkay, stretti l’una all’altro, indifesi.
L’acqua comincia a invadere la grotta.
Sul fondo della cavità che protegge le notti dei tre cavernicoli una serie di gradini scavati nella roccia portano su, fino alla feritoia di dove filtra la luce esterna, grande quanto basta per far passare un uomo. Il livello dell’acqua nella caverna ha raggiunto ormai i polpacci di Ohigawi che aiuta Mohani ha issarsi sui primi scalini e la segue con il piccolo tra le braccia.
Di là dalla parete rocciosa una luce livida domina la catastrofe incombente. Il mare impazzito dilaga con violenza incontenibile e scavalca con onde impetuose ogni ostacolo, cresce ogni bordata di livello. La temperatura si è repentinamente abbassata, molti animali lottano con vortici e onde sempre più alte, gli uccelli volano lontano a stormi e qualche felino più agile si arrampica sulle pareti rocciose della montagna.
Ohigawi tiene stretta a sè Mohani e protegge con un braccio Tonkay che piange disperato. Di dove si trovano non c’è via di scampo.
L’acqua sale inesorabile e già precipita dalle feritoia della caverna, si aggiunge a quella che monta all’interno.
Ohigawi stringe la gola di Tonkay fino a soffocarlo e lo depone sull’acqua che gli è arrivata al petto. Circonda la gola di Mohani con le dita possenti e spegne la sua vita.
Guarda in alto, al cielo ferito dai lampi, alla distesa di acqua che ha cancellato i connotati dell’altopiano, alla cima della Grande Montagna e lascia che un’onda gli invada i polmoni fino a fargli perdere conoscenza.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 26 Febbraio 2017
FRAMMENTI DI «LANCIA»
di Luciano Scateni
Le grandi potenze economiche del mondo se ne sbattono della parola crisi. Non li tocca. L’affare dei farmaci procura profitti miliardari, in continua crescita, alle multinazionali che dominano i mercati del mondo e speculano sulla salute dell’umanità, complice molta parte della medicina occidentale. Non sono rari gli episodi, spesso impuniti, di precipitosi ritiri dal mercato di specialità che non superano la sperimentazione sull’uomo o peggio procurano danni e purtroppo vittime. Il coraggio di opporsi a profitti illeciti è di pochi e ha costi che sono solo di pochi, eroici contestatori.
La chiave gira nella serratura del cruscotto e chiude il circuito. I tubi della dinamite spigionano il loro potenziale distruttivo e l’esplosione scaraventa ciò che resta dell’auto a distanza di cinquanta metri. Un frammento di lamiera sfregia orrendamente un ragazzo giovanissimo, alla guida di una «Vespa» che sbanda e si va a schiantare contro la vetrina di una boutique. I feriti, nell’area più vicina allo scoppio, si lamentano, qualcuno è in stato di choc, altri urlano come ossessi in preda a isterismo. Dalle finestre degli edifici circostanti è tutto un affacciarsi con la paura stampata sul volto. Un autobus ha frenato bruscamente e il contraccolpo ha fatto perdere l’equilibrio a una decina di passeggeri che viaggiano in piedi. Poco distante una donna anziana continua a salutare la figlia e i nipotini di lontano, S’avvia alla sua abitazione modesta, di vedova che sopravvive con la pensione sociale. Una scheggia di vetro le squarcia la gola. Cade prima in ginocchio, poi s’abbatte sul selciato. Il proprietario di un bar si precipita in strada e davanti alla scena terrificante è sul punto di svenire.
Quando si riprende corre come una furia al telefono, compone il «113 », sente il sudore gelido scorrere lungo la schiena.
Per fortuna l’ora è tarda e non sono molti i passanti in questo tratto di strada che il buio e l’abituale presenza di scippatori rende invivibile.
La «pantera» schizza via dal garage della Questura, la sirena lacera l’aria della sera, sgomma ad ogni curva, zigzaga tra le automobili in sosta selvaggia, fin quando un tratto rettilineo consente di schiacciare a fondo l’acceleratore. Parte veloce l’automezzo dei vigili del fuoco e dall’ospedale militare si muove un’ambulanza. È l’unica, per il momento, ad aver raccolto l’allarme della polizia. Chi abita in centro intuisce che l’insolito susseguirsi di sirene non si giustifica con un banale incidente. Qualcuno ricorda che è il ventitré di novembre, non senza rinnovate paure. Quel 23 novembre dell’80, del terremoto.
Un nome, Raffaele, e un volto da medico di campagna, mansueto. A ben guardare, sul sorriso lieve i due occhi sono assolutamente severi, attentissimi a ogni impercettibile mutamento d’espressione dell’interlocutore di turno,, per valutare in fretta consensi e disaccordo.
Il dottore (non si riesce a non chiamarlo professore) veste in modo sobrio e discreto, mai vistoso, con qualche veniale indulgenza alla ricercatezza per cravatte d’autore o e gilet sempre a tono con l’insieme. Gli occhiali si direbbero elemento intrinseco del bel viso segnato da rughe d’intensità senile e che solo nel disegno marcato della mascella rivela determinazione nel perseguire i propri obiettivi e consapevolezza sugli strumenti per centrarli, per i tempi richiesti,
Il suo cognome non è nell’elenco del telefono e neppure nella piccola bacheca d’alluminio del citofono ai piedi d’un edificio che s’adatta alla perfezione al desiderio di riservatezza, di rifugiarsi nell’ombra dell’anonimato.
Il dottore si cruccia molto per non marginali disfunzioni del centro antiveleni di cui ha responsabilità da qualche anno. È più un pronto soccorso, dice abitualmente, che stazione scientifica di prevenzione e di promozione della coscienza sanitaria: «Quante lavande gastriche e terapie disintossicanti, quante poche iniziative per l’uso corretto dei farmaci ». Tossicologo di chiara quanto scomoda fama, il dottore ha visto scandire la sua storia professionale da un equo alternarsi di lusinghe e minacce.
Si svolge banalmente la sua casa d’affitto scelta con pochissimo piacere (saranno quindici, sedici anni fa?), principalmente per l’incomparabile vantaggio di essere prossima all’ospedale dove ha sede il centro; tanto prossima da consentire che la vecchia solida automobile sia per lo più confinata in garage.
Dinanzi all’ingresso, una porta in legno comune con finte venature, lo zerbino parecchio consunto con la scritta in rosso «SALVE» ormai confusa con il fondo, una volta ocra, delle setole.
Nell’atrio davvero minuscolo, su una piccola consolle che imita il «veneziano» poggia un vassoio di peltro. Ospita ogni giorno la posta indirizzata al professore da ambienti scientifici di tutto il mondo. Un breve disimpegno, privo d’illuminazione diretta, riceve luce da quattro appliques fissate alle pareti asimmetricamente e sotto ciascun lume, in semplici cornici, le tavole anatomiche di Vespignani. Il corridoio è interrotto da una porta a vetri con la maniglia classicheggiante, come usava negli anni del boom edilizio, ai primi accenni del cosiddetto «miracolo economico»: lo studio è ingombro di libri per ogni dove e la scaffalature, che originariamente contenevano su di una sola fila le pubblicazioni scientifiche ordinate per argomenti, sono ora soffocate da doppie quinte di volumi su cui poggiano altri libri senza alcuna logica di classificazione.
Lo scrittoio, guai a toccarlo. Nell’inverosimile confusione di appunti, riviste, comunicazioni scientifiche e dattiloscritti, il professore si destreggia miracolosamente, pescando a colpo sicuro quanto gli occorre al momento per agevolare un lavoro paziente, rigoroso, che non gli sembra mai vicino alla conclusione.
* * *
 Per la durata di cinque, sei squilli di telefono – l’apparecchio imita antichi modelli del tempo andato – la moglie del dottore prova a sopportare il rumore insistente e si augura che sin fermi. Negli ultimi tempi, non a caso quando il marito è in ospedale, ha ricevuto per questa via messaggi intimidatori, minacce dirette e ricatti. E sempre con un identico finale: «Tuo marito gioca con il fuoco, si brucerà».
Per la durata di cinque, sei squilli di telefono – l’apparecchio imita antichi modelli del tempo andato – la moglie del dottore prova a sopportare il rumore insistente e si augura che sin fermi. Negli ultimi tempi, non a caso quando il marito è in ospedale, ha ricevuto per questa via messaggi intimidatori, minacce dirette e ricatti. E sempre con un identico finale: «Tuo marito gioca con il fuoco, si brucerà».
Non è difficile datare la vecchia «Lancia » del professore. Si porta dietro gli anni con dignità e sopporta gli acciacchi, pochi, per la minima usura a cui è sottoposta, ma vecchia è vecchia, quasi da antiquariato. Come di rado capita, anche quest’oggi è parcheggiata nei viali dell’ospedale.
– Permette, professore? Ha un minuto…
Il giovanotto che sta davanti al professore è di aspetto gradevole. Il taglio dei capelli irreprensibile, l’abito di eccellente fattura, le scarpe lucidate di fresco, gli assegnano un’aria perbene che il largo sorriso completa accattivante. Si direbbe un rappresentante di medicinali o come ama definirsi la categoria un informatore scientifico. Chi l’ha preceduto, al tempo dei primi farmaci non galenici, era arruolato senza andare troppo per il sottile tra i senza arte né parte, purché dotati di faccia tosta e parola facile. Il reclutamento si è via evoluto e ha richiesto qualità di base e titoli specifici. L’industria farmaceutica, specialmente con l’espansione delle potenti multinazionali, è diventata con l’elettronica uno degli imperi a maggior livello di profitti. Forse più dell’elettronica può contare sulla domanda di salute, certa e crescente e su bisogni indotti, ingenerati dalla medicina allopatica induce al consumo con infiniti sofisticati strumenti di persuasione.
I messaggeri di questa macchina che sforna in continuità nuovi farmaci ora sono quasi tutti laureati e assediano i medici, terminali della prescrizioni, con tecnica di marketing avanzato. Specialisti di settore impongono alle aziende nomi dei prodotti, spesso onomatopeici e perfino il colore degli scatoli: per esempio il rosso per farmaci destinati agli uomini, attratti da questo colore, come accertato dalla psicologia applicata.
Il termine «comparaggio», con cui s’intende il comportamento illecito di medici convinti a prescrivere un farmaco piuttosto che un altro (in cambio di percentuali sulle vendite) è un anello operativo importante della mediazione tra industria e medici. Più in alto la strategia coinvolge il gotha della medicina. Spesso i lavori di primari e direttori di cattedra sono commissionati dall’industria perché esaltino l’efficacia di un nuovo prodotto e il “favore” è ripagato con l’omaggio di attrezzature costose di ultima generazione e regali personali.
Non c’è congresso a cui manchino sponsor, ovvero il finanziamento delle industrie farmaceutiche, e non c’è lavoro scientifico, vero o compiacente, che non sia pubblicato senza un loro cospicuo contributo. to.
— Posso, professore?… –
La missione del giovane informatore scientifico ha un obiettivo di grande interesse per l’azienda che rappresenta.
— Vede, non è la prima volta che ragioniamo insieme di certe categorie di farmaci. So bene come la pensa, ma spero che vorrà ascoltare le ragioni che mi spingono a tornare sulla questione. I nostri laboratori di ricerca lavorano da anni su una nuova molecola le cui proprietà antinfiammatorie sono scientificamente provate. Il problema, come sa bene, era di ridurne gli effetti indesiderati. Bene, ecco una serie di lavori, eseguiti in tutto il mondo, sui risultati dei nostri ricercatori…
Il dottore «sa », non fosse altro che per il rapporto con colleghi tossicologi di livello internazionale, in particolare con quanti come lui non subiscono il coercimento delle multinazionali farmaceutiche,
Il giovanotto ha però il compito di tornare alla carica, per provare a far breccia nelle convinzioni del dottore maturate in anni di lavoro per dimostrare che la categoria delle sostanze di cui parla l’informatore è altamente dannosa e dunque di dubbia correttezza terapeutica. La «nuova molecola» propagandata dal suo interlocutore non è che la riedizione di componenti molto simili. Probabilmente più efficace, provoca anche danni maggiori a organi importanti come il fegato e i reni, irreversibili e forti squilibri ematici.
– Ecco professore, se ha qualche domanda… Mi consenta, prima, di complimentarmi con lei. La nostra azienda ha potuto profittare di una circostanza particolarmente vantaggiosa. Abbiamo acquistato un stock di auto a prezzi speciali da una concessionaria costretta al fallimento. Una parte delle auto è servita a rinnovare il nostro parco aziendale e il nostro presidente in persona ha deciso di offrire le rimanenti a pochi clinici che come lei svolgono un’attività di riconosciuto rilievo internazionale. Mi creda, è solo un gesto di riconoscenza e non sottintende alcun obbligo da parte sua.
Neppure una parola, un gesto. Il dottore si alza con calma, con calma raggiunge la porta dello studio, l’apre per quanto è consentito da una panca di metallo laccata, addossata alla parte su cui s’abbatte l’anta,e resta così fin quando il giovanotto ha varcato completamente la soglia. Richiude la porta alle sue spalle e toglie gli occhiali per passare una mano sul viso, sulla fronte, dove indugia a lungo come a mandar via un pensiero sgradevole.
*
Dieci, quindici persone al giorno, ricoverate al centro antiveleni e tutte con sintomi inconfondibili. Ancora un lugubre suono di clacson e non v’è dubbio, si dirige proprio qui, al centro antiveleni.
Non tardano a chiamarlo e il professore è davanti a un uomo anziano, avrà poco più di sessant’anni. Accusa forti dolori addominali. Ancora una vittima dei funghi e si tratta di un infartuato a cui l’avvelenamento potrebbe essere fatale. Arriva il cardiologo, si decide di seguire insieme il caso.
* * *
– Pronto, sono il dottor… –
Il professore chiede ospitalità alla RAI. Un fungo molto diffuso sta facendo strage di raccoglitori inesperti. E’ la netta somiglianza con un altro fungo, commestibile, a combinar guai. Ai piedi di ulivi e oleandri viene fuori copioso dalla terra e per forma e colore si confonde i chiodini. Non è mortale ma in soggetti debilitati, a rischio, può essere pericoloso.
Il servizio pubblico radiotelevisivo è sensibile all’appello e il dottore è ospitato dal conduttore del telegiornale nell’orario di massimo ascolto. Grazie a un poster diventano evidenti le differenze tra funghi commestibili e tossici, il chiarimento si conclude con l’invito a interpellare il centro antiveleni prima di mettere in pentola i funghi.
Il giornalista dichiara apertamente di profittare di una presenza così qualificata.
– Professore, lei non si occupa solo di funghi. È ovvio, ma voglio ricordarlo prima di farle una domanda che sono certo riguarda tutti i nostri ascoltatori. Si dice spesso che di farmaci si abusa.
Il dottore conferma quanto è noto tra addetti ai lavori. Se non vi fosse abuso, o cattivo uso di medicinali, la spesa farmaceutica calerebbe almeno del sessanta percento.
– Può indicare una categoria di farmaci molto dannosi, di cui si fa largo uso?
Quale occasione. Il medico elenca una serie di sostanze responsabili di malattie iatrogene, da farmaci e punta il dito accusatore su antinfiammatori di larghissimo impiego, venduti in farmacia senza prescrizione medica, per carenza di nonostante norme ministeriali. L’incontro spiacevole del mattino è ampiamente vendicato.
Di queste valutazioni il medico deve rispondere a un giurì accademico per aver riportato in italiano, su un autorevole periodico, le identiche conclusioni che in inglese hanno pubblicato le maggiori riviste specializzate degli Stati Uniti, dove la sostanza è stata vietata.
* * *
 La moglie del professore confonde da tempo premonizioni e paure irrazionali, non del tutto ingiustificate. Non è soltanto quella voce al telefono a spaventarla da morire, ma l’insieme di episodi di cui l’ha messa al corrente il marito a cui è legata da un rapporto intenso per quella speciale intesa che a volte nasce quando il matrimonio è un’unione senza figli.
La moglie del professore confonde da tempo premonizioni e paure irrazionali, non del tutto ingiustificate. Non è soltanto quella voce al telefono a spaventarla da morire, ma l’insieme di episodi di cui l’ha messa al corrente il marito a cui è legata da un rapporto intenso per quella speciale intesa che a volte nasce quando il matrimonio è un’unione senza figli.
A sera, davanti al televisore, ha vissuto momenti di grande preoccupazione senza farne partecipe il marito, ha imprecato in silenzio contro l’ostinazione del suo “giustiziere” che giudica un eroe a metà tra Robin Hood e don Chisciotte.
Il dottor Rambaldi, contando su influenti amicizie, ha ottenuto la registrazione dell’intervento del professore al telegiornale, il riversamento è ora su di una cassetta VHS che infila nel lettore: amministratore delegato della filiale italiana, ha dovuto sopportare non pochi fastidi dal vertice della multinazionale che produce e vende a tonnellate il farmaco messo sotto accusa dal medico antiveleni a più riprese.
Non ci sono gli estremi per una querela, o perlomeno questa è la sua opinione, salvo parere diverso dall’ufficio legale. Ma è poi questo il problema?
La questione è altra, perché da quel benedetto uomo non ci si può aspettare che zittisca come esito di un’azione giudiziaria. Allora?
* * *
Allora, se la sbrighino laggiù.
(In un paese ben noto per fama non usurpata di covo della camorra, grazie alla cosca locale opera un grossista di medicinali, sempre in bilico tra l’opulenza che gli deriva dalla protezione di padrini eccellenti e il continuo stillicidio di finanziamenti imposti a favore di questa o quella impresa malavitosa, di questo o quell’affiliato della camorra in temporanea difficoltà.
La casa dell’assessore alla sanità garantisce discrezione e ospita l’incontro voluto a centinaia di chilometri di distanza. Il linguaggio, in codice è una sentenza senza appello).
* * *
– Quanto tempo, dottò? –
Il parcheggiatore prende le chiavi dalla mani del professore e imballando il motore, non più pronto per brusche accelerazioni, sistema la «Lancia» sul marciapiedi e costringe i passanti ad aggirarla con scomodi slalom.
Nel piccolo, storico teatrino del quartiere Chiaia, il medico e la moglie seguono con attenzione il monologo di un’attrice emergente e fedele al tema dell’esser donna, in un mondo maschilista.
Il piacere di frequentare questo intimo spazio teatrale è nella mancanza di mondanità che attrae buona parte del pubblico del circuito normale. Occhi negli occhi il medico e la compagna. Le dita delle mani s’intrecciano, nel ricordo di momenti lontani, dei cinema di quartiere, dove hanno assistito a romantiche commedie di film hollywoodiani proposte da con mitici divi d’epoca.
Qui basta una poltroncina ricoperta di velluto consunto, il fascio ipnotizzante di luci dei proiettore, la musica soft di fondo per immergersi in ricordi struggenti.
Il medico stenta a tenere la concentrazione sull’evento ma poi ci riesce grazie al lungo allenamento richiesto dalla professione che non consente distrazioni nelle ore dedicate a indagini su temi esplosivi che in termini finanziari si traducono in attacchi agli interessi colossali dell’industria farmaceutica. L’attenzione per il monologo che l’attrice interpreta magistralmente si dirada a momenti, quando la memoria gli propone il replay mentale della presenza nel telegiornale di Rai3 delle affermazioni scientificamente irreprensibili, deontologiche inattaccabili, ma pericolosissime.
La voce dell’attrice si perde piano piano iri un suono indistinto, lontano, esattamente come accade quando si deve badare a due persone che parlano di questioni diverse e si sceglie di ascoltare uno solo di essi, di mettere la sordina alla voce dell’altro. Il medico di dare ascolto ai propri pensieri.
“Perché questa guerra santa e tanto accanimento nella sfida al mondo senza scrupoli dei farmaci? Ma certo, perché speculare sulla salute è un’insopportabile violenza sui malati, convinti a ingerire pillole, gocce e sciroppi, all’oscuro della loro dubbia efficacia e degli effetti collaterali. Perché tormentarsi, non è forse una guerra lecita, motivata, altruista?”
Lo è, ma il professore ha il coraggio di ammettere che di là dalle ragioni evidenti della guerra ai farmaci pericolosi, la spinta alla denuncia ha origine altrove.
A conclusione di un iter scolastico brillante e dopo la laurea con il massimo dei voti, non ha trovato lo spazio accademico e professionale che avrebbe meritato. Non solo una questione di prestigio: in parte frustrazione, per l’ingiustizia di privilegi concessi a colleghi meno meritevoli ma disposti a scelte di campo gradite al sistema che ora combatte contestando le complicità con i produttori di farmaci dannosi.
“Ma è giusto coinvolgere la donna che si ama, in questa crociata? Forse no, eppure non è tempo di abbassare la guardia ”
Le ultime parole del monologo tornano in primo piano e hanno la meglio sulle perplessità del medico battagliero.
Fuori del teatrino cade fitta la pioggia di un autunno inclemente. Un brivido e il professore si stringe addosso il soprabito, solleva il bavero, prepara la chiave per aprire lo sportello dell’automobile. Poggia una mano sullo sterzo, preme sull’interruttore delle luci. “Dove accidenti è la fessura del contatto…ah, eccoti”
* * *
Attorno a quel che resta della «Lancia» si agita una piccola folla di vigili del fuoco, agenti di polizia, carabinieri e il funzionario di turno della DIGOS che da subito esclude l’ipotesi di un attentato terroristico: i resti di un uomo e di una donna sono ricomposti per quel che è possibile in due teli impermeabili che si richiudono su corpi martoriati dall’esplosione. Della targa è leggibile solo una cifra, il nove.
* *
La giovane attrice si ferma per un istante a osservare il disastro provocato dall’esplosione. Ha freddo e non è troppo convinta di aver dato tutto quello che ha dentro, sul piccolo palco, davanti a cinquanta attenti spettatori. Dalla cabina della Sip un uomo tarchiato, con accento della Napoli incolta, pronuncia una frase convenzionale: “Dottò, il pranzo è servito”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 19 Febbraio 2017
IL SEGUGIO
di Luciano Scateni
Perfezione tecnica dei telefilm made in Usa, il contributo di sceneggiatori di altissimo livello narrativo, la credibilità dei personaggi, la professionalità di attori e attrici hanno conquistato il mercato internazionale televisivo, quello italiano compreso e…gli storici tentativi della produzione autarchica della Rai che hanno confermato la distanza abissale dai polizieschi americani. Esempi? Il tenente Sheridan, Il Commissario Maigret di Gino Cervi. Imparagonabili. La Rai di questa nuova stagione ha centrato in parte l’obiettivo della competizione con Hollywood e si deve alla penna di Camilleri, ad altre sporadiche proposte di letteratura italiana di settore, ma “Il tenente Colombo” e simili restano inimitabili, perfino se rivisitati in chiave ironica come racconta questo breve, ironico racconto.
Visto e rivisto nei film polizieschi. Il detective cammina come un indossatore in pensione. Il cappello ha la tesa anteriore rivolta all’ingiù, per ombreggiare lo sguardo impenetrabile e la tesa copre a stento i capelli folti sulla nuca, spettinati ma di uno spettinato non casuale. Due o tre ciocche poggiano vezzosamente su collo e colletto della camicia, che ha il primo bottone fuori dall’asola in accordo con il nodo della cravatta allentato. La giacca di tweed è adeguatamente gualcita eppure cade come cucita dal Nobel della sartoria. Le pieghe dei pantaloni coprono con nonchalance le scarpe di vernice che non mandano scricchiolii, non sono sciupate laddove il piede si piega ad ogni passo e non puzzano di cuoio, né di pelle, né di nuovo. Neppure di vecchio. Il quotidiano ripiegato e infilato nella tasca interna della giacca non provoca lo scontato, dispettoso gonfiore. L’impermeabile sembra non abbia altra vocazione che poggiare sul braccio, bloccato grazie alla mano ficcata con disinvolta trascuratezza nella tasca dei pantaloni, che non si apre all’altezza della cucitura laterale ma s’affaccia invece sul davanti prima di incontrare la pence. L’impermeabile é del colore d’ordinanza prescritto dal manuale del perfetto segugio, l’interno del bavero non presenta tracce di unto, un’ombra di sporco e la cintura dondola in sincrono con i passi elastici, decisi, da atleta, anzi da detective.
Quel che resta di una Chesterfield vola dallo stretto finestrino del corridoio con precisione. Nella traiettoria non perde un filo di cenere. La brace, alla punta della sigaretta, descrive una cometa di luce rossa dalla parabola perfetta.
L’investigatore non lascia mai chiusa la porta dell’ufficio e per entrare non utilizza mai la maniglia che tra l’altro rifiuta da tempo di svolgere il suo ruolo. Spinge un battente con la spalla, quanto basta a scivolare dentro con decisione, l’impermeabile atterra sul grande divano di pelle nera, il cappello lo segue con precisone collaudata da tenace allenamento. Lo scaffale dell’archivio occupa tutta la parete di fronte al divano e gli scomparti vengono fuori senza con cigolio, un intoppo, come se invece di camminare sui guide di metallo poggiassero su cuscinetti d’aria. Nel terzo cassetto, chissà perché è sempre il terzo, c’è la bottiglia di bourbon piena per tre quarti, il bicchiere a cilindro, tozzo ma capiente e quanto resta di una bustina di noccioline tostate.
Giusto il tempo di sprofondare nella poltroncina con le ruote scorrevoli, appena il tempo di poggiare i piedi sull’angolo della scrivania dove un classico lume diffonde luce calda, a cono, su carte sparse, portamatite, una foto di donna in amore; giusto il tempo di mandare giù una sorsata di wiskey e accendere un’altra Chesterfield che spande nella stanza una nuvola densa di fumo: il maestoso telefono nero, di quello antichi, in bachelite, manda uno squillo pazzesco, ad alti decibel ma rochi. Il detective aspetta tanto di quel tempo prima di sollevare il ricevitore che un altro investigatore al suo posto avrebbe afferrato di getto nell’eterna speranza di ricevere di un incarico.
* * *
Nessun incarico. Pit si concede una pausa da shopping ed entra nel magazzino Vanity, di abbigliamento. La commessa inquadra subito il soggetto. Tipo incerto, timido, affetto da balbuzie emozionale, incapace di descrivere con sicurezza quel che vuole, privo di gusto, di taglia difficile. Arrossirà nel provare un capo, avrà l’aria smarrita al momento di scegliere, indeciso tra un spesa cospicua ma lungimirante e un esborso modesto ma che garantisce di ben figurare.
- Vorrei un’impermeabile.
- Si signore.
– Un impermeabile…
- Si signore? – …beige.
- Ne ha visto uno in vetrina…
- Ecco, sì. Ne ho visto uno.
È proprio un soprabito da detective, a doppiopetto. Pattine sulle spalle e sul davanti il rinforzo con i piccoli anelli di metallo.
È largo, sicché la cintura, una volta stretta invita, da luogo a uno sbuffo dalle anche in giù, e un altro all’altezza del torace.
- Come le pare?
- .., credo che andrà bene.
- Meglio se l’indossa.
 Il risultato è un disastro. La commessa contempla con estasi da falso clamoroso il gonzo di turno e riesce a emettere un gridolino gutturale di soddisfazione che suona falso come una campana lesionata. Sul corpo tozzo di Pit, l’impermeabile sembra l’incerata per coprire una grassa botte. La cintura, tesa per quanto è lunga, si aggancia a stento e non segna un bel niente in vita. Così infagottato il brav’uomo non ha l’ardire di specchiarsi, ma neppure l’intraprendenza per rendere l’indumento alla commessa. Esce dal negozio con il fagotto sotto braccio e se non fosse per i duecento dollari sborsati, getterebbe l’impermeabile nel bidone dell’immondizia al primo angolo di strada.
Il risultato è un disastro. La commessa contempla con estasi da falso clamoroso il gonzo di turno e riesce a emettere un gridolino gutturale di soddisfazione che suona falso come una campana lesionata. Sul corpo tozzo di Pit, l’impermeabile sembra l’incerata per coprire una grassa botte. La cintura, tesa per quanto è lunga, si aggancia a stento e non segna un bel niente in vita. Così infagottato il brav’uomo non ha l’ardire di specchiarsi, ma neppure l’intraprendenza per rendere l’indumento alla commessa. Esce dal negozio con il fagotto sotto braccio e se non fosse per i duecento dollari sborsati, getterebbe l’impermeabile nel bidone dell’immondizia al primo angolo di strada.
Si regala un moto di compatimento e sente per un momento di odiare il mondo, a cominciare da mister da se stesso, il balordo mister Pit.
Forse una pipa. Ecco, una pipa potrebbe migliorare il look da investigatore. Ma una pipa come? Dritta o ricurva, lunga, corta, nera o marrone. Perché no…con il fornello di radica bianca.
Nella boutique del fumatore tira aria di perfezionismo. Il proprietario pretende di consigliarlo personalmente e l’investe con una raffica di domande che lo lasciano senza fiato. In questo momento potrebbero vendergli anche la pipa da museo di Abramo Lincoln, per un milione di dollari, o rifilargli un pipetta per l’oppio.
- È la sua prima pipa? Fuma per caso sigarette, sigari, non fuma affatto? Che lavoro fa, quanto tempo immagina di concedere a questo sacro piacere, che dico, a questo impareggiabile rito?
– Veramente vorrei una pipa. Non troppo costosa, per piacere. E l’occorrente per pulirla. Oh, anche del tabacco. Né dolce, né amaro. Una via di mezzo.
- Signore, non è entrato in un supermercato. Abbia pazienza, che pretende… Pensa forse che vendiamo patate?
- Non ci penso neppure. Per piacere una pipa…
- Signorina, dia una Wilter al signore, una scatola di Dunhill, un set per la pulizia e (sottovoce), me lo tolga dai piedi più in fretta che può.
141
“Come accidenti si tiene una pipa? Tra i denti si rovina e poi chi ha più la dentature adeguata… Ok, proviamo a riempirla. Fin dove? Mannaggia, non tira. Tabacco troppo pressato, riproviamo a caricarla e via, un altro svedese, svedese antivento. Evviva si accende.
- Oddio, dio mio soffoco, muoio, esplodo, dio aiutami.
Il fumo aspirato a pieni polmoni per alimentare il fornello, li satura completamente e li fa scoppiare.
“Maledetta tosse, maledetta pipa e dannazione ai detective”.
Si può rinunciare a due simboli importanti come l’impermeabile e la pipa? Pìt decide che si può. Ha preso in affitto due locali in centro, in un edificio degli anni cinquanta né troppo vecchio, né modernissimo. Preme due o tre volte il pulsante dell’ascensore con decisione da duro. Niente. Ora, bisogna ammettere che un investigatore ha quasi sempre i secondi contati e un pressante evolversi degli eventi da governare. Non sarà un saliscendi disobbediente a fargli perder tempo. Pit picchia di nuovo sul bottone di chiamata e con il palmo della mano aperta. Un gran colpo deciso. I denti affondano nel labbro inferiore. Il pulsante ha beccato l’incavo tra due muscoli e gli ha quasi maciullato un nervo. La fitta è atroce, il dolore viaggia fulmineo verso il cervello.
- .. portiere…
- Arrivo, e che è, se ne cade il palazzo?
— Ma che accidenti ha questo ascensore, è mezz’ora che aspetto.
- E sarà guasto, voi che volete da me…
- Avanti, fate qualcosa, sbrigatevi. Mica, ho tempo da perdere…
- Vediamo che cosa si può fare.
L’ometto pigia il pulsante, resta interdetto e guarda sbigottito Pit, proprio negli occhi.
- Ma allora ce l’avete con me. E ditelo, mi volete sfottere? Ma non vedete che l’ascensore sta proprio qua, al piano? Siete cieco, per caso?
Pit farfuglia qualcosa di irripetibile sui tempi d’oggi e le cabine di una volta, con i bei vetri spaziosi che lasciavano scrutare l’interno degli ascensori. Apre la porta, che gli sbatte sulla schiena grazie al possente richiamo di una poderosa molla, ma prima trova il modo di inciampare nello sca-
lino che l’arresto impreciso della cabina ha formato con il pavimento. Si dirige molleggiando alla porta a destra del pianerottolo, infila la chiave nella serratura, o meglio tenta di infilarla. Non va. Forse è un’altra chiave, eppure… Nel mazzo ce ne sono almeno quindici e Pit non riesce mai a ricordare che cosa aprano. Prova una a una le chiavi. Niente da fare.
- Ma le avrò provate tutte?
Riparte da zero e tiene stretta fra pollice e indice quella con cui ricomincia i tentativi. Alla quinta chiave dimentica di averla fra le dita e la molla.
– Porco mondo, qual’è?
Alza gli occhi al cielo, come a maledire la malasorte e lo sguardo finisce per un attimo sulla targa della porta: «Avvocato Jefferson». E chi diavolo è questo Jefferson che s’è permesso di sostituire il nome? Pit prende tempo. Che farebbe un suo collega in circostanze analoghe? Batte il mazzo di chiavi sul palmo della mano e resta assorto per un bel po’. All’improvviso si spalanca la porta e una donnetta ne vien fuori urlante come un ossesso, brandendo il bastone per lavare in terra.
- Aiuto, al ladro… mascalzone, via di qua… portieeeeeere.
Pit infila a precipizio le scale, mette un piede in fallo e si sloga una caviglia ma prosegue eroicamente saltellando su una gamba sola. Sbatte un paio di volte contro la gabbia metallica che protegge l’ascensore.
Ha una faccia a metà truce e a metà implorante. Al piano inferiore il volto gli si illumina per l’improvvisa rivelazione.
- Questo è il piano. Ecco il mio ufficio.
Prima che la vecchietta riesca a farsi sentire dall’intero palazzo, Pit spalanca la porta, se la richiude alle spalle e riprende fiato. Davanti ai suoi occhi finalmente il vetro dell’infisso e a caratteri cubitali la scritta «PIT FORSTER – DETECTIVE ».
Il telefono squilla, potrebbe essere il primo incarico. Sono diciotto settimane che il «Daily Mirror», nell’edizione domenicale, pubblica l’inserzione riquadrata, in grassetto, che magnifica efficienza e discrezione dell’Agenzia Investigativa Forster – Indagini di ogni genere.
Un altro trillo.
Il piede sano urta contro il tavolino basso e l’effetto è micidiale.
 Vola il vaso di vetro con i fiori di campo, e l’acqua allaga il pavimento. Vola Pit, in orizzontale e la corsa si arresta quando la testa incontra il piede della scrivania. I pantaloni sono squarciati all’altezza del ginocchio, la botta fa un male boia. Il pover’uomo sta per rialzarsi, a fatica, ma è ancora carponi quando s’accorge di non essere più solo.
Vola il vaso di vetro con i fiori di campo, e l’acqua allaga il pavimento. Vola Pit, in orizzontale e la corsa si arresta quando la testa incontra il piede della scrivania. I pantaloni sono squarciati all’altezza del ginocchio, la botta fa un male boia. Il pover’uomo sta per rialzarsi, a fatica, ma è ancora carponi quando s’accorge di non essere più solo.
A giudicare dalla porzione di gambe che gli stanno di fronte deve trattarsi di un’ospite femminile, di un bel tocco di donna. Gli occhi sono in procinto di dare la scalata alla promettente apparizione, annunciata, ma non riescono che a portarsi all’altezza di un bacino che sembra fatto per partorire senza dolore. Una scarpa a punta gli si stampa sul naso come un tornado. Da una narice, solo da una, gli viene giù un fiume di sangue e il naso gli sembra che non sia più attaccato alla faccia. Un urlo bestiale sale dal diaframma, anzi dalla pancia, raggiunge la gola, ma non c’è la fa a superare quel livello, sicché la bocca è spalancata e nessun suono ne sortisce. Pit è stupito di non sentire la propria voce.
Un secondo calcio, di sinistro, lo zittisce definitivamente. I denti superiori sono centrati in pieno. Due vanno in frantumi con rumore osceno, un altro finisce in terra e Pit lo vede rotolare fin quando si ferma con la radice sanguinante rivolta in alto.
Sconsolato, inebetito, il neo detective sente le lacrime gocciolare sul pavimento, e fondersi in un impeto di solidarietà con le sorelle di sangue piovute dal naso.
Senza una parola, la donna compie un perfetto dietro-front in stile nazista ed esce dall’ufficio con passo marziale. Pit alza bandiera bianca.
- Pronto, polizia?
- Dica signore, qui è la ventriteesima stazione, diciassettesima strada.
- Oh la polizia. Niente ho sbagliato.
- Come sarebbe ho sbagliato. Qui è proprio la polizia.
- Molto gentile, passi una buona serata.
La scritta sulla porta di vetro è stata composta con lettere adesive. Pit le stacca una per una e le appallottola nella mano ma non riesce a depositarle nel posacenere. La parte gommata si appiccica alle dita e non c’è modo di liberarsene.
Il disperato Pit si toglie la giacca e la slancia in direzione dell’attaccapanni, ma finisce in un mucchio scomposto tra le gambe della scrivania. Allenta il nodo della cravatta e s’aggrappa al mobile dello schedario che ha raggiunto zoppicando. Dove la mano s’è appoggiata l’impronta netta delle dita resta circondata dallo spesso strato di polvere. Le pulizie dell’ufficio, porcaccia la miseria, gli costano dieci dollari al giorno.
Pit apre il quarto cassetto dello schedario, infila una mano e tira fuori un paio di pantofole che non cambierebbe con nessun altro, nonostante i buchi irregolari in corrispondenza dei ditoni. Anzi proprio per questo sono preferite. Infila le babucce, apre un’antina della libreria dove sono allineati i gialli mensili della McDonald. Dietro la pila di libri c’è il piccolo televisore in bianco e nero, portatile. Lo sistema per terra, sulla moquette, innesta la spina. Un sinistro sfrigolio lo allarma. Dalla presa sale una spirale di fumo.
Pit dà uno strattone al filo. Non viene.
Infine la spina riesce a liberarsi ma il contraccolpo scaraventa Pit a terra con un tonfo che si può apprezzare fino a due piani più giù. L’osso sacro esce seriamente compromesso dalla performance.
«L’uomo è più forte delle avversità», pensa Pit e si compiace per la citazione. Afferra il settimanale che ha comprato per intrattenere i presunti clienti. Apre la rivista a caso: gli occhi cadono sull’oroscopo. Sagittario: «Settimana senza imprevisti, filerà tutto liscio come l’olio. Incontri interessanti. Salute: non date peso a qualche acciacco. Giocate alla roulette, è il vostro momento».
Ma la donna che lo malmenato chi sarà mai? Il mistero della sua identità lo infila nel tunnel di una crisi depressiva dolorosa, destabilizzante. Pit prende dal cassetto la monumentale Smith & Wesson. Nel tamburo lascia un sol colpo e con gesto professionale, provato mille volte allo specchio lo fa ruotare. Un attimo prima di premere il grilletto pensa che conviene nascere da madri puttane.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 12 Febbraio 2017
WAI-PUN
di Luciano Scateni
Sull’isola di Young festeggiano Mirka, vecchissima tartaruga che gioca con i bambini nella rada di Baiadera, portandoli in groppa fin dove c’è piede.
Saranno vent’anni che è se ne sta lì, paziente e allegrona. Si direbbe che ride ogni tanto, contenta di essersi accasata in uno dei luoghi più incontaminati della terra.
E’ festa della natura per Young. Oggi non si colgono i frutti, non si va a pesca. Si digiuna per ringraziare il mare e le piante, gli uccelli e perché no, la saggia tartaruga che non s’è più allontanata dall’isola. La gente di Young dipinge il viso e i corpi con i colori della pace e dell’amore, per segni antichi di devozione alle divinità benevole e misteriosi simboli di esorcismo contro il malvagio dio delle calamità.
E son danze, calme danze d’insieme, con i capelli ornati di fiori selvatici, i succinti costumi rivestiti da lunghi fili di raffia che si ripropone, attorcigliata, in trecce sfrangiate, attorno alle caviglie. Il mare, le sue vertiginose trasparenze e le infinite specie di pesci coloratissimi nello scenario di alghe filiformi o larghe, di scogli bianchi su cui spiccano tenere vegetazioni, dal rosso cupo al verde smeraldo. Nel mare fila leggera la flotta di snelle canoe, in semicerchio, sospinta da braccia esperte, avvezze a domare onde travolgenti che montano dopo aver saltato la barriera corallina, quando il vento soffia impetuoso. Appena dietro il promontorio scoglioso, la formazione delle barche si stringe in cerchio. Donne e bambini lanciano in mare mille corone variopinte di fiori legati con flessibili rami d’un’erba che ricopre copiosa l’isola di Young.
Di qui s’intravede Wai-Pun, il vulcano che domina l’isola imbronciato, brontolone, sbuffante, ammonitore, periodicamente cattivo, devastante. A sera, quando il sole scompare dietro l’arcipelago delle Ostraisand, il monte è visibile per un’aureola rossa attorno al cono eruttivo.
La radura dinanzi al villaggio di capanne è abbagliata dalle lingue di fuoco dei roghi che bruciano spezzoni di tronchi ben secchi disposti a piramide, a base larga e via via stretti in cima. La gente di Young mastica con gusto le corpose foglie stagionate di aprikwa, una pianta dalle virtù medicinali, fortemente depurative. I giovani cantano antiche arie, più cantilene che canzoni, con poche parole ripetute all’infinito: “bellezza, sorrisi della vita, amore, gioventù”.
”Ad ovest di Young… un piccolo atollo nell’oceano pacifico… ore 22 e 37 minuti… un missile a testata nucleare è precipitato nelle acque antistanti l’isoletta…” Le prime notizie arrivano al dal Pentagono dalla Nasa. “Si è trattato di un tragico errore… forse un guasto al computer che regola direzione, velocità e altezza del missile…” “L’esplosione ha cancellato l’atollo… una grande nube radioattiva minaccia gli arcipelaghi limitrofi…”. Il messaggio corre veloce via internet.
*
Gli anziani hanno pensato al vecchio vulcano. Un’idea cancellata in un attimo. L’effetto dell’esplosione è di circa un centesimo della devastazione provocata dalla bomba di Hiroshima.
Young è volata in miliardi di frammenti, insieme a tonnellate d’acqua vaporizzate in gocce minutissime. Sul mare, a molte miglia di distanza, galleggiano i residui di un totem.
Sul legno, i fori di una raffica di schegge e solo una metà della faccia scolpita del dio Kowinachi, nume tutelare di Young.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 5 Febbraio 2017
COLOMBO
di Luciano Scateni
Questa storia minimale ha un che di kafkiano. Il micidiale effetto domino, a cui dà il via uno diabolico pennuto, avrebbe acceso la fervida inventiva di Orson Welles, lo avrebbe indotto a diffondere il “fatto” via etere, come fece con l’annuncio spiazzante di bellicosi e ostili marziani sbarcati sulla Terra. Ovvero, il possibile dell’impossibile.
Un gran mal di pancia anticipa la colica, annunciata con qualche gemito appena soffocato e da contrazioni dolorose dell’intestino. Un velo di sudore freddo, incoercibili flatulenze.
Il ponte sulla ferrovia è protetto da una larga balaustra di granito e il bordo estremo, prima del salto di trentacinque metri, quanti ne corrono tra la massima apertura dell’arcata centrale e i binari, è macchiata a chiazze bianche, marrone, giallognole, calcificate.
Il piccione si porta più all’esterno che può con passetti di assestamento, lo sguardo è rivolto verso la strada ferrata che il ponte sovrasta. Il capo ruota da destra a sinistra due, tre volte, a sottolineare lo sforzo e il becco è spalancato, la coda si solleva fino a descrivere un angolo di trenta gradi con il corpo grigio macchiato di bianco.
L’escremento liquido si allunga in un filamento vischioso e colpisce esattamente il punto dove i cavi dell’alta tensione che alimentano le elettromotrici sono privi di guarnizione, consumata da pioggia, vento e dalla tensione eccessiva tra due pali.
La scintilla sprigiona schegge di fuoco, un filo di polvere pirica, sottile, si posa sui binari, fuoriuscito da una sacchetta di plastica che la frenata del treno merci, brusca, ha mandato a battere con violenza sull’estremità della barra di ferro che rinforza la porta del vagone. S’incendia la polvere e la vampata raggiunge la fessura del portellone scorrevole dove si è depositato uno strato del materiale infiammabile. Il fuoco si propaga rapido, raggiunge la sacchetta che salta in aria come una bomba. Scoppiano a catena gli altri contenitori. Il tetto del vagone vola via.
L’ultima esplosione, la più violenta, fa volare in mille schegge impazzite quanto resta della motrice Il macchinista e il suo aiuto sono sbalzati per quel che ne resta a decine di metri di distanza. Il treno corre veloce per inerzia. Al termine di un lungo rettilineo, il treno raggiunge il massimo della velocità. In senso inverso, in prossimità di un larga curva, finirà per incrociarsi con il rapido Milano-Reggio Calabria. Sbanda vistosamente il merci, stride il metallo delle ruote a stento trattenute dai binari. Il rumore sinistro mette in allarme Spampinato, capotreno del “pendolino” in fase di relax nella prima carrozza agganciata alla motrice.
Il ferroviere addenta il panino che come ogni giorno la moglie gli ha messo nella tracolla sdrucita. Un mezzo deragliamento, allarmante, lo manda a sbattere contro la porta che lo separa dalla cabina di guida. La curva dei binari è a pochi metri dal suo tratto più acuto. Spampinato si sporge dal finestrino mentre il merci sta per uscire dai binari. Sa che lo scontro è inevitabile e d’istinto aziona la leva dei freni d’emergenza. La forte decelerazione provoca un tremendo sussulto e le ruote dei primi vagoni perdono il contatto con i binari. Il convoglio vola come una freccia impazzita e dopo lo slancio iniziale impatta con il versante roccioso della collina che sovrasta la ferrovia. La motrice scavalca la siepe che conclude il pendio della collina, s’impenna e impatta con il solaio dell’edificio della stazione idroelettrica che costeggia la Ferrovia. Finisce con i respingenti sul quadro computerizzato che regola l’afflusso dell’acqua nell’invaso e lo riduce in mille pezzi.
Si bloccano contemporaneamente tutte le paratie di scarico e la massa d’acqua si riversa nel lago artificiale sottostante, ne satura la capienza. La forza impetuosa dell’acqua trascina con sé terra, alberi, massi e animali, uomini. Il fiume di detriti precipita a valle con una violenza spaventosa, s’ingrossa via via che tocca quote più basse, aggira sporgenze rocciose a valle della montagna e con balzi di onde da tsunami piomba nell’alveo del fiume che esonda dove incontra minore resistenza degli argini. Tutto è sommerso, si gonfiano i rami collaterali e i torrenti collegati. Uno, in piena, invade il terreno della centrale ENEL dove sono installati potenti generatori L’impianto va il tilt. Il back out fa piombare nel buio l’ospedale di zona, privo di fonti alternative per aver affidato il generatore all’azienda di manutenzione.
In sala operatoria il professor Donelli ha reciso l’arteria del paziente ed è sul punto di sostituire il tratto compromesso con una protesi. Il paziente è in circolazione extracorporea. Il gruppo elettrogeno è in avaria. Assistenti e infermieri tentano di far luce con le minuscole torce dei cellulari. Il cuore si ferma.
I funerali dell’ingegner Rimoldi mettono fine all’attività produttiva della Starter. Niente eredi, un’azienda afflitta da mancanza di commesse.
Il tribunale vincola la fabbrica al regime di amministrazione controllata in vista della liquidazione.
In un cassetto, chiuso con una doppia serratura, documenti esplosivi testimoniano oltre ogni ragionevole dubbio l’accordo tra l’ingegnere e alti dirigenti dei ministeri dell’industria e del commercio con l’estero per una massa ingente di commesse clientelari. In colonna sono specificate in percentuale le cifre delle tangenti incassate dai partner politici della Starter e del magistrato, il dottor Bernardi, che ha finto di non essere al corrente dei contratti viziati dalla corruzione in cambio di un lauto “ringraziamento”. Il giudice Nicolais, designato dal tribunale a gestire la fase investigativa che precede la liquidazione, si propone di consegnare l’incartamento a Bernardi, incaricato di indagare su ipotesi di irregolarità avanzate dalla Finanza.
Il giorno dopo, mentre viaggia con la sua Croma per raggiungere la fabbrica, Nicolais, all’uscita di una curva, si accorge troppo tardi della strada sbarrata da un tronco venuto giù con un violento temporale. L’auto compie tre giravolte su se stessa, finisce nella scarpata con un salto di sessanta metri e s’incendia.
L’ambizione del giudice Bernardi è soddisfatta con la nomina a componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ce l’ha fatta a raggiungere il vertice della carriera, è una giornata di primavera inoltrata, l’aria è più che tiepida. Gli inservienti spalancano le grandi finestre prima che inizi la seduta del CSM.
Sul davanzale di pietra si posa un colombo, impettito. Se ne resta li, immobile, a fissare la toga del giudice Bernardi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 29 Gennaio 2017
PRIMA E SECONDA PARTE
POLIZIOTTI SI MUORE
di Luciano Scateni
Il mestiere fa il cuore duro? E’ lavoro di frontiera il ruolo di commissario, specialmente in aree di diffusa criminalità. Il disagio assume caratteri di esasperazione se si esercita il difficile compito in convinta ostilità alla linea d’intervento repressiva, intesa come prioritaria ed esclusiva strategia per la sicurezza della città. De Maria vive il mandato in costante e sofferta contestazione della lettura di Napoli raccontata come luogo di irrimediabile sconfitta della legalità. Il suo anticonformismo, è plateale nell’idiosincrasia per “le circolari”, disposizioni che omologano nel loro linguaggio erga omnes realtà tra loro distanti, senza identificare problemi e specificità. Il lavoro sul campo è altro. Impegna il commissario sul fronte della repressione senza sconti del crimine privo di alibi e su quello della tolleranza per devianze di diseredati toccati dalla sfortuna di incolpevole marginalità.
Un omaccione poco disposto ai convenevoli, una carriera tutta percorsa sul campo, nessun favore, mai, da nessuno: Saverio De Maria è poliziotto sui generis.
Lo hanno mandato a dirigere il commissariato più rompiballe di Napoli con l’idea di bruciarlo. In questura hanno promesso al ministero di cuocerlo a dovere e di portarglielo ben rosolato su un piatto sacrificale perché finalmente lo si possa sbattere in qualche angolo sperduto d’Italia a girare i pollici, senza combinare guai.
Guai, per il ministero, sono per esempio certe propensioni del commissario a osservare la delinquenza come un fenomeno della società del malessere di cui ha rilevanti responsabilità lo Stato. Guai, sono talune asprezze nei confronti di politici e amministratori pubblici. E ancora, l’indulgenza che ispira i rapporti con il pianeta dei tossicodipendenti, degli omossessuali, dei contestatori. Nulla di irregolare, s’intende, che altrimenti sarebbe già con le spalle al muro, ma un comportamento sgradito all’istituzione che ragiona come le impongono la maggioranza silenziosa e la minoranza non meno esigente dei vendicatori per vocazione..
A far capo dall’abbigliamento, Saverio De Maria fa storcere il naso a colleghi e superiori. Mai una bella camicia bianca, la cravatta a tono con la giacca, scarpe classiche. D’inverno maglioni a collo alto, giubbotti e giacconi, spesso i jeans e d’estate camiciole, polo di insoliti colori, giacchette sfoderate, bianche o blu. Sembra che abbia litigato a vita con il barbiere. I capelli sottili, e piuttosto ondulati, ricadono abbondanti sul collo, coprono le orecchie e calano sulla fronte in ciocche disordinate. Il viso è costantemente ombrato dalla barba di due, tre giorni. Per fortuna è di colore biondo, così da attenuare l’impressione di sciatteria. Si direbbe sovrappeso ma non lo è. Forte è la sua struttura ossea e sul possente impianto scheletrico i muscoli sono da atleta.
Ha un modo tutto suo di parlare e bisogna abituarsi a questo vezzo se non si vuol perdere la pazienza. Quasi sempre bisogna ripetergli la stessa frase. Resta impassibile il commissario, quasi fosse incavolato per essere stato distolto da un suo importante pensiero. Dopo qualche istante di silenzio guarda l’interlocutore e gli fa: «Hai detto qualcosa?».
Le tasche delle giacche sono sformate. Carte, sigarette e accendino, soldi, la penna biro, convivono con la pistola che non è quella di ordinanza. La questura non è mai riuscita a imporgli le normali misure di sicurezza, i percorsi variabili, la scorta, una costante diversificazione di abitudini e orari.
Il commissario non rinuncerebbe mai alle piccole cose di ogni giorno. Il caffè non è caffè se non nel piccolo bar di piazza Trieste e Trento, accanto al tabaccaio da cui si serve da sempre, al giornalaio con cui finge di condividere la passione per il calcio, al parcheggio dei taxi, occasione permanente per tastare il polso a una categoria che ha orecchie dappertutto.
Di fronte al San Carlo, dove sarebbe vietato, Gennaro Squitiero s’è fatto un suo parcheggio privato a ridosso della Galleria Umberto I. Ha sloggiato in parte taxi e invaso perfino lo spazio riservato alla sosta degli automezzi pubblici. Le tariffe sono personalizzate, a misura di macchina. Due euro è il prezzo per un’utilitaria, ma ci vuole almeno il doppio per una Mercedes, e a clienti abituali è riservato un trattamento forfettario, una specie di abbonamento settimanale. Gennaro ha qualche problema psichico, di non chiara origine. A volte s’inceppa e non riesce a pronunciare certe parole, anche semplici, oppure ripete la stessa frase più d’una volta. «Buongiorno dottore, buongiorno dottore », per esempio, oppure «Avete visto il gol di Maradona alla “Domenica Sportiva”, alla “Domenica Sportiva”?». A suo modo il parcheggiatore è dotato di humor. Quando una donna lo guarda con aria implorante, perché gli sistemi l’auto, Gennaro recita un ritornello alla Arbore. «Gesù, Gesù, Gesù. E chi gli ha dato il permesso di uscire di casa?» Poi esegue un inchino perfetto e apre lo sportello con una parodia esasperata delle buone maniere, eseguita con una lunga palandrana azzurra da commesso di ferramenta. Scopre il capo con un ampio gesto che porta il cappello da ufficiale di marina a sfiorare terra.
-A quanti milioni stai, Gennà?
Il commissario un giorno lo ha interrogato come fosse uno dei suoi abituali clienti per fargli i conti in tasca.
– Ho sbagliato o non ho sbagliato mestiere? Gennaro mio, tu sì che sei un ricco signore, altro che un commissario di polizia come me.
L’appuntamento con Carmine, l’agente che ha il dono di non dire una parola di propria iniziativa, è al semaforo di piazza Municipio, come sempre. De Maria lo stuzzica.
– Carmine, tua moglie non t’ha cacciato ancora di casa? No? E’una santa, senti a me
L’agente di solito non replica ma per una volta ribatte con lo stesso tono canzonatorio.
– Dottò, mia moglie mi sopporta, ma vostra madre mi ha detto un un giorno o l’altro vi darà lo sfratto.
Il commissario finge di offendersi e Carmine se la ride sotto i baffoni da poliziotto.
Via Medina non si smentisce. E come sempre invasa da automobili. Gli autobus si fanno largo un centimetro per volta con gran consumo di freni e frizione, gli autisti aprono e chiudono di continuo le porte per consentire ai passeggeri frettolosi di proseguire a piedi. E lunedì e in città si sono riversati come al solito molti i commercianti pendolari della provincia. Solo i motorini riescono a farsi strada. Profittano dei trenta centimetri sgombri accanto al serpentone spartitraffico o guizzano tra un’auto e l’altra. Anche a voler azionare la sirena non si farebbe un metro di più. Tanto vale un’occhiata al «Mattino» e alla cronaca di un altra giornata di guai.
– Senti che stronzata, Carmine. Ti pare che ci possiamo bere questo racconto di certi, come dire, colleghi? Ormai siamo ai vendicatori della notte e se ci si mettono anche loro, siamo a posto…
Il trafiletto è su due colonne, taglio basso: “UCCISO UN RAGAZZO. RUBAVA BENZINA”. Il racconto è tanto poco credibile e le forze dell’ordine sono state costrette a tirar fuori una testimonianza che accrediterebbe l’autodifesa del collega che ha dichiarato di aver visto dalla finestra di casa rubare benzina da un’auto in sosta, in piena notte. E’ sceso nel cortile e il giovanissimo ladro avrebbe reagito minacciandolo. Dalla pistola d’ordinanza, sarebbe partito un colpo che ha ucciso il ragazzo.
— Capito Carmine? È partito un colpo. Come se non ci volesse un dito che preme con forza il grilletto. E sai il ragazzo dove è stato colpito? Alla schiena.
L’agente annuisce appena. L’incrocio con la via Diaz è a una trentina di metri ma sono trenta metri di ingorgo. Sulla sinistra c’è l’edificio della Questura con un paio di volanti a presidiare l’ingresso. La piccola folla di frequentatori occasionali è regolata dal maresciallo Gargiulo. Una vera istituzione. C’è chi deve sbrigare pratiche, derubati che sporgono denuncia con poca convinzione e una coppia di stranieri ancora in stato di choc per aver subìto uno scippo.
Con una sgommata da telefilm americano d’azione parte l’Alfa del capo della Mobile. Mastropaolo è di quelli che interpretano il ruolo come se fossero sempre avanti alla cinepresa e l’ autista lo asseconda. Una volta è toccato anche a De Maria di essere coinvolto nella sceneggiata. È rimasto di sasso. Mastropaolo è uscito dalla Questura fra quattro agenti in borghese che sembravano piuttosto ospiti abituali di Poggioreale e si è infilato in macchina dopo aver scrutato a destra e a sinistra. Sedendosi ha poggiato la pistola su una gamba, ha allentato il nodo della cravatta. Praticamente Humphry Bogarth. Poco è mancato che De Maria gli ridesse in faccia.
Finalmente Carmine riesce a superare l’incrocio. Ora si cammina speditamente. Il palazzo delle Poste: sarà pure in stile fascista, pensa De Maria, ma bisogna riconoscere che come altri edifici del regime è stato costruito tanto bene da sopportare indenne i settant’anni trascorsi. Più in là, sulla destra, il bugnato di palazzo Gravina dove ha sede la facoltà di Architettura. Nel ’68 non ha svolto il ruolo della consorella veneziana, capofila della contestazione, ma i suoi bravi casini li ha piantati. Ora, che i ragazzi hanno riscoperto il mito dello studio tradizionale e della meritocrazia, le scritte superstiti sui muri della facoltà sembrano memorie patetiche di un’epoca di balordi e suonano finte. Il corpo accademico ha restaurato presto le regole del gioco con gli studenti. La lotta impegna i docenti. S’azzuffano per accaparrarsi gli incarichi più remunerativi e per stabilire rapporti di forza vantaggiosi all’interno della facoltà.
Su per Sant’Anna dei Lombardi ancora traffico. In vista c’è il crocevia dello Spirito Santo e il caos di piazza Dante.
– Caro Carmine, comincio a invecchiare. Ogni cosa, un ricordo. Ero entrato da poco nella polizia e ci chiesero di dare una lezione ai «rossi». Uno di loro mi mise in crisi. “Poliziotto”, disse sfottendo, “pensa con la tua testa e non con quella di chi ti usa per impedire alla gente di svegliarsi e di mettere in crisi il sistema. Vieni in assemblea e capirai qualcosa di più”.
– Carmine, come fai a manganellare uno così?
Nessun cenno di attenzione in risposta e De Maria non ha voglia di ulteriori riflessioni sociologiche. C’è un volume che l’amico Fiorentino avrà certamente e una pazzia ogni tanto è consentita. Il commissario ha i libri come unica indulgenza per se stesso.
– Fausto, ti stai arricchendo. Non fare quella faccia, è così, con tutti gli studenti di architettura che accalappi… –
– Lascia perdere commissà. Questo non è mestiere che arricchisce e con clienti come te, sai che incassi… Beato chi ti vede. Almeno acchiappassi un po’ di delinquenti. Sai che ti dico? Meglio i carabinieri. A proposito, c’è n’è una sui carabinieri che…
– E piantala. Solo io ne posso sparlare. Piuttosto dammi le «Favole di Roberto De Simone». Porcaccia miseria, leggere è proprio un vizio da ricchi. Trenta euro? Altro che favola. Cristo, potevo fare il commercialista, che so il chirurgo. No, come un fesso, in polizia sono entrato. Almeno ci credessi.
Allo Spirito Santo un altro segno niente male del passato, i vecchi orologi stradali dell’ente autonomo Volturno. Scandivano il tempo per i napoletani dall’alto di steli post-liberty dominati dal fascio che dopo il ventennio è stato coperto con lo scudetto rosso e giallo del Comune. Uno degli orologi, in piazza Trieste e Trento, trafugato chissà quando e da chi, era una meraviglia. Perché fosse letto da via Chiaia, via Roma e dalla piazza del Plebiscito, si divideva in tre quadranti comandati da un unico meccanismo. Uno a uno, gli orologi si sono fermati e i vetri di protezione sono andati in frantumi per le sassate dei vandali. In via Santa Lucia è rimasto solo il palo di sostegno, con i fili del comando elettrico sconsolatamente pendenti. Il Volturno ha assistito impotente allo scempio ma infine ha deciso di recuperare questo arredo urbano carico di ricordi. I quadranti si ispirano ancora al disegno originale, ma è sgradevole la consapevolezza che si tratta di un rifacimento. La precisione del segnale si deve ai tedeschi. L’impulso radio parte dalla Germania e si può scommettere che gli orologi stradali di Napoli non sono stati mai così precisi. Almeno questo. Son ferme invece le lancette del monumentale orologio murale che campeggia sull’edificio della scuola Vittorio Emanuele in piazza Dante, in testa al tipico ristorante «53». La statua del sommo poeta gli volge le spalle e anch’essa è segnata dal disamore della città per le proprie cose. Il bianco del marmo è imbrattato di scritte tracciate con le bombolette spray. Prevalgono le frasi di studenti e neofascisti. A pochi passi c’è la federazione napoletana del MSI.
— Per la miseria e che ci fa tutta questa gente per strada a quest’ora? Vai a Milano, a Torino, dove ti pare, a Bologna, non vedi un’anima dopo le otto e mezzo. Tutti a lavoro. E non mi dire che qui sono tutti disoccupati. La verità è che qui, negli edifici pubblici e non solo lì, si marca il cartellino, si appende la giacca all’attaccapanni e tutti in giro. Sai cosa penso del colore su Napoli che fanno gli inviati della grande stampa e della televisione. Cazzo, qualche volta mi chiedo però se non hanno ragione. Lasciamo perdere. Dai Carmine, andiamo in ufficio.
Completato il periplo della piazza, il semaforo è rosso ma Carmine se ne frega allegramente. Aggredisce la salita Tarsia per dirigere al commissariato che dista poche decine di metri da Montesanto, la piazzetta più caotica di Napoli. C’è un tempo, attorno all’una, in cui sembra che tutta la città vi confluisca, tanto brulicano i terminali di Cumana, Funicolare e metropolitana presi d’assalto da studenti e da impiegati che nell’intervallo corrono a casa per non mancare al rito del pasto abbondante di mezzogiorno_ E gente che deve emulare Tomba, eccelso slalomista, per scansare i banchetti delle decrepite contrabbandiere, affollati di «Marlboro», «Merit», preservativi e saponette, i carretti dei fruttivendoli, i bazar di giovanotti di colore che stendono in terra i loro panni colorati su cui sono ammucchiati finti braccialetti etiopi e radioline con cuffia, cinture di cuoio. Le ambulanze dirette al Vecchio Pellegrini rinunciano al lasciapassare della sirena, a cui la gente è ormai insensibile e dal vicino provveditorato agli studi vien fuori una mare di precari in cerca di supplenze, insegnanti distaccati (ìqualcuno dice imboscati), infiniti aspiranti a qualcosa, messi in fila nelle mille graduatorie di un esercito di scontenti.
Il commissario De Maria ha sovranità su una platea urbana che s’arrangia come può, tra commerci abusivi e ogni variante della delinquenza minuta: contrabbandieri di sigarette, molti dei quali riciclati nello spaccio della droga, figure minori della camorra e scippatori.
Su Montesanto incombono le propaggini dei famigerati quartieri spagnoli. Di lassù partono i veloci raid dei teppisti con le vespette «50» che schizzano via dopo il colpo per risalire nei meandri dei vicoli, e lassù c’è la fitta rete di un mercato della droga che utilizza decine di gregari per i capozona delle «Famiglie».
– Gesù, Carmine, guarda chi è tornato in circolazione. Quello non è capatosta? Si è fatto il Volvo quel fetente.
– Dottò, Salvatore Campopiano è uno buono. Che pensavate, diaverlo fottuto per sempre? –
Capatosta, nel suo genere è un classico. È figlio di Assunta, una puttana che ha fatto il mestiere fino a sessant’anni. Alla fine della carriera la donna se ne sta per ore accanto al celebre «Pintauro», il forno di Toledo da cui escono le migliori sfogliatelle del mondo. Sulla faccia aggrinzita due dita di cerone e sulle labbra un rossetto viola, sbavato, a forma di cuore: eppure i suoi clienti riesce ancora a rimorchiarli nel basso di via Pasquale Scura. Salvatore, da piccolo, aveva imparato a sloggiare rapidamente all’apparire della madre con il gonzo di turno e profittava della circostanza per correre da don Ciro, guappo vecchio stile del quartiere che si divertiva a traviarlo insegnandoli i trucchi del mestiere e in particolare il furto con destrezza.
Salvatore Campopiano è entrato e uscito dal Filangieri come da una pensione e si è fatto conoscere per una sua convinta caratterizzazione del bullo che sa assestare quattro ceffoni a chi sgarra. Il maresciallo Gargiulo ne ha fatto a suo tempo una questione personale. Capatosta non si poteva più muovere. Rubava uno stereo e Gargiulo beccava il ricettatore, gli faceva sputare il nome di Campopiano che finiva sistematicamente in riformatorio. La guerra personale è andata avanti fin quando il maresciallo si è guadagnato il meritato riposo con il distacco in Questura. Ma quelle erano ragazzate. Capatosta ha mirato alto e si è affiliato alla Nuova Camorra Organizzata quando don Raffaele Cutolo era ancora imperatore incontrastato di ogni traffico illecito.
– Salvatore non dimentica, marescià.
La minaccia è rivolta a Gargiulo, mentre il malvivente infila il portone della Questura con due agenti dell’anticamorra.
La Mobile lo ha fatto prelevare per chiedergli di dare una mano in una faccenda sporca, un giro di prostituzione maschile in cui si dice sia implicato Veronica, misero invertito che riesce a irretire ragazzini di dodici, tredici anni per immetterli in un mercato particolare.
Capatosta, secondo un informatore dei Quartieri, è incazzato come una belva per le attività di Veronica.
– Dottò e che vulite ’a me, nun so’ nato spia.
Infine la Mobile ha saputo dove metter mano e ordina l’irruzione al terzo piano di una palazzina terremotata in via Nardones, dove Veronica è in piena attività di tenutario.
Il dirigente della Questura e Salvatore si incontrano di nuovo in circostanze meno confidenziali. Capatosta, dice una soffiata, è l’ispiratore del repulisti alle casse aziendali nei giorni di paga. Sono suoi gregari i rapinatori che finora hanno razziato quasi due milioni.
La Questura è sulle corde dopo una telefonata dal ministero dell’industria, evidentemente sensibile alle lamentele di un gruppo multinazionale vittima di una delle rapine. Il meccanismo è in moto: il ministero sbraita con la questura, questa con la Mobile. Per spezzare la catena della proteste ci vuole un risultato tangibile ma Salvatore questa volta ha la bocca cucita. L’appuntato Leone incontra Totonno ‘o contrabbandiere in una ricevitoria del Lotto e i termini della trattativa sono chiari.
-Totò, devo dire niente alla Finanza?
– Niente gli devi dire.
– Ok, niente gli voglio dire, ma tu devi aprire le orecchie. Vedi di farmi chi si mette in tasca i soldi delle busta paga
Totonno non è fesso. Intuisce che il poliziotto non ha niente tra le mani.
– Ma che vulite ’a me, non ne so niente. Chissà chi fetente è…
Alla Mobile alzano bandiera bianca dopo aver esaurito ogni possibilità di soffiate.
– Pronto? Passami il commissario De Maria. …Savé, tu mi devi portare Capatosta e i suoi scagnozzi in manette. Un’altra fabbrica che rapinano e passiamo un guaio. Io, tu e la questura.
Nell’ufficio alla salita Tarsia, il commissario ha dato appuntamento a tutti gli uomini disponibili e come al solito, senza formalità, ha detto come stanno le cose.
– Ragazzi, ci sono un paio di poltrone eccellenti che bruciano e i pompieri siamo noi. Chi conosce i compari di Capatosta? Si alza una mano. Adinolfi dice che può fare qualcosa.
– Dottore non garantisco ma un’idea c’è l’ho. –
Salvatore Campopiano ha intorno una piccola corte dei miracoli che si diversifica per specializzazioni. C’è un commando di estorsori che hanno mano libera dal Museo a piazza Carità, in un’area fitta di negozi, soprattutto di abbigliamento; e c’è il genio rapinatori, che assalta uffici postali e ora le casse delle aziende.
Di quest’ultima cosca dovrebbe far parte Ciro Catapano, un bisonte con i capelli tagliati a spazzola, un curriculum voluminoso di picchiatore e di sadico. ‘O fascista viaggia da qualche tempo in BMW. Adinolfi si arma di pazienza. Altre volte ha sperimentato un travestimento che lo rende irriconoscibile. Camuffa la calvizie con una parrucca riccioluta, si applica sulle labbra un paio di baffoni e si nasconde dietro un paio di occhiali da cieco con le stanghette larghe un centimetro e mezzo.
Comincia il deprimente lavoro degli appostamenti. In una «500» scassatissima l’appuntato aspetta paziente gli eventi. Mancano due giorni al 27 e qualcosa dovrà succedere sempre che i rapinatori delle busta paga siano davvero affiliati di Capotosta. La mattina del 26 ‘o fascista esce dal portone dell’edificio dove abita Salvatore Campopiano in compagnia di altri due balordi e s’infila nella BMW che un attimo dopo sembra una discoteca mobile. Dalle casse acustiche dell’impianto stereo viene fuori a volume rompitimpani la musica di un pezzo accattivante di Nino D’Angelo. Il traffico agevola il poliziotto, che non fatica a seguire la grossa auto quando s’immette in via Roma e giù, a sinistra, in via Diaz, piazza della Borsa, il Rettifilo, fino alla caotica Ferrovia di dove si esce a stento in direzione della zona industriale. In via Argine è più difficile stare dietro alla Bmw ma la 500, dentro la sgangherata carrozzeria, ha un motore che gira a meraviglia e la distanza tra le due auto non si fa incolmabile. In prossimità del grande e grigio perimetro della Mobil la BMW rallenta vistosamente, fino a fermarsi nella piazzola di un distributore di benzina, proprio di fronte alla palazzina della direzione di un gigante del petrolio. I tre gaglioffi si dirigono al bar della stazione di servizio e il poliziotto li imita. In attesa del caffè, ‘o fascista scruta a lungo attraverso il vetro, come a volersi imprimere nella memoria i dettagli della palazzina e della guardiola presidiata da vigilantes.
SECONDA PARTE
Martedì 27, ore 6. Gli uomini del commissario De Maria hanno accettato di buon grado la levataccia. La prospettiva di una buona operazione non dispiace a nessuno e se l’appuntato Adinolfi non è nato di venerdì 17, in anno bisestile, sarà un giorno di quelli che fanno finire in TV e sulla prima pagina del Mattino.
Un gruppetto di agenti, con la tuta della società petrolifera, è fermo a discutere di donne, quelle del mezze nude Drive-in e di calcio. Tra loro c’è un juventino che ebbe il torto di denunciare la propria fede di tifoso. Da allora sono stati lazzi, sfottò e scommesse con dozzine di sfogliate in palio e una volta la penale di doversi recare al San Paolo con la maglia azzurra del Napoli e un cartello con su scritto “La Juve non è più. Una prece”.
Tiratori scelti hanno indossato la divisa di vigilantes, altri, in giacca e cravatta, hanno sostituito i funzionari della cassa.
Il commissario è con i collaboratori diretti e il fido Carmine in un pulmino di un’inesistente ditta di manutenzione. I finestrini non consentono di vedere all’interno e al contrario, dell’abitacolo si può osservare agevolmente l’esterno. È una di quelle giornate che la madre di Saverio De Maria racconterebbe dal punto di vista astrologico per spiegarne l’andamento favorevole. I rapinatori arrivano alla spicciolata, allo scadere del primo intervallo del turno di mattina. Hanno l’aspetto di quattro operai che hanno profittato della sosta per andare a gustare un caffè nel baretto di don Luigi, uno che di miscele se ne intende. Il commissario infila un gomito nelle costole di Carmine.
– Quella faccia di bronzo di Capatosta è venuto di persona. Il colpo merita evidentemente la presenza del capo
Salvatore Campopiano si ritrova ammanettato prima di rendersi conto di essere fregato e la sfilza di bestemmie fa scoppiare De Maria in una risata che contagia Carmine fino alle lacrime.
***
Il commissario non crede ai suoi occhi. sorpresa Capatosta è rimastoto a Poggioreale neppure un anno e rieccolo in circolazione, più in ballo che mai.
— Dottò, commenta l’autista, ‘sti fetienti si pagano i meglio avvocati, chi vi credete?
Non è Capatosta il vero problema. O almeno non solo gente del suo stampo. Balordi come lui nascono dappertutto e se fossero fenomeni isolati si potrebbe pensare di renderli inoffensivi. La questione, pensa De Maria, è questa dannatissima città, tutte le fottutissime città con diffuse aree del malessere sociale, con troppi stimoli negativi e alibi che fanno arruolare tanti ragazzi nell’armata della malavita e nelle truppe disperate dei drogati, dei diversi, degli esclusi, degli incolti senza colpa e dei violenti per necessità.
Sono queste riflessioni, non sempre implicite, che hanno etichettato il commissario non organico al sistema delle forze dell’ordine.
Il suo ufficio ha poco da dividere con lo stereotipo del bravo funzionario. Non c’è una scrivania classica. Nelle peregrinazioni tipiche del mestiere, De Maria si è portato dietro un paio di cavalletti su cui poggia una tavola larga per quanto è lunga, illuminata da una lampada da architetto. Un’incredibile serie di boccali, in cui si affollano penne e matite di ogni tipo, convive sul piano con pile di libri, mucchi di giornali e riviste, una scacchiera d’alabastro, posacenere che ricordano i viaggi in mezza Europa.
Improvvisa, in Questura arriva la grana e non è sorprendente l’idea di affidarne la soluzione proprio al commissario De Maria. È una di quelle rogne con infinite e imprevedibili implicazioni che nessuno vorrebbe trovarsi tra i piedi. La questione parte di lontano e, a volerla datare, almeno all’inizio degli anni ottanta, quando la droga ha sopravanzato i confini di una circolazione ristretta agli ambienti bene della città, ai grossi centri di provincia. Come olio su di un piano in discesa, gli stupefacenti hanno invaso terreni vergini e specialmente quelli delle periferie oppresse dall’abbandono, dei piccoli centri che a quelle periferie urbane somigliano sempre di più. Sono luoghi dove le istituzioni non ci sono. Molti anni prima il rione Traiano aveva scandalizzato urbanisti e sociologi con le sue tipologie di quartiere dormitorio. Una fotografia, divenuta famosa, ritraeva una vecchia curva sulla macchina per cucire, al centro di un piazzale immenso, assolato. La poveretta si era illusa di poter proporre in una situazione impossibile modelli di vita associativa tipici dei vicoli di dove era stata deportata.
Sulla soglia del basso, in via Ventaglieri, quella Singer era a disposizione dell’intera zona. Una piega scucita, una veste da accorciare, un colletto di camicia da sostituire, trovavano risposta immediata. Nel tempo il Traiano è stato rivalutato, e paradigma della marginalità sono ora la 167 di Secondigliano, Scampia. Di qui proviene un quarto della delinquenza minorile di Napoli e l’evasione della scuola dell’obbligo sfiora il dieci per cento della popolazione. L’edilizia, ispirata agli standard delle leggi sulle residenze popolari, qui assume a una sua deprimente specificità. Stecche di dodici, quattordici piani, si sviluppano per decine e decine di metri e alla fine diventano barriere di cemento bucato da migliaia di celle densamente abitate. C’è dappertutto un che di non finito: il verde mai impiantato, scuole e luoghi di aggregazione, impianti sportivi, promessi per incentivare l’insediamento e dimenticati, perfino ascensori mai installati e l’assenza di una trama pur minima di attività commerciali. Il nuovo, ai suoi margini si confronta con il vecchio che, in fatto di vivibilità, vince nettamente il confronto. Per quanto caotico e malandato, l’antico tessuto sociale ha perlomeno dimensione umana.
Nel cuore della 167, strappati all’inutilità funzionale, sono stati recuperati trecento metri quadrati coperti per il Campo all’interno della piastra su cui poggiano le cosiddette Vele, esempio velleitario di edilizia popolare, che altrove segnala modernità e a Scampia abbandono, degrado. Le Vele brulicano di umanità impaurita che si protegge con grate e cancelli robusti, annullandosi all’interno di case bunker in cui regina è la televisione.
Una scuola giusta, malgrado tutto, ha indagato dentro di sé per capire il nesso tra comportamenti e subordinazione psicologica a una certa televisione. La graduatoria delle preferenze ha in Rambo il primatista assoluto, seguito con distacco dai Vendicatori della notte, dal Kung-Fu e dalle macabre proposte di Dario Argento. Le ragazzine della media Savio II sognano di andare a passeggio con Silvester Stallone nelle impraticabili stradine del rione Kennedy, finalmente protette da maniaci e scippatori. I ragazzi fantasticano sul bello dell’identificazione con l’eroe invincibile.
 Nel cuore della 167 nasce il Campo, presidio antidroga e Pietro Carella costruisce la sua più accativante favola da donare a Giulio e Vincenzo, Ernesto, Peppe e Valerio, Antonio, Stella, e a tanti altri viandanti solitari. La camorra è in allarme. Pietro comincia a sottrarre prede agli spacciatori e però non sono i drogati del Campo a mettere in crisi i trafficanti. Per loro è senza speranza l’ideologia del recupero. Altri nemici osservano con sospetto e poi con ostilità quest’uomo mite, solo in apparenza, che rivela doti di catalizzatore e pericolose capacità di coinvolgimento. Gli sono contro anche gli operatori che non intendono aggiungere nulla al loro ruolo di distributori di metadone. Ma chi proprio non tollera il carisma emergente di Pietro è la congrega dei privati che si attrezzano per occupare ogni spazio lasciato libero dall’inerzia dell’istituzioni. In vista della legge e soprattutto dei finanziamenti regionali, le strutture pubbliche, è opinione diffusa, tarderanno a attivarsi, saranno approssimative, inefficaci, soffocate dalla burocrazia e da ipoteche lottizzatrici dei partiti. Il Campo è scomodo, smentisce il teorema dell’inefficienza pubblica.
Nel cuore della 167 nasce il Campo, presidio antidroga e Pietro Carella costruisce la sua più accativante favola da donare a Giulio e Vincenzo, Ernesto, Peppe e Valerio, Antonio, Stella, e a tanti altri viandanti solitari. La camorra è in allarme. Pietro comincia a sottrarre prede agli spacciatori e però non sono i drogati del Campo a mettere in crisi i trafficanti. Per loro è senza speranza l’ideologia del recupero. Altri nemici osservano con sospetto e poi con ostilità quest’uomo mite, solo in apparenza, che rivela doti di catalizzatore e pericolose capacità di coinvolgimento. Gli sono contro anche gli operatori che non intendono aggiungere nulla al loro ruolo di distributori di metadone. Ma chi proprio non tollera il carisma emergente di Pietro è la congrega dei privati che si attrezzano per occupare ogni spazio lasciato libero dall’inerzia dell’istituzioni. In vista della legge e soprattutto dei finanziamenti regionali, le strutture pubbliche, è opinione diffusa, tarderanno a attivarsi, saranno approssimative, inefficaci, soffocate dalla burocrazia e da ipoteche lottizzatrici dei partiti. Il Campo è scomodo, smentisce il teorema dell’inefficienza pubblica.
Il piano per annientare Carella e il Campo nasce nella testa di Onorato, eminenza grigia e capozona di don Vittorio, boss dell’hinterland napoletano. Il giovanotto, evento rarissimo, s’è fatto un nome tra gente di rispetto senza aver mai compiuto un atto di violenza in prima persona. Tutto cervello, è l’inventore dei patteggiamenti tra parte della malavita e i vertici dell’ordine pubblico. È una strategia semplice, la sua, ma di innegabile produttività. Si passa voce tra gli affiliati di dar sotto con i furti di automobili e di prendere di mira quelle di proprietari eccellenti. Auto di consoli, per esempio, di magistrati, giornalisti, ricchi imprenditori e turisti. Prefettura e questura diventano bersaglio di proteste indignate in un crescendo che le tiene sulla corda per qualche mese. Non resta che contrattare la tregua con i due o tre boss a cui è riconosciuta la leadership del settore. E un do ut des ormai accettato come regola del gioco. Un piede schiaccia il pedale del freno e i furti d’auto rientrano nei limiti fisiologici, un altro preme sull’acceleratore e c’è un occhio si chiude per i ladri di appartamenti o i trafficanti di sigarette.
Onorato indaga su Pietro Carella e il suo Campo con scrupolo da investigatore e in breve si appropria degli elementi su cui costruire la capitolazione del pericoloso personaggio e dell’ideologia che lo ispira.
Il tenente Vaccaro, quando si è arruolato, aveva in mente una certa idea dell’arma dei carabinieri. Pensava a un corpo di gente tutta d’un pezzo, inflessibile, castigatrice di ogni genere di mascalzoni, rammolliti, intrallazzatori, corrotti e eversivi. Non ha messo molto a capire che anche i carabinieri devono fare i conti con compromessi, tolleranze, condizionamenti della politica e perfino qualche sporadica complicità con gente non proprio per bene. Pian piano la sua fedeltà all’arma si è trasformata in disamore, in sofferte critiche a permissività e debolezze, nella scelta sofferta di rimanere carabiniere ma con un proprio codice di comportamento. L’ansia di quella che definisce pulizia morale diventa violenza illecita nei confronti di quanti ritiene spazzatura umana. E sono vittime che pagano per intere categorie: puttane e drogati, scippatori e travestiti, ladri di polli e sovversivi.
Il maresciallo Alfano non lo sopporta. Dopo tanti anni in divisa s’è fatto l’idea che dietro molti comportamenti della cosiddetta devianza si nascondono storie di sofferenza e marginalità. L’esperienza sollecita indulgenza piuttosto che intransigenza. Si sente a volte un poveraccio fra altri derelitti e solo per caso sottratto alla strada, al loro stesso destino. Al colonnello Bernardi ha parlato chiaro.
– Ho chiesto il trasferimento, ma non riesco ad ottenerlo. Non ho mai fatto storie signor colonnello, ma questa volta, mi dovete credere, o mi accontentate o lascio l’arma.
Giovanni, ex contadino del beneventano, è diventato portinaio per il bene dei figli. Al paese i ragazzi avrebbero subito la sorte di una realtà immobile attorno alla sua povera economia agricola. Ora studiano, son diventati cittadini e grazie a qualche appoggio di gente importante il loro futuro non è così nero. Giovanni consegna la posta al maresciallo di turno e questi la distribuisce sui tavoli.
“Al comandante Vaccaro, strettamente riservata”, dice l’intestazione su una busta dozzinale, battuta da una macchina per scrivere che avrebbe necessità di manutenzione straordinaria. Le lettere tonde confondono i contorni con l’interno, la C maiuscola si stampa a metà tra un rigo e l’altro, la effe manca del tutto. “Dove sono finiti duecento milioni destinati al “Campo? Vendere metadone del centro è o non è un reato? Dal Campo sparisce metadone: controllate il pulmino della USL e i clienti di lusso. Un Amico”.
La stessa lettera è sul tavolo del sostituto procuratore Dell’Erba, ancora sconvolto per la morte di Marco, il figlio della sorella stroncato da un’overdose a diciannove anni. Il nipote aveva trascorso inutilmente diciotto mesi di vita balorda nella comunità terapeutica Il coraggio.
I messaggi anonimi sono di Onorato.
Il colloquio fra il tenente Vaccaro e il magistrato gode di straordinarie sintonie.
– Giudice, lasciatemi carta bianca. Un solo favore, autorizzatemi a mettere sotto controllo il telefono di Pietro Carella.
Gli uomini di Vaccaro si attivano e inizia un lavoro capillare di ricerca dei punti deboli per incastrare l’operatore e il suo clan. Il gruppetto storico di tossicodipendenti è lasciato fuori perché, si sa, è solidale
con Pietro, ma i contatti con le frange che frequentano sporadicamente il Campo si allargano a macchia d’olio.
- Vito, ti conosciamo bene. Spacci la roba al rione Kennedy e chiudiamo un occhio solo perché sei marcio di eroina, ma c’è un limite a ogni tolleranza… capisci?
– State sbagliando. Non mi faccio più e non spaccio una bustina da mesi.
- Vito, a chi lo racconti. Nessuno esce dal giro e nemmeno tu. Ma detto fra noi me ne frego se ti fai o no. Se ti voglio sbattere dentro lo faccio quando mi pare. Hai capito? Sta’ attento a come rispondi. Carella, il metadone se lo vende?
Vaccaro è certo che prima o poi qualcuno cederà. L’appuntato Marino indaga in altre direzioni. Duecento milioni, dice la segnalazione anonima, tirati fuori dalla Regione.
Il dottor De Luca si mette a disposizione.
– Ecco qui la delibera. È la 89/7215. I milioni sono andati all’unità sanitaria locale che ha competenza sul Campo e non sono duecento, ma ottanta di più. –
Il presidente della Usl cade dalle nuvole.
– Appuntato, sono quì solo da un mese e mezzo e di questi soldi non ne so niente. Posso chiedere ai miei collaboratori… Schiavone, venga un momento. Com’è sta storia dei soldi per il Campo?
– Dottore, a loro li abbiamo girati. Chiedete al dottor Carella.
L’appuntato Marino regala la scoperta al tenente Vaccaro. Di quei soldi, nelle casse del Campo non c’è traccia.
– Tutto quadra, tenente. E se no come avrebbe fatto uno stipendiato, Carella questo è, a farsi una casa di cinque stanze?
È un giorno di dicembre che a Napoli sembra primavera e la gente i cappotti ancora non li ha tirati fuori dall’armadio.
Sono le 16 e 45. I carabinieri irrompono nei locali del Campo e bloccano le uscite. Due gazzelle inchiodano il furgone della Usl accanto al marciapiedi, mentre è pronto a mettersi in moto.
Manette per Pietro Carella e i suoi collaboratori, manette per chi occupa il furgone, sigilli alle porte del Campo e l’Ansa trasmette il primo flash di agenzia: “Blitz dei carabinieri nel centro antidroga Il Campo. Arrestati il dottor Pietro Carella, noto operatore del settore e cinque collaboratori. Le accuse sono…
Il primo a reagire è l’onorevole De Matteis. Deputato repubblicano da due legislature, è stato eletto grazie ai voti di un’area che comprende l’unità sanitaria competente sul Campo. Conosce bene il presidio e il lavoro di Carella. Grazie a lui Nicola è tornato a vivere. Quando il parlamentare ha scoperto che il figlio si drogava poco è mancato che non ne morisse. Per sua fortuna ha superato bene l’infarto, forse neppure di un vero infarto si è trattato, e da quel momento si è dedicato al recupero di Nicola. La prima idea è stata di affidarlo a Muccioli ma Nora, la moglie, sapeva del Campo e di un operatore davvero speciale che di ragazzi ne ha recuperati parecchi.
– Pietro, che devo fare? –
– Onorevole, non lo so. Voglio dire che il mio non è un metodo, una formula. Non sono un guaritore. Chi è riuscito a uscire dalla dipendenza non ha sconfitto l’eroina, ma la disperazione. E non è detto che l’abbia vinta per sempre. Volete che mi occupi di Nicola? Lo farò, ma non vi aspettate cure mediche, miracolose terapie farmacologiche o che lo incateni per fargli superare la crisi di astinenza.
Nicola è uno dei ragazzi serviti a domicilio, ma che sia figlio di un parlamentare non c’entra nulla. È un ragazzo saturo di angosce, insicuro, fragile, avvilito. Un perdente. La sua ansia discende da una forte subordinazione psicologica al padre, che pure lo adora. L’onorevole è uomo senza difetti e con mille primati. Di famiglia povera, si è inventato l’autonomia economica dai tempi della scuola, ingegnandosi in cento piccole ma redditizie attività, senza ricadute negative sullo studio. Era ancora al liceo quando ha sentito la vocazione per la politica. Ancora una volta lo studio si era integrato con i primi passi nel partito repubblicano, i rimborsi per il suo prezioso lavoro di raccolta e sistemazione di documenti, pubblicazioni, articoli, utili all’elaborazione politica del partito e per riempire di contenuti discorsi, comizi. Un capolavoro il suo matrimonio. Nora Campassi ha integrato alla perfezione le qualità del marito con riconosciute doti di creatività, estro, intuito, partecipando attivamente alla sua affermazione, che ora si concretizza in un ruolo non secondario alla Camera e in un peso rilevante nella direzione repubblicana. L’onorevole soffre la pena per il figlio dapprima con un senso di frustrazione, poi con rabbia da impotenza.
Nicola del padre non ha l’equilibrio, né la determinazione, e della madre non ha la vivacità intellettuale. Le sue aspirazioni non hanno mai oltrepassato la soglia di un lavoro tranquillo, normalmente retribuito e di svaghi da gente comune, come il calcio, la televisione e un po’ di musica leggera.
Pietro gli ha insegnato a parlare del suo rancore verso i modelli ambiziosi che non gli sono propri e rivolto al padre…
— Onorevole, dovete prurre un lavoro a Nicola, niente di trascendentale. Un lavoro.
Il ragazzo si è presentato alla compagnia di assicurazioni con la faccia grigia e gli occhi acquosi, incapaci di stabilità, con in corpo la dose di metadone. Ornella, volontaria del centro, glielo ha portato come ogni giorno, dosi a scalare, senza chiedergli nulla, attenta soltanto alle trasformazioni comportamentali del paziente. E’stato Nicola a decidere di frequentare il Campo saltuariamente, per ritrovare un filo di pensieri con Pietro e le sue favole terapeutiche dolci, intense. Il blitz dei carabinieri al Campo si basa proprio su quelle dosi di metadone, consegnate a domicilio per consentire a Nicola di sentirsi utile, con il lavoro.
I
l commissario De Maria riceve l’incarico di una contro indagine per le pressioni dell’onorevole De Matteis sulla prefettura che a sua volta ha delegato la questura.
– Carmine, stavolta va a finire che ci divertiamo pure. Pensa lo sfizio di sputtanare qualche fesso tracotante. E mò non andare dicendo che ce l’ho con l’arma, se no ti sbatto al seguito di qualche commissario vero.
Dal ministero degli interni arriva l’autorizzazione all’inchiesta parallela e si parte dalle intercettazioni telefoniche. Una noia mortale. Le conversazioni di Pietro Carella sono banali ordini di servizio. Registrano contatti con i ragazzi che non possono frequentare il Campo e screzi con i funzionari dell’unità sanitaria locale per la cronica disattenzione al problema dei volontari senza i quali il Campo non avrebbe senso. C’è una sola telefonata sulla quale è stato costruito uno dei sospetti del magistrato e si riferisce a colloquio dell’operatore con un amico avvocato che assume gratuitamente la difesa dei tossicodipendenti, ogni volta che piove loro addosso l’accusa di spaccio.
– Ho paura – ha detto a Carella il legale.
Il tenente Vaccaro ha lasciato intendere al magistrato che i timori dell’avvocato nascondono irregolarità nella gestione del Campo di cui sarebbe responsabile l’avvocato quanto Carella.
– Avvocato, allora perché avreste paura? –
– Ecco commissario. Dite voi se questa è una buona ragione. Ricevo una busta, dentro un foglio quadrettato ela scritta “Lasciate perdere con quegli smidollati che si bucano. Pensate a vostra figlia Graziella”.
E il solerte Vaccaro? È rimasto all’interpretazione che più gli fa comodo, non ha approfondito.
Altro capo d’accusa: gli operatori hanno distratto molti flacconi di metadone e li hanno portati fuori dal Campo per favorire figli di personaggi eccellenti.
– Vede commissario… metadone, terapie di gruppo, qualunque altro intervento, servirebbe a poco se questi ragazzi restassero ad aggrovigliarsi in un circuito perverso di interdipendenza con l’eroina. In questo caso le loro giornate diventerebbero una guerra permanente per procurarsi la droga. Il metadone è solo lo strumento per stabilire il contatto con i ragazzi, per evitare che la loro vita sia regolata da una solitudine che si riempie con il buco. Cerchiamo di evitare che quelli tra loro che hanno il lavoro, lo studio, un rapporto affettivo, siano costretti a lasciare ogni cosa e a venire al presidio per il metadone. Forse abbiamo commesso un’irregolarità con il nostro servizio esterno, ma peculato… concussione… Non c’è un grammo di metadone che sia sfuggito alla registrazione in uscita.
L’inchiesta della magistratura procede nel frattempo per inerzia. Una volta avviata non si può dire “Scusate tanto, abbiamo sbagliato”.
Il tenente vendicatore profitta della paralisi assistenziale del Campo e del ritorno di molti ragazzi all’eroina, alla schiavitù nei confronti degli spacciatori.
La camorra sa bene come riprendersi quanto il centro le aveva sottratto. Immette nel giro droga di inconsueta purezza e intensifica la presenza dei suoi distributori nelle vicinanze del Campo. Il giudice Dell’Erba dispone una raffica di comparizioni per i ragazzi di Carella. Soprattutto convoca i più esposti. Quelli che hanno precedenti da far dimenticare, altri ricaduti nella trappola dell’eroina.
Agli interrogatori è presente il tenente Vaccaro.
– Falcone, attento a come rispondi. Carella si faceva pagare il metadone? Dico, dai drogati assistiti a domicilio…
– Non ne so niente.
– Allora non hai capito, Falcò. Io ti rovino. Devo rinfrescarti la memoria sulla rapina a Casavatore?
– Signor giudice, con quella rapina non c’entro niente e per quanto ne so Carella non ha mai preso una lira da nessuno.
– Tenente, attenzione con questi metodi poco ortodossi. Non vorrei che vi trovaste con una denuncia per abuso di potere, commenta il magistrato che per quanto interessato a trovare riscontri alle accuse a Carella, non è disposto a tollerare i sistemi intimidatori del carabiniere.
L’unica testimonianzacontro è faticosamente strappata a Peppe Cortese, un ragazzo di vent’anni che il blitz al Campo ha riportato indietro di almeno tre anni. La sua ricaduta somiglia al furioso accanimento del fumatore dopo un periodo di astinenza. Peppe è uscito dal giro dello spaccio e ora non sa dove sbattere la testa per procurarsi la roba.
La testimonianza fasulla del ragazzo è praticamente comprata da Vaccaro prima dell’interrogatorio.
– Peppe, ti posso aiutare. Se non riesci a trovare l’eroina che ti serve, vieni da me e vedrò di darti una mano.
Non ci vuole molto per smontare la presunta confessione di Peppe, ma il commissario De Maria non vuole sprecare l’occasione e si riserva di utilizzare il ricatto subito dal ragazzo per mettere il carabiniere con le spalle al muro. Peppe si è pentito subito per aver venduto il Campo in un momento di debolezza e è disposto a raccontare come gli è stata estorta la testimonianza.
L’ultima insinuazione da verificare riguarda il presunto arricchimento che avrebbe consentito a Carella di comprare un bella casa, certamente non alla sua portata.
È’ proprio lui a ricevere De Maria. Il magistrato non ha potuto negargli il beneficio della libertà provvisoria. Ma sulla questione della casa prende l’iniziativa Anna Giulia, la moglie di Pietro. Si alza con calma e tira fuori da un cassetto della scrivania una cartellina rigida, chiusa da un largo elastico.
– Leggete con calma, commissario. É l’atto di donazione di questa casa, una specie di dote tardiva che mio padre mi ha fatto quando si è reso conto che con lo stipendio di Pietro e il fitto da pagare non riuscivamo a tirare avanti.
Pietro, con la sua faccia scavata, pallida, sorride appena.
– Bastava chiedere, commissario. Era sufficiente una domanda: come ha potuto comprare una casa così costosa? Nessuno, l’ha fatta. Commissario, posso presentarle Matteo, Ernesto, Ornella, Luigi e Mimmo, Nicola, Sergio… Sono ragazzi del Campo e ora che l’hanno chiuso stanno qui con me, un po’ arrangiati, certo, perché ho tre figli e non c’è spazio per tutti.
Resti a cena con noi. Sergio è un bravissimo cuoco.
AL TENENTE VACCARO, URGENTE. «Questo comando dell’Arma, con decorrenza immediata, Vi trasferisce alla tenenza di Trapani. Vogliate provvedere “ad horas” per le consegne al capitano Coviello».
Il telefono richiama il sostituto Dell’Erba alla realtà.
– E così vi hanno trasferito. –
– Ho il fonogramma sotto gli occhi, giudice. –
Il magistrato chiama a sua volta Virginio Assumma.
– Sono preoccupato. Hanno punito Vaccaro e ho l’impressione che l’aria si faccia irrespirabile.
Il segretario dell’assessore ha i suoi grattacapi. Gli arrivano pressioni da tutte le parti perché Carella sia reintegrato nel suo posto di lavoro e il Campo sia riaperto.
– Ho anch’io i miei guai, ma tu sta’ attento e se puoi fare marcia indietro, senza perdere la faccia, non fartene scrupolo. Si è mossa troppa gente a favore di Carella.
Dalla procura della Repubblica vengono segnali di identico tenore. In questo momento si vuole evitare di dar fiato ai sostenitori di un garantismo sfrenato a cui danno voce troppe forze politiche, seppure con motivazioni diverse.
– Giudice, trovate il modo di sgonfiare questa storia. Non dico bruscamente, ma con gradualità, ripristinate la normalità. —
Saverio De Maria passa una mano sugli occhi e gli occhi bruciano di stanchezza, l’altra nei capelli, capelli arruffati come al solito, e porta il sedile dell’auto indietro fin quando va. Stende le gambe, si tasta lo stomaco che ora si fa sentire e, chissà perché proprio ora, pensa a Patrizia.
Patrizia che ha sconfitto la sua inerzia affettiva, quel vago senso di indisponibilità all’innamoramento, l’avversione per storie di clandestinità, il disagio di affrontare conflitti intellettuali.
E’ una settimana che non fa l’amore con Patrizia. “Strano”, pensa “c’è sempre un altro modo di far l’amore”. Avrebbe scommesso di non aver più nulla da scoprire. Non è che Patrizia abbia inventato chissà che, eppure far l’amore con lei è stata un’esperienza assolutamente nuova, emozionante.
Voleva proprio conoscerlo, ha detto la donna a De Maria quando ha ricambiato la stretta di mano di presentazione.
– Lei mi incuriosisce. Ho ascoltato un paio di suoi interventi in circostanze particolari. Ad esempio quando si è discussa la questione dell’affidamento e più in generale della tutela dei minori. Mi sono chiesta se è possibile che un poliziotto concili davvero il suo mestiere con idee tanto avanzate. Ora lo chiedo di persona, possibile? Saverio ha il vezzo di appropriarsi della struttura verbale dell’interlocutore e rinnova il gioco del cosiddetto ricalco.
— Lei mi diverte. Ho badato a un paio di sue espressioni, durante il dibattito di questa sera, quando si è parlato di violenza sulla donne. Mi sono chiesto se è possibile che una donna come lei sia davvero così indifesa. Ora lo domando direttamente a lei.
Patrizia è a suo agio, mentre d’abitudine diffida di interlocutori appena conosciuti, quando il fastidio traspare dagli occhi che guardano senza vedere, dalla voce, che annuisce senza andare oltre. Ora Patrizia sorride e si chiede perché, di là dal divertimento per il gioco verbale del commissario. Non sa che con il ricalco si realizza un circuito perfetto di complicità emotiva. Se è divertita per le risposte speculari che ha ricevuto è però inconsapevole di tante altre comunicazioni non verbali trasmesse senza averne consapevolezza al commissario.
Patrizia, non dà rilievo alle parole che ritiene importanti con una particolare accentuazione della voce, ma restringendo lievemente il campo visivo, socchiudendo le palpebre. Lo sguardo diventa in quel momento più intenso e le mani strette sulle braccia, poi poggiate sui fianchi. Le braccia sono esili, affatto spigolose nonostante la magrezza. Le dita sono lunghe e affusolate. Per comunicare “ecco, questo è importante”, ruota il polso fino a costringere la mano in una posizione quasi rigida, parallela al pavimento, perpendicolare al corpo, mentre le estremità del pollice e del medio si toccano per formare un cerchio che si apre e si chiude continuamente con contatti ripetuti dei polpastrelli. Il ritmo del respiro è frequente oltre il normale e ogni tanto, sopravviene un respiro profondo, come a rallentarlo. La fronte, magra come il resto del corpo, è appena protetta dalla pelle e una vena più marcata delle altre pulsa in evidenza, in sintonia con il battito del cuore.
A Saverio basta l’osservazione di questi impercettibili messaggi per adottarli uno a uno. Forza il proprio respiro perché coincida con quello di Patrizia, replica il gesto della mano e la sottolineatura delle parole con gli occhi e lei prova il disagio di sentirsi indifesa, ma non ne è turbata. Anzi annulla la tensione iniziale, si libera dell’istintiva conflittualità pregiudiziale e progressivamente stabilizza respiro e battiti del cuore. L’effetto è simile alla quiete che la mamma, distesa sul letto accanto al figlioletto trasmette con i suoi respiri profondi, che i bambini finiscono per emulare fino ad addormentarsi, perfetta operazione di ricalco.
La prima volta, nella mansarda di Patrizia, nessuno dei due ha voluto anticipare di un attimo l’esordio del rapporto sessuale. La casa è molto piccola, ma graziosissima. È’ il rifugio della donna che continua a convivere saltuariamente con il marito una casa che non sente più sua. La mansarda è ha il calore dei rivestimenti in legno delle pareti e di grandi travi che reggono il solaio. La piccola dimensione è compensata dal razionale funzionalità. Da una stanzetta di passaggio si accede al terrazzo e l’ampio soggiorno-letto, si completa con una tavola poggiata su cavalletti, per metà utilizzata come studio, con il computer, la lampada da architetto, libri fotografie, per metà riservata a colazione, pranzo e cena. Piani d’appoggio lungo le pareti sono stracolme di compact disc e libri, troppi. Molti sono sul parquet, in pile alte da terra. Al lato della stanza che s’apre sul balcone una grande vetrata, che ha sottratto spazio al muro esterno, rientra a scomparsa su guide di acciaio. Il letto, ampio e corredato di soffici cuscini, guarda direttamente il mare di Posillipo che di quassù appare blu e brillante dall’alba al tramonto, grazie al percorso senza ostacoli del sole che l’inonda appena si affaccia dal profilo del Vesuvio, fino a scomparire oltre Nisida. Patrizia, la prima volta, si è tolta subito le scarpe, per liberarsi di ogni costrizione. Si e poi seduta sul letto, due cuscini dietro la schiena, il posacenere accanto, le gambe ripiegate sotto il corpo, un ginocchio arretrato. L’altra gamba è rimasta scoperta con un risultato non involontario di seduzione.
– Se te lo chiedo, sei capace di raccontare a che cosa pensi in questo momento o rispondi come tutti a niente? –
Saverio confermerebbe la risposta evasiva ma deroga dall’abituale riserbo
– Non so perché, ma sono preso dal fascino di un ricordo nascosto da tempo in un angolo della memoria. Forse ricorderai di quel medico svedese che ha introdotto in un’arteria una sottilissima sonda munita di fibre ottiche, per fotografare l’interno e ha insegnato a riconoscere l’uomo come entità speculare di altri elementi della natura. Le immagini di quell’arteria erano la appunto la natura: piante e colline, vallate, mari, paesaggi.
– Che bello, ma scusa l’intraprendenza, che c’entra, con l’emozione in attesa di fare l’amore?
-Forse questo.
– Saverio prende tra le sue una mano della donna. Nell’incavo delle dita ripiegate cerca il contatto del suo medio con l’anulare di Patrizia. che ne avverte il significato simbolico, della penetrazione. Allo stesso modo, l’interno di una vena, esplorato dall’obiettivo della mini telecamera si propone come frammento rappresentativo di un paesaggio terrestre.
– Qual è la prossima fantasia?
– Hai mai osservato un uomo e una donna guardarsi negli occhi con intensità: c’è un movimento lieve ma costante in quegli sguardi, un breve vagare dell’iride agli angoli, prima di riunirsi dritti nelle pupille. Prova a guardarmi negli occhi, non provare a comunicare, non leggere nei miei. Sarò io a entrare nel tuo sguardo, a oltrepassarlo, a raggiungere la profondità di quello che provi in questi momenti. Ecco, sono già oltre il primo schermo di difesa. Le tue pupille ora sono permeabili e si dispongono a essere violate.
Saverio bluffa, ma fino a un certo punto. L’idea della penetrazione richiama davvero una reazione emotiva e le pupille davvero ingrandiscono a vista. Patrizia si lascia invadere. La sensazione di essere vulnerabile evoca fantasie di altri tempi, quando la resa di “O” all’uomo padrone l’aveva indignata ma anche affascinata. Proprio come ora “con quest’uomo che arresta camorristi e legge Proust, comanda poliziotti e sogna come una bambino e forse fa l’amore come un dio.
Quella prima volta non è finita lì. Non quando Saverio se n’e andato senza dir ciao e neppure il giorno dopo e l’altro ancora, un tempo giudicato da Patrizia eclissi totale, incomprensibili e neppure dopo la sorpresa di farsi trovare nella mansarda dov’è entrato con il passepartout, ferro del mestiere preso a prestito dal fidato Carmine.
E non è finita neppure ora, dopo una settimana di assenza spesa a risolvere il caso Carella. In ciascuno dei due è rimasto un sapore di magica follia o di folle magia. Per Patrizia non sono espressioni equivalenti mentre per Saverio l’una e l’altra si equivalgono. – È’ come dire che maghi e pazzi sono uguali. Ma scherzi Saverio? Io sono certamente folle in questo momento e non ci trovo niente di magico. Se tu sei mago, come credo, sei certamente sano di mente. Devi scegliere, commissario, ti concedo una sola condizione delel due.
– Mi tengo la magia, grazie. Sono già pazzo, o se vuoi troppo lucido, in tanti momenti della mia pazza vita. Detto tra noi, non capisco perché tollerano un poliziotto come me in una polizia come questa e non mi spiego ovviamente perché ci resto. Follia è la nostra storia, ma la mia mano sul tuo viso è una magia e magici sono i giochi d’amore che inventiamo. Pazza è l’idea di scoprirne sempre un altro ma è magico il tuo modo di assecondare la gara. Prova Patrizia. Entra nei miei occhi. Fin dove puoi.
*
‘O sciancato, in italiano è intraducibile. È più, anzi peggio di zoppo. È zoppo storpio. ‘O sciancato di mestiere fa il palo. È un professionista e free-lance che presta la sua opera per chiunque sia disponibile a ingaggiarlo, pur conoscendo le quotazioni del suo cachet, ovvero duecentocinquanta euro per una rapina e il doppio per un regolamento di conti, spese escluse. Una delle specialità di Domenica Carfora, ‘o sciancato, è un fischio molto modulato e potente, eseguito con pollice e medio congiunti alle estremità e poggiati con forza sulla lingua arrotolata all’indietro. Nel suo codice un sibilo acuto e due gravi sono il segnale per mollare tutto e darsi a gambe levate, ma nel dna c’è il vanto di aver fatto ricorso all’avvertimento solo un paio di volte. In tasca ha l’anticipo che gli ha messo in mano don Gennaro in persona: un rotolino di banconote legato con un elastico giallo.
– Mimì, gli ha detto il boss, da oggi devi sentirti l’ombra ‘e chillu fetente d’’’o commissario De Maria. Voglio sapé che ffa, addò va.
‘O sciancato ha una macchina per il lavoro e una per il tempo libero. La stravecchia Cortina sembra uscita dallo scasso e la ruggine se l’è mangiata per metà, ma Peppe Turbo gli ha messo nel cofano una bomba di motore che la fa filare come un razzo. Se ne sta seduto di traverso al posto di guida e riflette. “E bravo il commissario. Ha una colombella nascosta niente male. E mò se la sta passando. Ma che gliene frega a don Gennaro di questo poliziotto chiava tore…”
Gliene importa, altro che. Pur nella sua dimensione di boss, Gennaro Ammaturo deve dar conto a un mucchio di personaggi più importanti di lui. La storia del Campo non è andata giù. Pietro Carella è di nuovo al lavoro e le pecorelle smarrite sono tornate all’ovile. Decine di drogati avevano ripreso a bucarsi prima del suo rientro e la camorra era appagata dal risultato, ma è stato un successo breve e De Maria deve pagare per aver fatto saltare il piano che avrebbe tolto di mezzo Carella e i suoi collaboratori.
– Don Gennà. Ho buone notizie. Il vostro uomo se la fa cu ‘na guagliona a Posillipo e quando è impegnato, voi mi capite, ci sta insieme tutt’ ’a nuttata.
– Statte bbuono, Mimi. Quando è il momento, ti chiamo. –
Ci vogliono due uomini fidati, in gamba. Professionisti. I fratelli Russo, per esempio.
Comincia a diventare una dipendenza. Saverio trascorre più notti con Patrizia che nel suo buco in centro. Sempre meno gli garba la routine del commissariato e lascia che s’ammucchino sul tavolo le “circolari del cavolo”. Ne ha abbastanza anche dell’ambiguità della sua duplice interpretazione del ruolo di poliziotto umano e di intellettuale velleitario.
Carmine taglia a memoria le curve dei tornanti che portano all’edificio bianco, a metà della collina di Posillipo, in mezzo a un verde intenso, solo un po’ sbiadito in cima agli alberi più alti, sbiancati si dalla salsedine.
– Strano, sarà un caso, ma quella Ford l’ho già vista e con quella faccia da schiaffi al posto guida…
– Carmine, piantala di pensare sempre come un poliziotto. Stammi bene, vattene a casa, va e torna domattina alle 8. Porta i giornali.
Mario e Giovanni Russo, di Scisciano. Un centro senza particolari qualità della provincia napoletana, dove la stentata economica agricola convive con mani di rapina sull’edilizia privata e pubblica, con l’intermediazione camorristica tra committenza e imprese di costruzione che ha arricchito la vecchia mafia e generato la nuova, sanguinaria, che ricicla i proventi illeciti in affari puliti oltre che in traffici illegali. I Russo si sono fatti un nome come killler. Di morti ne hanno una dozzina nel curriculum e la carriera non è poi cominciata da molto.
L’Alfa è in sosta a un paio di metri dalla Ford dello sciancato, a distanza utile per una manovra agevole. É da poco trascorsa l’una della notte e nella stradina privata non c’è anima viva. Il portoncino d’ingresso si apre in un amen. Su, per le scale, senza il minimo rumore. i killer imboccano la stretta scala da cui si accende al terrazzo, a fianco della mansarda. Di lì il balcone è a non più di sessanta centimetri. La notte è tiepida e la grande finestra è socchiusa per consentire alla brezza marina di rinfrescare l’interno. Senza particolari cautele, uno dei fratelli la spalanca. Appena dentro la stanza tutti e due si piegano sulle ginocchia e portano avanti le braccia, le mani unite attorno alla pistola, in posizione di tiro. Sulle canne delle rivoltelle i silenziatori. Sei piccole fiammate in sequenza da ciascun’arma e i corpi di Patrizia e Saveriò si chiazzano di sangue…
Restano così, in posizione scomposta.
E così li trova Carmine che mezz’ora dopo le otto, l’indomani, ha atteso invano il “pronto” di De Maria al citofono.
– Mamma mia, che carneficina. Commissà, fosse l’ultima cosa che faccio in vita mia, giuro che taglio la testa al fetente che vi ha fatto fuori. Come un cane lo scanno.
Beniamino Murolo, solo lui può sapere qualcosa.
– ‘Na Ford? È’ d’o sciancato. Si, sta a Furcella. Sapite ‘o bar Azzurro? La ‘o truvate.
È davvero lì. Domenico Carfora, con un Biancosarti tra le mani, discute del blitz che i ragazzi del quartiere hanno fatto al Vecchio Pellegrini per ripotare a casa il corpo senza vita di uno di loro, stroncato da un’overdose. C’è voluto un esercito di poliziotti per riprendersi il cadavere.
Il poliziotto non va per il sottile.
– Domé. Io ti cancello dalla faccia della terra come uno scarafaggio e nessuno ti piangerà. Dimmi chi ti ha mandato a Posillipo o quanto è vero iddio ti buco la budella senza darti il tempo di pregare San Gennaro.
La salita della Rinascente, su verso l’ospedale militare, i vicoli di Montecalvario ancora feriti dal terremoto, le gabbie di tubi Innocenti, i puntelli di legno a croce, í commandos di scippatori sulle sguscianti Vespe 50 e in discesa un enorme bulldozer che ingombra tre quarti di strada: Carmine accosta a destra e la 127 fatica a salire sul marciapiedi per dar spazio al pesante automezzo. Lo guida abusivamente Giggino. Compirà diciotto anni fra due mesi e non ha nemmeno la patente B figurarsi quella speciale, richiesta per mezzi di pesanti.
– Mammà, grida, i freni. Mammà, nun frena.
Il ragazzo salta giù, mentre il bulldozer acquista velocità e si abbatte sulla 127 prima che Carmine si renda conto che di cosa stia succedendo. Per tiralo fuori occorre scoperchiare l’auto con la fiamma ossidrica.
Eduardo Postiglione è il più giovane commissario di polizia e gode di protezioni eccellenti. C’è il posto di De Maria da coprire e il ministero degli interni Io gratifica con una designazione che solleva non poche perplessità.
– Ben arrivato, dottò. C’è una busta per voi. L’hanno portata a mano un’ora fa.
“Ho ucciso io don Gennaro Ammaturo. È’ stato lui a pagare i fratelli Russo per ammazzare De Maria. I fatti sono andati così: vi informo perché l’ho promesso al commissario sul letto di morte. Quando riceverete questa lettera spero di essere lontano quanto basta. Carmine Costagliola.
Vendetta incompiuta, ma preziose rivelazioni.
Il posto sul volo BX 27382 resta vuoto e a Buenos Aires i parenti di Carmine tornano alla periferia della città, nella villetta costruita dopo anni di fatica, senza il nipote atteso invano all’aeroporto della capitale argentina.
Il commissario Postiglione si attiva e prova una strana euforia.:
– Adinolfi… Perrella… Luongo revocate i permessi. Domani voglio tutti gli uomini qui alle 5 e mezzo.
E al telefono
– Signor giudice dovete fare un piccolo miracolo, mi serve un ordine di cattura, subito, per Gennaro Ammaturo, nato a Marano di Napoli il 2-5-1931, pregiudicato e Mario e Giovanni Russo, residenti a Scisciano…
Eduardo Postiglione vuole arrivare lontano. Vendicare la morte di un collega con tre arresti da prima pagina è scorciatoia niente male.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 15 Gennaio 2017
SPARVIERO
di Luciano Scateni
Uno tra mille, nato per caso in via Speranzella anziché nelle vie Pacuvio, Tito Stazio, Catullo della città cosiddetta “bene”. Nella sua casa, messa su con l’essenziale, non una libreria, neppure il Cuore di De Amicis, ma il 45 giri di Franco Esposito, neomelodico che allude ai latitanti che trascorrono il Natale lontano dagli affetti. Sasà, uno tra mille, non ha gli strumenti minimi di riflessione per chiedersi a chi deve il tracciato della sua vita di precario sociale segnata dalla nascita nel ventre di Napoli e non nella città dei privilegi.
Il primo a chiamarlo «mezzo uomo» ne ha avuto ben donde. Salvatore, al primo ceffone del commissario Ammaturo, s’è sciolto in lacrime e il nome di Peppe Maresca gli è venuto fuori in un amen, assieme al pianto e al bruciore sul viso colpito come la testa di un birillo dalla manaccia a dita aperte. Peppe ha oltrepassato da tempo diciotto anni e il maresciallo De Simone l’ha portato a Poggioreale per una vacanza di sedici mesi. Quando è arrivata la polizia avrebbe voluto zittire la madre che squittisce nel vicolo «Figlio mio, che te fanno?» o cavare gli occhi a donna Jolanda, ipocrita consolatrice della donnetta. Soprattutto gli sarebbe piaciuto avere tra le mani quel fetente di Salvatore che lo spedisce dietro le sbarre. Un giuda da quattro soldi. Mentre infila la testa nello sportello della pantera della «Mobile» lo vede venir giù dal vicolo Santa Teresella e rialza la testa, si sporge oltre le spalle del maresciallo, gli grida «mez’ommo» e sputa in cielo, come se la saliva possa ricadere addosso a Salvatore.
Sui «Quartieri» lo spione ha chiuso. L’unico a non schifarlo è «Nennella», femminiello avvizzito e patetico sotto lo strato di cerone che copre malamente le rughe da maschio ma non il degrado di vecchio psicotico e le miserie dell’ambiguità un tempo ostentata, ora sofferta come una maledizione.
«Nennella» lo chiama «Sasà» e forse d’istinto, forse per calcolo, gli offre solidarietà, da diverso a diverso. La debolezza di Salvatore gli fa tenerezza e per un momento l’illude di poter usurpare uno spazio di sentimento materno. Un attimo dopo Sasà è il maschietto da sedurre, nonostante i colori e le chiazze dei capelli che le continue tinture hanno logorato, e un corpo già goffo di suo, ora devastato dall’adipe.
Perfino Lucia ne ha vergogna: con Salvatore sono cresciuti l’uno accanto all’altro, due bassi contigui, tormentandosi quand’erano «criature» con dispetti e battibecchi.
«Scema» l’apostrofava Salvatore, «mammalucco» replicava Lucia e non l’avrebbero smessa più se i rispettivi genitori non avessero adottato il buon metodo antico di un paio di scappellotti. Un giorno, qualcosa è cambiato. Lucia ha pensato a un incanto, al momento clou d’un fotoromanzo con i protagonisti immobili, a tutta pagina, a una canzone di Nino D’Angelo, al miracolo dell’Immacolata che se ne sta lì da sempre, sotto la campana di vetro ai piedi del letto, nel basso.
È la prima volta da tempo che il cielo, per il poco che arrivano fin giù in vicoli angusti, è più blu che azzurro. È il giorno magico in cui le ragazze, come sia corsa voce, mettono via gonne di lana e golfini, soprattutto le ragazze appena sbocciate come fiori dopo l’incubatore della pubertà. Lucia è in prima magistrale, quattordici anni compiuti da poco e una voglia matta di sentirsi addosso gli occhi dei ragazzi.
Salvatore s’arrangia con il padre dopo un percorso scolastico che l’ha fatto dannare. Al mattino, quando il vicolo si sveglia e nel basso ricomincia la routine d’ogni giorno, prova a infilare la testa sotto il cuscino, ma don Pasquale gli dà l’immancabile scrollata, lo butta quasi giù dal letto urlando.
S’avviano assieme, Salvatore con la borsa degli attrezzi a tracolla, dove li porta il mestiere di idraulici. Oggi però è festa, se si può dire così. Pasquale ha provato a superare in piedi l’influenza ma infine il virus l’ha spuntata e il brav’uomo è costretto a letto con febbre da cavallo e una tosse stizzosa, tenace, che si complica per trenta Marlboro al giorno.
C’è un paio di jeans mai messo nell’armadio di legno lucido dove non riescono a convivere decentemente le poche cose di don Pasquale e gli indumenti dei due figli maschi, uno più disordinato dell’altro.
Salvatore infila i pantaloni nuovi e ci mette su una camiciola larga, giallina, che accentua l’imponenza delle spalle da atleta. I capelli, indisponenti per due o tre indomabili vertigini, sono infine addomesticati da un’abbondante razione di gelatina. Nei vicoli che scendono a incontrare via Roma c’è qualcosa di diverso stamattina. Forse è la fine dell’inverno e della patina d’acqua e polvere che fa scivoloso il lastrico. In piazza Carità, nella sala giochi di Tonino Carcaterra, il solito fumo stagnante, nessun’idea di come sia il tempo fuori della pesante porta imbottita, i drin e bip dei video spaziali, i soliti ragazzi allucinati e il tifo contro le macchine che inghiottiscono monete a tutto spiano. Peppe s’è appassionato al circuito motociclistico, all’Honda che simula un gran premio della Gp, ai sorpassi che il computer grafico ha programmato per il video-gioco. Fuori, Peppe non ha ancora un’Honda che l’aspetta, non ancora. C’è invece un piccolo “Ciao”, rubato a chissà quale signorino dell’Umberto, in prossimità del liceo di via Carducci. Sasà monta dietro e comincia il carosello senza meta nel perimetro attorno a Toledo, ogni tanto un’impennata e lo slalom tra macchine, passanti e vigili urbani, del tutto disinteressati all’esibizione.
S’avvicina l’ora di uscita dalle scuole e Peppe punta su piazza del Gesù. Dà di gomito all’amico ogni volta che incrociano una ragazza procace, sfrontata per l’aria tiepida che asciuga finalmente le ossa, contagiata dall’allegria generale per la primavera che incalza. Fischia, Peppe, con pollice e indice cacciando ficcati in bocca sulla lingua arrotolata. Stavolta a voltarsi è proprio Lucia. Il motorino la sfiora e Sasà le sfila di sotto il braccio il libro di storia, rivestito con una carta vezzosa a pois. Potrebbe essere l’inizio delle solite ostilità, ma lo scenario della competizione è improvvisamente diverso. Sasà si gira per godersi la faccia stupita di Lucia e incontra uno sguardo appena ironico, su un viso dolce, di colpo più maturo. Salta giù dal motorino e sale in cima alla scala di dove si accede alla Chiesa del Gesù. Di lì può seguire la ragazza che avanza a fatica nel serpente di macchine e pedoni, stretti nell’imbuto che il portale di Santa Chiara incontra all’uscita della piazza. Anche Lucia cerca con gli occhi Sasà e c’è un’emozione nuova nella speranza di rivederlo qui, lontano dal vicolo che unisce la loro infanzia e dove tra poco si ritroveranno. Le piacciono quei jeans nuovi, la testa nera che brilla al sole e il vezzo di sorridere, un po’ canzonatorio. Si dà un’occhiata, fingendo di essere attratta dalla bigiotteria di un piccolo negozio arredato con grandi specchi azzurri. Non si dispiace, stamattina. Sasà è adeguatamente infastidito dall’intraprendenza di un paio di studenti che incrociando Lucia mimano l’incertezza sulla direzione da prendere e la costringono a cambiare rotta due o tre volte di seguito, giusto il tempo per dire chissà quale spiritosaggine. Scende i gradini e facendosi scudo di un autobus che ingombra quasi tutta la strada si porta alle spalle della ragazza, la segue per alcuni metri, l’affianca e la prende sottobraccio proprio come fanno tanti studenti all’uscita di scuola con le loro ragazze.
E lì prende corpo una piccola storia di affetti non previsti, davanti all’istituto magistrale e nei dintorni di piazza del Gesù, dov’è il «Little Bar» e il cinema «Modernissimo» che apre anche al mattino, durante le ore di scuola marinate dagli studenti per brevi furti di intimità. Sasà ha preso ha disertare il lavoro e contemporaneamente s’è messo a frequentare Peppe che in un modo o nell’altro riesce a procurarsi del denaro. In principio gli ha fatto solo sa partner in certe commissioni in città. In pratica ha badato al motorino mentre l’amico andava su, al quinto piano di un palazzo malandato di via Tribunali. Al rientro sui “Quartieri” un rapido scambio con ragazzi e ragazze venuti chissà da dove: una, due bustine argentate per un mazzetto di banconote. In un pomeriggio di magra Peppe va giù lungo la ripida discesa che incrocia a metà la via Pignasecca, in vista dell’ultimo tratto da cui si accede alla piazza Carità. Prima che la discesa sia finita, frena e cede a Sasà il posto di guida.
 “Guarda, guarda bene. Hai visto che traffico. E se c’è il traffico che cosa succede? Che le macchine si fermano. E chi c’è nelle macchine a quest’ora? Le donne. E fa caldo, i finestrini sono aperti, le borse a portata di mano, i gioielli pure. Tu fai come ti dico, quando ti batto sulla spalla passa a fianco della macchina ferma. Attento Sasà. Se grido vai, tu fila come un razzo. Capito?” La testa del ragazzo batte dentro come un tam-tam e uno strano pensiero gli fa aumentare ansie e paura. Una cosa è giocare allo slalom tra le macchine e un’altra è schizzare via con qualcuno che ti rincorre.
“Guarda, guarda bene. Hai visto che traffico. E se c’è il traffico che cosa succede? Che le macchine si fermano. E chi c’è nelle macchine a quest’ora? Le donne. E fa caldo, i finestrini sono aperti, le borse a portata di mano, i gioielli pure. Tu fai come ti dico, quando ti batto sulla spalla passa a fianco della macchina ferma. Attento Sasà. Se grido vai, tu fila come un razzo. Capito?” La testa del ragazzo batte dentro come un tam-tam e uno strano pensiero gli fa aumentare ansie e paura. Una cosa è giocare allo slalom tra le macchine e un’altra è schizzare via con qualcuno che ti rincorre.
“Vai Sasà… e vai…”
Salvatore tarda qualche secondo a partire e la ragazza afferra il braccio di Peppe con tutte e due le mani. Quando si decide a smanettare, il motorino compie un balzo e un polso della ragazza picchia con violenza contro la carrozzeria della Renault, appena più su del finestrino aperto per tre quarti della corsa. Il braccio si frattura e il dolore si accompagna a un urlo. Due «falchi» della squadra antiscippo partono a tutto gas con le Kawasaki truccate e bloccano Sasà dopo non più di centocinquanta metri. Peppe è saltato a terra appena si è reso conto dell’inseguimento e corre come un pazzo fino alla bottega di Aniello. La sartoria comunica con il cortile interno del palazzo e di lì con un vicolo parallelo, inaccessibile grazie al barbacane eretto al tempo del terremoto.
Gegé De Simone, ispettore di polizia di lungo corso si è fatto le ossa nel giulianese dove con i camorristi certo non si va per il sottile. Quando porta Sasà davanti al commissario conosce in anticipo il seguito. Ammaturo squadra il ragazzo con calma e con un tono di voce per nulla alterato gli fa:
“Figlio di puttana, chi c’era con te?”
Il ragazzo abbassa la testa, la bocca chiusa. Il ceffone arriva improvviso, pesante.
“Gong… secondo round. Con chi stavi fetente?”
Il nome salta fuori e il maresciallo De Simone affronta a colpo sicuro il dedalo dei Quartieri Spagnoli. Peppe finisce in manette.
* * *
Lucia sa che il suo ragazzo è sempre con quel balordo di Peppe e gli ha strappato la promessa di cambiare compagnia. Difendersi dal rischio di essere coinvolti negli «affari» dei Quartieri è un’impresa per chi è nato qui e c’è un’età a rischio, proprio quella di Sasà. Lo scippo costa al ragazzo la denuncia al tribunale dei minori e niente di più solo perché ha collaborato.
Il prezzo più duro è l’indifferenza di Lucia che non manda giù il marchio di vigliacco appiccicato alla pelle di Salvatore dalla gente dei Quartieri che Salvatore diserta fin che può.. Comincia a frequentare Forcella e finisce per sfiorare il mondo dei disgraziati che si mettono in fila per entrare a far parte della Famiglia. Il re della cosca è dietro le sbarre, il suo mito no. Vincenzo “’o sparviero” ha lasciato dietro di sé il carisma di boss padrone del quartiere e non ha ripudiato il clichet di guappo, ereditato dal padre. Prima di finire a Poggioreale, con una sfilza di accuse buone per almeno tre condanne all’ergastolo, ha recitato con capacità di attore consumato il ruolo di leader, prodigo con i sudditi fedeli, giustiziere implacabile con chi prova a contrastarlo..
Spesso dall’attico di Forcella dov’è il suo regno, è sceso in pompa magna tra i suoi, in doppiopetto blu, rigato, una rosa rossa all’occhiello, il seguito a fargli corteo. Ha sfidato in pieno giorno quel rompi-coglioni di Ammaturo e tutta la squadra mobile, i carabinieri, per stare in mezzo al popolo e impartire con studiata teatralità benevolenza e cazziate, minacce e promesse. Bello, come può esserlo solo uno scugnizzo di Gemito cresciuto nella fierezza del comando, Vincenzo ha lineamenti forti ma regolari. Sempre abbronzato, perché il verde intenso degli occhi abbia risalto, va fiero di una pagina doppia articolo che gli ha dedicato un settimanale femminile, corredata di molte foto: “Bello, elegante, spavaldo. Il re di Forcella è adorato dalle donne, venerato dai luogotenenti, rispettato come un dio dalla sua gente”.
Vincenzo evade dal carcere di Ascoli Piceno grazie a interessate complicità politiche. Forcella lo accoglie come un re. Il boss, complice tutto il quartiere, sfida spavaldo la polizia e non dirada le apparizioni nei vicoli, a beneficio dei fans.
Sasà si è messo in testa di avvicinare ‘o sparviero durante una delle udienze che concede al “popolo” e da molte mattine va avanti e indietro tra le bancarelle di sigarette di contrabbando, l’esposizione di polipi vivi e pesci scongelati in acqua di mare stagnante, i venditori ambulanti di filmini porno e pistole, gli scippatori che bighellonano in attesa di un’altra giornata di razzie..
Vincenzo ha un look diverso stamattina. Casual d’autore, mocassini inglesi e nella cintura di Valentino un cannone calibro 45, a portata della mano destra.
“Sparviero…sparviero”
“E chi è stu mezz’ommo?”
Non c’è intenzione dispregiativa nell’ironica attenzione che Vincenzo presta al ragazzino ma per Sasà non conta. Per lui è un insulto che si ripete e l’accompagna come un marchio da cui forse non riuscirà a liberarsi.
Ammaturo stavolta ha fatto sul serio. Una soffiata gli ha dato la certezza che ‘o sparviero è in tana. Trecento uomini in assetto di guerra, tutte le pantere disponibili a bloccare ogni varco d’uscita, le autoblinde con i tiratori che si sporgono dalle torrette, fucili di precisione imbracciati, e a picco sul dedalo di Forcella un paio di elicotteri. Vincenzo sale a perdifiato le scale del suo palazzo e con un balzo salta sul tetto dell’edificio di fronte, seguito da due guardaspalle. Ancora un passaggio per terrazzi adiacenti, poi la discesa precipitosa e giù il lasciapassare di un cancello che immette sul vico Zurlo, forse fuori dell’accerchiamento.
Vincenzo oltrepassa il cancello, pistola in pugno. Di fronte, di lato, alle spalle, gli uomini di Ammaturo l’aspettano con i mitra spianati.
La colt gli scivola dalla mano e fa un accidenti di rumore nell’impatto con il selciato. Non ne fa lo scatto delle manette ai polsi. Arrivano agenti da tutte le parti e ‘o sparviero è costretto a camminare nel suo regno tra due ali di poliziotti, con Ammaturo che apre il corteo. Uno sfregio che schianta il mito del boss.
Sasà è in prima fila e quando il re di Forcella gli passa davanti, sconfitto, gli grida “mezz’ommo” e scappa via. Anche da Forcella.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 8 Gennaio 2017
LUANA
di Luciano Scateni
Si sentono esclusi, emarginati perché periferia senza qualità. Ogni sporadico evento che rompe la monotonia di una solitudine misera è come manna dal cielo, specialmente per i giovani che sono rimasti e per gli anziani, esclusi da tutto, rassegnati a trascorrere mattinate intere sulle panchine della villa comunale a raccontarsi il passato, a sfidarsi in partite di scopone seguite da altri vecchi che commentano le giocate.
Il 10 di agosto è una giornata speciale. Arriva Luana.
Sotto il tendone a strisce gialle e blu, alla luce del giorno restano odori di umanità, rifiuti e crepe annerite del pavimento, vernici erose e più volte sovrapposte, l’uno strato sull’altro, quel tanto di miserrimo che l’incuria accumula nel tempo. Gravano nell’aria il fumo denso, stagnante, di sigarette e lo sgradevole tanfo di sudori, l’eco appena spenta di grida e applausi e fischi del vociare caciaresco nell’intervallo tra un numero e l’altro, il ton-ton dei piedi battuti sul pavimento di legno, le manate sulla schiena di seggiole ricoperte di velluto sdrucito
Alla base di un pilone, di quelli che sostengono la tenda, la scopa di saggina ha radunato lattine vuote, deformate e buste accartocciate di patatine, cicche di sigarette, cartacce, bucce di semini e polvere, la carcassa di uno scarafaggio, una copia gualcita della “Gazzetta”, biglietti d’ingresso della sera prima, un guanto di pelle.
Alla luce del giorno, da varchi che lembi del telone sollevato aprono tutt’attorno al Palatenda, entra una luce livida, rara da queste parti. Cielo da neve dicono i vecchi, ma è più facile che da questo cielo venga giù acqua. Non è latitudine per nevicate e quando di rado fiocca, fino a imbiancare i tetti delle automobili, in qualche parte della città alta i ragazzi disertano la scuola e ingaggiano battaglie con palle di neve, qualcuna indirizzata a passanti indispettiti. Il traffico urbano si riduce a poche auto di temerari irriducibili, la gente ha un’aria stupefatta.
La Mercedes supera a fatica il lieve dosso provocato artificialmente perché incanali l’acqua piovana in direzione della strada ed eviti di allagare il tendone. Walter ringrazia il padreterno per avercela fatta ancora una volta a superare stress e mancanza di sonno, pasti disordinati, orari sballati, un’ulcera contrastata malamente con cucchiaiate di bicarbonato dopo ogni pasto.
Ora deve digerire i seicentocinquanta chilometri percorsi senza soste, per metà quando l’alba era ancora lontana: nebbia per lunghi tratti e una dura battaglia per non chiudere gli occhi, una gran voglia di smetterla con questa vita da nomade senza dimora, il dividersi frenetico tra serate, sale d’incisione, studi cinematografica, pranzi e cene con giornalisti specializzati e nulla per il privato.
Si ricomincia. Stasera il circo del sesso è di nuovo di scena e apre il sipario per due volte a un paio di migliaia di spettatori allupati, beffardi, psicotici.
Le solite cose. Prendono posto nelle prime file una decina di poderosi buttafuori, spalle larghe e manacce adatte a spintonare, trattenere, arpionare. Walter ne conosce una parte, agli altri spiega come tenere a bada i più scalmanati, con decisione, ma senza provocare tumulti. Un caffe, almeno un buon caffè ristretto, prima di mettere mano alle mille questioni che precedono ogni tappa del pomo tour. C’è la SIAE da pagare e la consegna degli omaggi al commissariato di polizia, l’appuntamento con la RAI che ha chiesto di girare lo show per il settimanale di Rai3 e qualche perplessità per il taglio dello speciale destinato a una rete che potrebbe dissacrare questo tipo di spettacolo.
E’ arrivato il “Transit” con gli addobbi di scena, l’impianto stereo, i nastri con le registrazioni dei pezzi di Luana, Monica e Mehary, le tre pornostar di turno.
Bionda, imponente, due gambe lunghissime e seni che il bustino dell’abito scollato proprio non ce la fa a contenere, Luana ha l’aria stanca e sotto gli occhi, enfatizzati da ciglia finte annerite con dosi generose di mascara, occhiaie profonde. Due solchi blu.
È l’anziana del team, non solo anagraficamente. Il suo è un curriculum di tutto rispetto. Qualche fotoromanzo, per cominciare quando aveva appena quindici anni, i primi film hard, che ora sembrano ai fan innocue trasgressioni al puritanesimo da ancelle di Maria. Crescono progressivamente il successo e la popolarità, notificata dai poster che tappezzano le cabine dei camionisti, arrivano il debutto in teatro e la prima denuncia per offesa al pudore, la condanna sospesa, gli strali di moralisti, lettere di insulti. Una in particolare, scritta a stampatello, anonima è piena dì ingiurie, di volgarità oltraggiose, nella busta il disegno approssimativo di una donna nuda avvolta dalle fiamme. Dell’inferno?
Infine il sodalizio con Walter, un meridionale vivace, dotato di intuito, intraprendente, con il bernoccolo per far soldi. Il lavoro diventa frenetico. La parte più faticosa è proprio quella degli spettacoli che s’incastrano logisticamente con difficoltà e costringono la compagnia a trasferimenti faticosi, da una parte all’altra dell’Italia. Meglio le fotografie e i film. Il ciac a Roma, per non più di due o tre settimane e altri sette giorni se ne vanno negli studi fotografici. Una pausa di tutto riposo.
Luana scende per ultima dalla Mercedes. Conosce la tenda, il paese, il genere di pubblico che stasera riempirà il teatro, le parolacce, le provocazioni, gli spaghetti ai frutti di mare del Sarago, unico ristorante del posto, un ridicolo spasimante che non perde uno show e ogni volta le fa trovare in albergo un gran fascio di rose, il biglietto con rozze frasi da innamorato.
 Alla luce del giorno Luana somiglia a una delle tante femmine procaci di questa città piena di donne appariscenti, per lo più abbondanti di seno, vistose, platinate.
Alla luce del giorno Luana somiglia a una delle tante femmine procaci di questa città piena di donne appariscenti, per lo più abbondanti di seno, vistose, platinate.
Il circo del sesso è appunto simile a un circo equestre ma meno stabile nelle piazze che tocca, chiamato da imprenditori locali che sanno di fare il tutto esaurito. Anziché esibire clown e trapezisti, elefanti e cavalli ammaestrati, mostra glutei e seni, il sesso in diretta con un ciclo completa di offerte pomo.
Eroine dei cinema per adulti, le officianti hanno imparato che nelle sale a luci rosse non c’è azzardo erotico proibito.
Lo show ha schemi elementari, scenografie inesistenti, rozze ed elementari sceneggiature. La musica è cornice indipendente dello spettacolo e ripropone le classiche colonne sonore del porno. Serve sicuramente a rimbombare nello stomaco degli spettatori e aumenta il pathos di luci intriganti, di performance sempre più spregiudicate. Dietro il palco, nell’angusto passaggio compreso tra il fondale e la tenda, un buio e stretto sentiero di assi sconnesse precede i camerini di Luana e delle compagne di lavoro, bugigattoli senza porte dove indossano i ridottissimi costumi di scena sotto lo sguardo degli addetti ai lavori. Considerato il genere di spettacolo non è davvero un problema. Piuttosto complicato è il trucco, sotto la luce incerta di una lampadina sorretta da un filo volante, attorcigliato un paio di volte attorno a un chiodo. Mehary, in difficoltà, è assistita da Walter che nella circostanza deve assolvere anche al compito di truccatore. Nel bel mezzo di una natica, porzione del corpo che tra qualche minuto sarà esposta e in luce, una rosa di brufoli viene coperta da fard e cipria. Luana impreca contro la vita da cani complicata da difficoltà supplementari, come l’impresa di orientare lo specchio per catturare la luce di una lampadina al risparmio da 60 candele e contro uno sbuffo di polvere che ha imbiancato il manto rosso punteggiato di perline scintillanti.
Fuori del teatro tenda si accalcano spettatori sfaccendati che sperano di entrare clandestinamente. Nell’attesa commentano con battute non proprio da educande le audaci locandine delle dive del nudo.
I buttafuori faticano a trattenere quanti premono per entrare. Del ritardo è responsabile la RAI, che prima dello show ha l’esigenza di filmare ogni contorno dello spettacolo, a dispetto delle proteste di Mehary che non ha concluso il restauro della natica ripreso dalla telecamera. Le interpreta Luana che sfida l’operatore con una smorfia e poi oscura l’obiettivo con una mano. Walter ha istruito le ragazze per le interviste. Le tre star hanno imparato a spacciare la pornografia per crociata di liberazione dai tabù del sesso, messaggi di pace, libertà di usare il corpo come l’istinto suggerisce. “Denunce?” “Certo, un ambiguo atto di repressione fondato sul cosiddetto senso comune del pudore”. Luana e le altre declamano la loro filosofia di tolleranza per il genere che rappresentano con voce soave e dolci, larghi, languidi sorrisi e un articolato uso dei diminutivi: coccolina, miciottina, bambolina. La Rai finge di credere che sia una cosa seria. La telecamera sgombra il campo e si trasferisce all’ingresso, dove la ressa sta per diventare tumulto. Il flash provoca esibizionismi e intolleranze. Chi è venuto al pornoshow dichiarando un impegno imprevisto e straordinario di lavoro ha di che nascondersi, volta le spalle all’obiettivo, trova riparo dietro la mole di compagni di avventura che non devono giustificare nulla a mogli e fidanzate ignare, a colleghi d’ufficio e amici moralisti.
“Scusi, lei è una abitudinario o un neofita?” Il vecchietto guarda dritto nella telecamera e vince l’emozione con una risatina isterica che scopre dentacci neri e smozzicati.
“Non me ne perdo nessuno”
“Chi è la più bella… o come direbbe lei, la più…?
“Bbona, eh, eh… bbona. Luana è la più bbona di tutte”
“Siamo tra uomini, dica pure: ha di fronte Luana, che fa?”
“ Eh che faccio: me la mangio, ecco che faccio”
“Non ha paura che alla sua età il sangue vada alla testa e le faccia qualche brutto scherzo?”
“Ma quale scherzo, io me la mangio. –
“Dopo lo spettacolo, se è vero che si eccita, cosa fa?”
“Figlio mio e che devo fare. Purtroppo non ho più la mia compagna”
C’è un avvocato in sala. Chiede di non essere inquadrato, poi, incoraggiato dagli amici, si piazza impettito davanti alla telecamera.
“Avvocato, che cosa si aspetta dallo show?”
“Vede, caro amico, non è la prima volta che vengo a uno spettacolo del genere. Perché sono qui? C’è un lato artistico che mi interessa… il lato artistico è… il lato che mi interessa”
Le prime file della platea sono occupate dal manipolo di ragazzi di periferia che per primi sono arrivati al tendone e con un assalto da marines si sono avventati sulle poltroncine proprio sotto il palco. È di li che si può aspirare a vincere il premio che le star metteranno in palio durante l’esibizione di farsi metter le mani addosso..
Luana ha finito la “Merit” giusto in tempo per dare il cambio a Monica, che ha riscaldato l’ambiente giocando con una candeletta luminosa che sostituisce platealmente il fallo in esplicite penetrazioni a cui corrispondono cori entusiastici dalla platea.
Parte la musica, una musica rock, di un rock molto soft. Il cono di luce buca la nuvola di fumo che ha saturato la tenda e spazia senza apparenti obiettivi sul palco ma si ferma sulla gabbia dove Mehary si dimena mimando esplicite masturbazioni, in adorazione di un manichino vagamente somigliante a un divo della musica pop.
Luana sbuca dall’ombra e avanza ancheggiando finché lo spot la illumina con lama di un “occhio di bue” mentre si gira, spalle al pubblico e piegandosi sul busto espone uno degli oggetti del desiderio a cui i fans dedicano apprezzamenti sonori molto coloriti.
Vola via il gilet, che comunque ha finora coperto a stento i grandi seni e cominciano i segni d’irrequietezza delle prime file.
I più intraprendenti invocano da Luana un cenno che dia via libera per balzare sul palco, ma non è il momento e i buttafuori li respingono con decisione.
La star compie per intero il rito della provocazione e lo intervalla con piccanti duetti che coinvolgono il pubblico con crescente partecipazione. Infine è il momento che i duemila hanno aspettato trastullandosi con le performances di Monica e Mehary: Luana cammina fino al margine del palco e finalmente punta l’indice sugli scatenati fans.
“Chi di voi vuole raggiungere Luana? Tu, o tu, vediamo chi…”
Un ragazzo dalla faccia rubizza, grassoccio e un po’ goffo, si issa in piedi sui braccioli della poltroncina e agita le braccia per farsi notare.
Ci riesce e il cordone dei buttafuori lascia aperto un varco. Luana gli afferra i capelli e attira a sé il ragazzo che affonda la testa tra i suoi seni, prima di respingerlo con decisione. La star riagguanta il frastornato ragazzotto e stavolta gli consente di usare le mani, che la frugano fin dove è possibile.
Il tifo del pubblico raggiunge sonorità da stadio e l’ultimo atto sta per compiersi. La mano di Luana si posa sulla nuca del fortunato e preme la testa sul seno nudo.
Gli agenti di servizio sono a disagio. Dovrebbero intervenire, secondo le disposizioni che regolano la tutela della pubblica morale. E’ che sono della stessa pasta di questi ragazzi di periferia, eccitati quanto loro. La differenza è nel contegno che sono costretti a tenere per non disonorare la divisa.
L’avvocato s’aggira con improbabile disinvoltura nel parcheggio, dove la “Mercedes” di Walter ha già il diesel avviato. Ammicca al giornalista della RAI che aspetta l’esodo delle pornostar per concludere le riprese.
“Non c’è problema. Un milioncino e passa la paura. Parola mia, vale proprio la pena. Sono donne di classe, parola mia”.
Nel sottopassaggio del metrò due giovanotti sovreccitati bloccano una ragazza. Uno dei due la tappa la bocca con una manaccia, l’altro infila una mano sotto la gonna, con l’altra le strappa la camicetta.
L’assalto non va oltre solo per caso. Un ferroviere di notevole stazza mette in fuga i due balordi. Il sipario scende pietoso a oscurare uno sprazzo di ordinaria inciviltà.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 1 Gennaio 2017
LE CORTINE
di Luciano Scateni
Le cortine, di ferro o solo virtuali, ma non meno ostili e impermeabili, i muri. Uno, storico, eretto per spaccare in due un popolo, prima della separazione avvelenato dalla follia nazista di Hitler; i muri della xenofobia, dell’odio di razza, rappresentazione emblematica di egoismi che dal particolare di un uomo contro un altro uomo si espandono e invadono intere collettività. Il male, esteso e globalmente identico nelle forme e nella sostanza, genera il tragico bilancio permanente di decine di guerre in luoghi diversi della Terra, di miserie estreme, di odio profondo che si sostanzia in contrapposizioni apparentemente ideologiche, ma generate da obiettivi di rapina delle risorse altrui e mascherata da guerre di religione. Allo scontro tra blocchi di potere, tra dominatori dei due emisferi, si ascrive anche la storia di Sonja e Ivan, il loro difficile sogno di sentirsi cittadini del mondo.
SONJA
La base del masso marmoreo, venato di rosso ruggine e di verde primavera, è unita alla lastra che chiude la vetta della collina per un sol punto, ancora risparmiato da millenni di tramontana che per almeno tre mesi l’anno soffia impetuosa, incuneandosi nella gola tra i monti Minsk e Krainek.
Lo chiamano il “blocco magico”.
Pazienti, di una pazienza euforica, generata dall’impeto di forti sequenze emotive, Ivan e Sonja hanno inciso il marmo, lei con la forcina, usata per scrivere i loro nomi uniti con la & commerciale, ingentilita da fantasiosi ghirigori. É quasi scomparso il velo rosso che Sonja ha tracciato con la matita per le labbra nei solchi scolpiti.
Ivan gioca nel ruolo di guardia nell’Armata Rossa e in nazionale, al fianco di Sabonis, imperatore lituano del basket europeo. È molto amico del gigante biondo. Divide con lui la stanza d’albergo quando sono in trasferta e la cabina del vagone letto, la stessa fila di poltrone in aereo, ha con lui in comune la passione per gli scacchi, i jeans e le attrici francesi, il buon vino italiano, la fotografia, il basket moderno, nella versione interpretata da Abdul Jabbar, Magic Johnson e Larry Bird. Ivan ha coscienza di essere un giocatore da laboratorio, sull’impianto di un mediocre talento naturale.
Il jumbo compie un atterraggio morbido sulla pista 3 del “Kennedy”, l’applauso al comandante è meritato. Il pilota con migliaia di ore di volo porta l’aereo incontro alla fantastica aerostazione newyorkese, simbolo del mondo occidentale e di mille suggestioni enfatizzate dalle informazioni indirette che Ivan e i suoi compagni hanno raccolto in mezzo mondo a contatto con i giocatori delle squadre dell’ovest.
Sonja ha salutato il compagno all’aeroporto di Mosca. Lavora al ministero della cultura, ha vent’anni e una voglia inconfessata di seguire Ivan in quella parte del mondo di cui conosce appena quanto trapela dalla stampa estera che circola al ministero o da qualche informazione di prima mano riferita dai funzionari di ritorno dagli Stati Uniti.
Sono venticinquemila gli spettatori accorsi per vedere all’opera i russi e per soddisfare l’orgoglio nazionalista: la selezione del dream team ce la mette tutta e ha un buon gioco, anche perché la nazionale sovietica è solo all’inizio della preparazione.
Ivan ha disputato la migliore partita della sua carriera, Sabonis è lontanissimo dalla migliore condizione atletica.
La Nbc è collegata in diretta con il palazzo dello sport e il telecronista Alan Calleway cattura Ivan prima che sparisca nel sottopassaggio.
Il giocatore strappa il microfono dalle mani del celebre commentatore dell’emittente americana e dichiara a quindici milioni di telespettatori sbigottiti di appellarsi alla democrazia degli Stati Uniti perché gli sia concesso l’asilo politico.
* * *
Sonja ha superato se stessa e ha convinto un paio di colleghe a rinunciare in suo favore al viaggio negli Stati Uniti, al seguito della delegazione invitata dalla Princeton University. L’incontro fra Reagan e Gorbaciov ha di questi corollari positivi. Tema dell’incontro è la cultura contadina dell’Unione Sovietica, prima e dopo la rivoluzione d’ottobre.
L’invito coincide con la tournée dei cestisti russi e sposta l’asse dell’interscambio sul terreno della cultura oltre che dello sport.
Sonja guarda continuamente l’orologio: 19 e 25… 19 e 37…
Gregoari Martinenko osserva l’uditorio nella sala conferenze dell’università di Princeton con qualche preoccupazione…”Potranno mai capire processi così lontani dalla loro mentalità, dalla loro storia?”.
Le telecamere della Nbc indugiano sul viso, teso, un po’ pallido, e sulle mani che assemblano di continuano le cartelline dattiloscritte. Sonja si alza all’improvviso dal suo posto letto, afferma il microfono e si mette di fronte all’obiettivo della camera accesa. Pronuncia, parola per parola, la stessa frase che Ivan ha detto a molte miglia di distanza.
All’ambasciata sovietica si vedono in giro facce da funerale, è snervante l’attesa di risposte da Mosca e dal Dipartimento di Stato americano.
Le rispettive diplomazie non sanno davvero come risolvere la questione che comunque si osservi comporta non pochi rischi di offuscare il clima distensivo tra le due grandi potenze dopo mesi e mesi di laboriose trattative. Washington deve sopportare il maggior imbarazzo. Dovesse concedere asilo ai due giovani, si alienerebbe Mosca e forse l’opinione pubblica sovietica; se consegnasse Ivan e Sonja ai russi, metterebbe in discussione l’immagine libertaria degli Stati Uniti.
Intanto alla Nbc le centraliniste non riescono a fronteggiare le richieste degli utenti che vogliono conoscere gli sviluppi dell’affare e che protestano per il black-out.
La soluzione, contrastatissima, arriva dopo quasi quarantotto ore di discussioni sottili, a tratti animate.
Valeri Osimov ha pescato negli archivi dei servizi russi il caso di una coppia americana che circa un anno prima ha consegnato all’ambasciatore sovietico la domanda di emigrazione in Russia. La faccenda è stata accuratamente nascosta per non turbare i rapporti fra i due Paesi e forse è venuto il momento di riportarla in evidenza. Uno scambio tra i Norton e i giovani russi potrebbe essere esibito come segnale del nuovo corso imboccato dalle rispettive diplomazie
A Mosca sono interessati a uscire dal disagio con questo singolare compromesso, mentre Washington teme che gli americani non accettino l’idea di due compatrioti che scelgono l’Est, ma Arthur Mitchell, esponente di rilievo della CIA, pensa che l’alternativa è possibile.
È ancora la Nbc a godere del privilegio dell’esclusiva per un evento che s’annuncia spettacolare e coinvolgente dal punto di vista emotivo. L’aeroporto Kennedy è come una fortezza e brulica di militari, di agenti in borghese dei servizi segreti. Ogni varco è controllato come l’accesso a Fort Knox. I due aerei USA e Urss sono affiancati sul terminale della pista numero uno, gli equipaggi si schierano ai piedi delle scalette, in attesa dello storico avvenimento.
Ivan e Sonja sono stati informati dal Presidente in persona, i Norton hanno ricevuto la notizia dall’ambasciatore sovietico. Per i giovani russi, ammessi come rifugiati politici, la destinazione momentanea è un college di San Francisco, la coppia americana è attesa a Mosca.
Praticamente circondati da guardie del corpo, gli uni e gli altri percorrono a piedi il tratto che separa l’aerostazione dalla pedana posta al centro fra i due aerei, dove sono in attesa le autorità americane e sovietiche.
Tiratori scelti sono appostati ovunque e le telecamere seguono alternativamente il piccolo corteo e le delegazioni ufficiali.
A un tratto, da un lato della pista, compare la sagoma d’un elicottero e per troppi secondi i servizi di sicurezza pensano alla protezione dal cielo dei protagonisti dello storico evento.
Quando qualcuno comincia a sospettare di quel volo radente è troppo tardi: dall’elicottero parte un missile che colpisce il gruppo dei quattro, alcuni degli accompagnatori.
È caos in un attimo. Accorrono militari e poliziotti, automezzi dei pompieri, ambulanze. La micidiale esplosione ha provocato la morte di dieci persone. Per Ivan, Jack ed Evelyn, non c’è niente da fare. Sonja respira ancora ed è trasportata d’urgenza in ospedale, ma muore prima di arrivare sul tavolo operatorio.
L’elicottero vira bruscamente e si dirige verso un piccolo aeroporto in disuso, a dodici chilometri dal Kennedy. Dopo un paio di minuti un’esplosione a bordo e il veloce Augusta, colpito a sua volta da un missile, si disintegra.
Arthur Mitchell è ricevuto dal presidente. Gli comunica che è andato tutto secondo le previsioni. Il mercenario pagato per mettere in atto la strage è saltato in aria con i suoi uomini e non c’è da nessuna parte la minima traccia degli accordi intercorsi. Non resta che gestire attentamente i contatti con i mass-media.
In casa del killer a pagamento la CIA trova un documento, una cosiddetta risoluzione, in cui si annuncia la strage contro la spartizione del mondo di cui sono protagonisti Reagan e Gorbaciov con la finta intesa sul disarmo.
Karina Suslova sale sulla collina che un giorno Ivan le ha fatto conoscere e depone ai piedi del masso di marmo un piccolo fascio di fiori di campo.
Neppure il suo ragazzo ce l’ha fatta a concludere il sogno ereditato.
Nella foto accanto, giocatori di basket russi, il più alto è Sabonis, citato nel racconto.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Natale, Domenica 25 dicembre
‘O REY
di Luciano Scateni
Il mito, nella storia del mondo antico, è indelebile, scritto a caratteri cubitali nella memoria, enfatizzato da successive sovrapposizioni di leggende suggestive. L’era moderna ne costruisce anche troppi, esaltati dal sistema dei media, posti sul piedistallo della popolarità e bruscamente detronizzati, riposti negli angoli bui dei ricordi. Succede ai politici assurti agli onori del potere istituzionale, agli artisti, ad attori, a splendide donne incoronate miss e non meno ai calciatori, con rare eccezioni per numeri uno che fanno la storia senza età dello sport più popolare del mondo. Succede che un asso conclamato imbocchi il sentiero del tramonto e non ne tenga conto, che tardi a dismettere la divisa indossata nei momenti più alti della carriera. Succede che chi lo ha esaltato gli mostri il pollice in giù della condanna a morire come mito. Senza pietà.
È quel che si dice un brevilineo. Appena 39 il numero di scarpe, basso il baricentro, ‘o rey non può certo definirsi un fusto e anzi lo scompenso di crescita muscolare, tutto sbilanciato nel tratto fra l’addome e i piedi, lo fa tozzo, tracagnotto ed esposto a repentini sbalzi di peso, nemmeno consistenti ma sufficienti ad appesantirlo di colpo. È nato alla periferia di Tucumàn, ai piedi della Ande. La città, circa trecentomila abitanti, ha vissuto episodi decisivi nella lotta per l’indipendenza dell’Argentina e vanta un qualche orgoglio per questa sua nobile storia. Sono principalmente due le ragioni di una sua buona fama. L’una è di natura economica, poiché Tucumàn è il centro di produzione di zucchero più importante del sud America. L’altra di deve a un certificato di nascita, custodito in municipio come una reliqua. Conferma che Carlos, Joaquin, Roberto, asso degli assi della pedata è nato qui, nella via Velasquez, al profetico numero 10. Mamma Juanita ne ha fatti sette di figli. Quattro sono femmine, le prime due, la quarta e la settima. I maschi, sono distanziati l’uno dall’altro di tre, cinque e sei anni. Tutti somigliano al padre, uomo laborioso, ignorante, sanguigno. Molto simpatico. A Tucumàn si lavora lo zucchero e si gioca con el balon nelle stradine polverose, dove i bambini imparano prima a calciare che a camminare. Gli scolari s’impegnano in animose partite ovunque si apra uno spazio pianeggiante da trasformare in campo da gioco grazie a pile precarie di libri di scuola sistemate in terra, a segnare i limiti delle due porte. Interminabili discussioni precedono l’accordo sulla scelta del campo e della porta in leggera discesa ritenuta più facile da violare, dove ognuno dei Pelé in sedicesimo spera di far passare un pallone di plastica pesante comprato con i soldi di una sudatissima colletta.
Lo stadio improvvisato confina con una serie di collinette innaturali, cresciute un po’ per volta con i materiali di scavo di un cantiere edilizio, ricoperti alla meglio con un sottile strato di terreno.
Stanno lì da tempo, tanto che una discreta varietà di piante selvatiche è venuta su fino a nascondere alla vista il complesso delle palazzine costruite in cooperativa dai dipendenti dello zuccherificio Santiago che occupa circa duecento operai.
El senior Pereira è diretto proprio a una di queste case, tutte usuali e di aspetto cadente benché finite da appena tre anni. E’ arrivato da Buenos Ajres dopo un viaggio faticoso, complicato dallo stop per uno sciopero senza preavviso, proclamato dal potente sindacato dei trasporti. In tasca ha la lettera del suo amico Marcel, Marcel De Souza, compagno di mille esaltanti battaglie sportive sui campi di mezzo mondo; ne sono stati tutti e due gratificati quando hanno meritato titoli cubitali sui giornali specializzati perché “fantastica copia del gol” con la maglia bianco-azzurra della nazionale. Marcel si è ritirato con discrezione, ma ha resistito poco a star fuori dal mondo del calcio che ha monopolizzato vent’anni di gioventù. E’ stato naturale rimanere nel giro, con il gusto di rivivere da spettatore l’atmosfera dell’agonismo domenicale e l’abitudine di annotare con meticolosità nomi e caratteristiche dei ragazzi di mezza Argentina. De Souza si è scoperto un talento naturale nell’intuire chi, fra tanti emuli di campioni affermati, ha stoffa per diventare un asso.
Pereira si è trovato sulla panchina quasi senza volerlo. La squadra del Rosario, di cui un tempo ha indossato la maglia, era in crisi tecnica e come si dice in gergo navigava nei bassifondi della classifica, nonostante il nome altisonante e il valore tecnico dei giocatori. La stampa aveva stilato la diagnosi: “Lo spogliatoio non va”. E così gli avevano affidato la terapia d’urto, da un giorno all’altro. Pereira aveva messo nell’impresa tutta l’esperienza di giocatore e il meglio degli allenatori conosciuti nel corso di una lunga carriera. Individuati rapidamente i focolai del malessere e portando dalla sua parte i leader della contestazione, aveva ripristinato nel collettivo il piacere di vincere.
É stato un grande giorno il 10 giugno del 1969, quando il prestigioso Boca Junior gli ha chiesto di firmare un contratto di tre anni, lasciandogli piena libertà delle scelte tecniche, i programmi di medio e lungo periodo e non s’è illuso di dormire sugli allori conquistati grazie a un club che non bada a spese. Ad ogni sosta del campionato e durante l’intervallo fra una stagione e l’altra, ha viaggiato in un lungo e in largo nel Paese a caccia di talenti. La lettera di Marcel promette bene e di Marcel c’è da fidarsi: “Vieni amico. Rivedrai te stesso in pantaloni corti. Ho tra le mani un vero fenomeno”.
Pereira costeggia lo spiazzo dove i ragazzini si danno un gran da fare per calciare il pallone con veemenza tipicamente infantile. Le evoluzioni dei piccoli calciatori replicano i gesti visti tante volte in televisione, sognati a occhi aperti. I loro volti sono congestionati per la foga di una competizione di cui parleranno a scuola il giorno dopo. Con spavalderia o dispetto, da vincitori o da vinti. Un ragazzino, fra tanti, comincia a incuriosire Pereira. È di statura inferiore ai compagni e un casco di riccioli neri gli copre completamente la fronte. Gli occhi, vivacissimi, non guardano quasi mai il pallone. Corre a testa alta, lo tocca con maestria e con entrambi i piedi, avanza sempre in verticale, punta deciso alla porta degli avversari. Salta gli intercettatori come birilli, con lievi spostamenti del corpo e finte, colpisce di testa con precisione e tempismo. Si chiama Carlos, Joaquin, Roberto. Pereira prova ad immaginarlo al pieno della maturità atletica, quando avrà completato lo sviluppo. Il film del futuro gli rimanda l’immagine di un campione completo, uomo squadra e goleador. Il ragazzino non vuol saperne di lasciare il campo e con un gesto brusco risponde picche all’invito di Pereira. Guizza sulla sinistra del proprio schieramento e invoca a gran voce il pallone. Il compagno fa partire un lancio teso, radente il terreno. Carlos, in corsa, mette il piede appena più avanti del corpo e il pallone, incontrandolo, s’impenna, acquista velocità supplementare, inganna il marcatore. Vola il ragazzo e raggiunge la palla prima che s’allarghi verso il limite laterale dello spiazzo. Poi stringe velocissimo, portando avanti el balon con tocchi di misura. Gli si fa incontro un avversario. Carlos finge una deviazione al centro, s’allarga di nuovo sulla sinistra, salta l’avversario. Con gli occhi fissi alla porta, s’accorge che il portierino è avanzato per tentare di chiudergli lo spazio utile. S’arresta di colpo, stoppa la palla, l’alza con la punta della scarpetta da ginnastica e fa partire un tiro morbido, a parabola, che scavalca il difensore per finire di precisione tra le due pile di libri.
Carlos se ne torna indietro senza un gesto d’esultanza e s’avvicina a Pereira. Il tecnico ora sa come si chiama, dove abita, quanti anni ha. Appena dodici, ma l’espressione è più matura e vivace. È proprio lui il fenomeno che Marcel ha scovato. Di qui prende il via la storia del campione dei campioni, di un mito che nessuno avrebbe immaginato potesse emulare la favola di Pelé.
L’asta di una bandiera si pianta nel terreno come un giavellotto, qualche centimetro più in là della linea laterale. Sembra un segnale convenuto. Piovono da ogni dove lattine vuote e buste di plastica appesantite con qualunque cosa capiti a portata di mano, altre bandiere, pacchi di sale che s’infrangono e disegnano al suolo rose bianche dai lunghi raggi, come una cucchiaiata di calce caduta dall’alto. Qualcuno maledice i campionati di calcio del ’90 a cui lo stadio ha sacrificato la pista d’atletica accorciando le distanze tra il pubblico e il rettangolo di gioco. Sul plexiglass che difende la panchina dei padroni di casa si arresta il volo di tre, quattro ombrelli e l’impresa è firmata dai “signori” della tribuna centrale.
Dalla curva «B» viene un fracasso apocalittico e qualche provocatorio sparo di razzi, resti di bengala ancora fumante approdano a un passo dalla rete della porta più vicina. La barriera dei fotografi si scompone in una fuga generale, disordinata.
Dai «distinti» un imponente coro di fischi investe l’aria umida di un pomeriggio tetro, con il cielo livido che minaccia pioggia. Non solo fischi: una moneta centra la testa di un guardalinee e il gesto teppistico dà il via al tiro al bersaglio.
Nel muro compatto di tifosi della curva «A» si apre all’improvviso uno squarcio. Un gruppetto di dissidenti è messo a tacere con la forza di convinzione di pugni e calci. Intervengono gli agenti di polizia con gran manganellate che fanno il vuoto per una decina di gradini.
L’arbitro deve fischiare come un ossesso per farsi consegnare il pallone. Corre ai bordi del campo dove il collaboratore colpito dalla moneta è soccorso da medici e infermieri. Arriva un barella e il sanguinante guardalinee è portato via dagli infermieri in stato confusionale. I giocatori sono nel cerchio del centro campo in attesa della decisione che li rispedirà al sicuro, negli spogliatoi.
Carlos ha un impeto di rabbia furiosa. Di colpo ha voglia di arrendersi alla violenza crudele di questa gente che per quasi novanta minuti l’ha insultato, fischiato, umiliato ed è proprio l’impotenza, l’impossibilità a contrastare le violenze subite a spingere l’orgoglio che gli ha consentito di non mollare prima, di non chiedere una pietosa sostituzione. Si sfila la maglietta, scura di sudore e negli occhi c’è odio per i facinorosi che continuano a beccarlo mentre s’avvia agli spogliatoi. È la sua via crucis, cento metri umilianti lo separano da quella buca infilata migliaia di volte con l’eccitazione di una vittoria appena conquistata, di trionfi personali, abbracci dei compagni, cori osannati della folla. Ai piedi della rampa che porta al lungo sottopassaggio e agli spogliatoi, si ferma e resta così per qualche secondo. Fin quando la mano di Miguel, amico fedele e consigliere, si poggia sulla spalla e lo spinge via, dove si spegne l’eco dei fischi e non arriva il sibilo perentorio dell’arbitro che mette fine alla partita..
Carlos infila gli abiti nel borsone da gioco e in tuta, ancora le scarpine ai piedi, porge le chiavi dell’Alfa e Miguel, si raggomitola sul sedile accanto a quello di guida, prega l’amico di far presto, di portarlo finalmente a casa. Fa cenno al poliziotto di lasciar perdere. Non ha più bisogno di scorta, di privilegi, di protezione. Ha solo voglia di silenzio e di immobilità.
Sembra che qualcuno, sul muro di recinzione della villa abbia tirato un frego sulla scritta “Carlos, più di un re”. Non è così. La scritta è attraversata dal residuo di terra che la pioggia ha trascinato con sé sottraendola al bel vaso di terracotta che sovrasta il muro di tufo.
Carlos è vecchio e ferito a morte dalla gente impietosa che non gli perdona il tramonto atletico, dopo il fastoso tracciato di una carriera stellare.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 18 dicembre
VALENTINA
di Luciano Scateni
Il top nero, di morbida seta, ha un percorso decisamente femminile con la curva generosa che s’inarca appena al di sotto delle clavicole, evidenti sulla magrezza non spinta di Valentina.
La stoffa, tagliata con maestria, ampia sul petto, non è certo modellata per aderire alla pelle. Sicché non c’è che da aspettare un movimento più accentuato in avanti della splendida donna per intuire forma e consistenza del reggiseno, anch’esso nero, che separa due tenere coppe, appena sufficienti a coprire l’area immediatamente prossima all’areola dei capezzoli.
A caschetto, con la frangetta che cade un attimo più su delle sopracciglia ben disegnate, i capelli di Valentina son neri per davvero, nerissimi, lucidi, non uno fuori posto.
È in forse la sfida sul primato degli occhi, profondi, taglio lievemente orientale, o della irresistibile attrattiva della bocca: il disegno delle palpebre è dolce, armonioso e si esalta con la giusta ombreggiatura di ciglia naturalmente lunghe e folte, anch’esse scure come l’ebano; sono carnose entrambe le metà delle labbra che nell’arco superiore assecondano l’incavo che precede la punta del naso appena all’ insù. Partendo dai margini laterali delle labbra che le concludono con dolcezza si potrebbero tracciare due linee virtuali all’insù, certi che si congiungano con il centro delle pupille, perfezione che può apprezzare chi ha confidenza con le tecniche del disegno e della pittura e in particolare con le proporzioni migliori del volto di una donna.
Sono ben unite al capo le orecchie e non conoscono che dolci rotondità. I lobi, non violati per ospitare orecchini distinti dai padiglioni, completano l’armonia del contorno netto e discreto dell’insieme. Una linea morbida include la perfetta congiunzione delle spalle con il profilo del collo, da far invidia a Modigliani.
Benché magre, le braccia, moderatamente più lunghe del normale e ben tornite, si concludono con grazia nei polsi nudi, privi di orologio e braccialetti. Le dita della mano sono ben curate e affusolate.
Dicono accreditati cultori della perfezione al femminile che i seni di una donna si deve poterli racchiudere nell’ampiezza di una coppa di champagne e i seni di Valentina obbediscono a questo canone, ma con più preziose gradevolezze: il gonfiore che interrompe la levigatezza del petto, inizia molto in alto, così da rispettare il giusto spazio tra il margine inferiore dei seni e la linea ideale della vita che marca profondamente l’incavo oltre il livello delle anche.
Il cerchio poco più scuro dell’area che accoglie i capezzoli accentua la diversità con il bianco della pelle di velluto, e lo enfatizza grazie alla trama regolare di minuscoli pianeti erogeni che diventano turgidi a ogni sollecitazione, che sia il freddo, stimoli della sfera sessuale e perfino innocui contatti con il tessuto a velo del reggiseno.
Il ventre, elastico, si esprime con una minima ridondanza che raggiunge il suo massimo giusto attorno al contorno dell’ombelico, per tornare rapidamente ad appiattirsi prima di esprimere la marcata evidenza del pube, la sua peluria ordinata in direzione della linea mediana che attraversa tutto il corpo fino a separarsi laddove inizia il plastico incontro con le gambe. Non tanto più giù del punto di congiunzione tra i confini inferiori delle scapole, la schiena si ritrae in un solco profondo che si colma per sottolineare la sporgenza ardita, perfettamente circolare della natiche.
L’altezza forse eccessiva, sicuramente di notevole effetto delle gambe, giova all’idea complessiva di una figura slanciata e sicuramente carica di femminilità.
 Come non avere consapevolezza di un corpo siffatto. Valentina si è appagata della propria immagine dal tempo dei primi apprezzamenti e innanzitutto per la complicità di una madre vanitosa, oltre che avvezza a valutare se stessa, gli altri, anzi le altre, con esclusivi parametri di esteriorità.
Come non avere consapevolezza di un corpo siffatto. Valentina si è appagata della propria immagine dal tempo dei primi apprezzamenti e innanzitutto per la complicità di una madre vanitosa, oltre che avvezza a valutare se stessa, gli altri, anzi le altre, con esclusivi parametri di esteriorità.
Tutto ha congiurato perché la ragazza si uniformi poco per volta al personaggio che Crepax ha disegnato ispirandosi alla sua donna. E’ stato lo stesso disegnatore a strizzarle l’occhio mentre firmava autografi durante un “Salone del fumetto”, notandola tra il pubblico, già pettinata alla Valentina, ormai felicemente vicina alla maturità fisica. Della Valentina virtuale ha cominciato a imitare sguardi e civetterie, l’abbigliamento e lo stile di vita, insieme sofisticato e provocante, fino a convincersi di potersi offrire come modella al famoso disegnatore.
E’ di fronte allo specchio, accanto a sé la sedia viennese, in tutto uguale a quella che Marlene Dietrich ha cavalcato per mettere in evidenza le gambe affusolate; la punta della scarpa di Valentina, dal tacco vertiginosamente alto, è sulla seduta e in quella posizione la gonna scivola sulla gamba, scopre la giarrettiera, il bianco della coscia fino all’orlo degli slip. Valentina prova a immaginare l’intensità del desiderio che susciterebbe negli uomini se li guardasse così, piegando leggermente in avanti la testa e accompagnando lo sguardo con il gesto vezzoso della mano che si poggia sul seno, come a difenderne la nudità.
Sa che il narcisismo ha progressivamente preso il posto dei normali slanci affettivi, che addirittura ha spento la libido, che infine del normale desiderio di sessualità non è rimasto molto, che ha prevalso su tutto l’interesse maniacale per il suo sontuoso portamento, la perfezione dei tratti del viso; lo charme incanta gli uomini e inganna la loro convinzione di trovarsi di fronte a una donna con forte carica erotica. Non ha consapevolezza che per chi ha capacità di leggere oltre l’apparenza di occhiate invitanti e ammiccamenti c’è il niente clamoroso. Non immagina di essere collocata nel ruolo di bambola, seppure di lusso.
Dalla finestra spalancata entra un sole inquietante per quanto è caldo di novembre, ma entra anche il freddo secco della tramontana e si fa sentire lo stereo di un’auto parcheggiata a breve distanza. La finestra aperta lo asseconda involontariamente. Gianluca è un giovane studente deluso di psicologia, spinto a occuparsene dalla consapevolezza di dover tenere a bada le conseguenze di turbe emotive provocate dalla tragedia di una madre suicida al culmine di una ricaduta nella depressione e dal disagio del rapporto nullo con il padre alcolizzato. Da qualche ora se ne sta appostato sul terrazzo e di lì la vista della finestra è diretta. Con il binocolo si introduce morbosamente nel privato di case dirimpettaie, soprattutto di donne impegnate in lavori domestici. A un tratto Gianluca si immobilizza e mette a fuoco la figura di una ragazza di colore piegata sul letto da rassettare.
Il fucile con il mirino telescopico si ferma su questo bersaglio. Gianluca inquadra la nuca di Dogath e la segue con spostamenti minimi del fucile. La ragazza sfila un lenzuolo di sotto il materasso e s’avvicina alla finestra per scuoterlo. Al centro della fronte c’è ora un punto rosso, del mirino telescopico. Il dito preme deciso sul grilletto e la ragazza rimbalza all’indietro come un pupazzo abbattuto al tiro a segno. Le braccia che teneva di lato per scuotere il lenzuolo ricadono inerti, il corpo finisce in terra scomposto. In corrispondenza del foro, a metà fra i due occhi, s’allarga pochissimo il rosso del sangue.
Il bossolo schizza sull’impiantito del terrazzo. Il rumore è forte quanto lo sparo del fucile attutito dal silenziatore.
*
Valentina gira di un quarto il busto e la testa lo segue. Slaccia un altro bottone della camicetta per capire quanto conceda ad un ipotetico ammiratore. Così è in posizione quasi frontale rispetto alla finestra e il foro questa volta è appena sotto il cuore, ugualmente mortale.
Gianluca raccoglie i bossoli, smonta con calma il fucile e lo ripone nella custodia nera, preme sulle due piccole serrature, la poggia su un ginocchio ripiegato e prima di alzarsi ci batte su un paio di volte, come farebbe un violinista soddisfatto dopo un concerto riuscito. Il corpo di Valentina si è scomposto nel toccare terra. La frangetta poggia da un lato sul pavimento e dall’altro lascia scoperta una porzione della fronte. Le gambe sono intrecciate innaturalmente e un braccio è schiacciato sotto il corpo. Il peso della testa sulla guancia che tocca a terra deforma la bocca.
Lo specchio, impetuoso, continua a fissare la sua tragica immobilità.
Gianluca si issa sul muretto del terrazzo, lancia lontano la custodia del fucile e abbandona l’appoggio con un breve passo, fino a trovare il vuoto perpendicolare di quindici piani del palazzo nero di smog.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 11 dicembre
MARTA
di Luciano Scateni
La mani si levano alte sulla tastiera, leggere. Sono coperte d’una peluria folta, in linea con la rete di vene in rilievo che dal polso s’irradia fino al punto di congiunzione del dorso con le dita, e scavalca le nocche decise, fino ad assottigliarsi in vasi quasi invisibili sotto la pelle tesa delle dita affusolate. Sono mani nervose quando si abbattono sui tasti per obbedire a frasi musicali che richiedono tempi serrati e forza in crescendo. Non in questo momento di concentrazione che precede i primi accordi della musica di Berlioz, tra un attimo amplificata dalla cassa di risonanza di un sontuoso Stainway, accordato dallo specialista Van Basten in persona. Le dita si piegano per esprimere la giusta pressione sui tasti fin dalle prime note. Gli occhi corrono sulle righe e anticipano di qualche battuta la seconda frase dell’esordio. L’andantino Albumleaf, del 1844, non è una composizione tecnicamente ardua, ma richiede superiori capacità di concentrazione in alcuni passaggi interpretativi.
Gustav Mortensen ha più volte sperimentato la capacità di impedire che prevalga la dissociazione tra il momento creativo dell’esecuzione e il ricordo di ore e ore trascorse nel perfezionare una stessa frase musicale. Le dita obbediscono alla trance interpretativa, la mente si concentra sulla sequenza emotiva che perfeziona la qualità dell’esecuzione. L’imprevisto interferisce con la perfezione tecnica della performance nella seconda parte dello spartito e Gustav si limita a leggere senza l’empito che gli è riconosciuto universalmente. Da un angolo abitualmente controllato della coscienza emergono, dominanti, pensieri che portano l’artista lontano dalla sala concerti e dalla musica di Berlioz.
* * *
Marta, non è la prima volta, ha disertato il teatro, gli ha preferito la scrittura dell’ultima biografia che le ha commissionato l’editore parigino Hachette, con il quale intrattiene da molti anni un proficuo rapporto di collaborazione. Il profilo di Mahler non è semplice da tracciare, ma la moglie del pianista non ha difficoltà a disegnare la personalità di giganti della cultura, in questo caso della grande musica.
 Il concerto, immagina, deve essere più o meno alla metà dell’esecuzione. Le sembra di vedere Gustav, la sua aria assorta, ispirata, la forza magnetica che emana mentre le dita sfiorano i tasti con maestria… Intuisce perché chi lo ascolta subisce il fascino del superbo interprete e dell’uomo ritenuto da chiunque lo frequenta gradevole, saggio, di grande talento, colto. Marta ha scoperto presto come sia invece possibile che la statura di un grande artista coesista con le negatività di un uomo egoista, gretto, incapace di un vero sentimento oltre la vanità e un’esasperata autoreferenzialità.
Il concerto, immagina, deve essere più o meno alla metà dell’esecuzione. Le sembra di vedere Gustav, la sua aria assorta, ispirata, la forza magnetica che emana mentre le dita sfiorano i tasti con maestria… Intuisce perché chi lo ascolta subisce il fascino del superbo interprete e dell’uomo ritenuto da chiunque lo frequenta gradevole, saggio, di grande talento, colto. Marta ha scoperto presto come sia invece possibile che la statura di un grande artista coesista con le negatività di un uomo egoista, gretto, incapace di un vero sentimento oltre la vanità e un’esasperata autoreferenzialità.
Mortesen non segue più le note dello spartito e suona in automatismo, senza la partecipazione che ha reso famose le sue interpretazioni. La mente gli propone Marta mentre batte sui tasti della Remington professionale e copia quanto ha scritto a mano con la sua grafia da amanuense, il gesto abituale di sollevare di tanto in tanto il capo dal foglio per passare leggermente le dita sulle palpebre, a massaggiare gli occhi.
“È stato un peccato di ambizione prenderla in moglie”. Marta aveva ai suoi piedi tutta Bruxelles. In primo luogo per una bellezza del tutto diversa, mediterranea, e per la rara capacità di trasformare la sua raffinata cultura in affidabilità, dolcezza, femminilità. La splendida ragazza aveva un’altra non secondaria dote, figlia unica di una famiglia tra le più in vista e facoltose della città. Molto, ma troppo poco per l’ambizione dell’incontentabile Gustav, che non tarda molto a valutare le possibilità di cercare analoghe qualità in altre donne, su cui sa di esercitare il fascino di artista affermato, di un portamento che attrae irresistibilmente, del ruolo sociale riconosciuto in tutto il mondo, solista ricercatissimo e più volte cercato dalla stampa, non solo specializzata.
Marta si è data un tempo per capirlo e il tempo è scaduto. Il metodo nel suo lavoro è fondamentale. Più di due ore di concentrazione comportano cadute di qualità e la scrittrice lo ha sperimentato in tanti anni dedicati ai cinque libri pubblicati dall’editore francese, tradotti in sette lingue. La sua stanza è molto personale. Il letto, ampio e senza spalliera, poggia su un’alta pedana di legno, in prezioso ulivo italiano. Tutto intorno alla stanza si sviluppa la libreria, con i volumi a cui Marta tiene particolarmente, da rileggere o consultare. Sul mobile di un famoso stilista convivono con gusto sobrio il televisore, uno stereo compatto e in un contenitore in pelle la collezione di penne stilografiche che si arricchisce continuamente di nuovi esemplari, testimonianza dei viaggi nel mondo compiuti per presentare i suoi libri. L’armadio è addossato alla parete di fronte al letto. L’anta centrale, a specchio, è la porta d’ingresso del bagno. Questo lo spazio privato che Marta si è ritagliato per marcare il confine con Gustav dopo la decisione consensuale di separarsi.
All’intesa, inizialmente condivisa, è seguito un crescendo di liti furibonde e pause di assoluta indifferenza, insulti, violenze. Gustav non ha più nascosto le infedeltà, Marta ne ha avuto nausea e ha preso ad offenderlo, a ferire la sua vanità, ha provocato reazioni violente, fino alle percosse, minacciato di destinare con il testamento i suoi immensi beni all’Accademia che finanzia con borse di studio e pubblicazioni i giovani talenti della letteratura norvegese e ai benemeriti di “Save the children”, a Medici Senza Frontiere.
Al culmine di una conflittualità esasperata, Marta annuncia al marito che si è rivolta al legale di famiglia perché avvii le pratiche di divorzio. Per Gustav significa perdere prestigio, introduzione negli ambienti bene di mezza Europa, una montagna di soldi: infinitamente di più rispetto ai pur lauti guadagni di concertista.
Mortesen è alle battute finali del concerto. “A che punto sarà Marta… Deve aver finito di scrivere e avrà quasi certamente preso il suo thè verde, accompagnato da biscotti dietetici. Il solito rituale prima di andare a letto. Qualche pagina di James Joyce, il televisore acceso, potente sonnifero, una leggera pellicola di crema da notte sul viso, in particolare attorno agli occhi”.
Ma questo è già il dopo. Il grande specchio con la semplice cornice bianca, ben illuminato, riflette e fa ancora più regolare, perfetta, la magnifica bocca di Marta che stende sullo spazzolino il dentifricio con le strisce bianco-azzurre. E’ intenso l’odore di menta, deciso il sapore.
Gustav esce dal camerino e s’avvia al foyer dove l’aspetta Erika, ultima trasgressione a un matrimonio per altro finito soprattutto per sua colpa.
Lenzuola di lino ricamate, una morbida coperta, leggera ma caldissima e sul tavolino, accanto al letto, il secchiello con il ghiaccio, una bottiglia di «Ferrari», il vetro coperto di un sottile velo gelato, e ancora “Gente di Dublino” letto male tanti anni prima, il telecomando, una rosa colta nel solarium trasformato in serra, l’elegante «Mont Blanc», un blocco di carta patinata, l’anello con lo smeraldo che per la luce incidente del faretto da notte manda bagliori a stella, riflessi nel vetro che protegge un’immagine firmata Mc Karsey, celebre fotografo dei Vip che ritrae Coimbra, gatta persiana dolcissima e golosa; un filo di perle, la lettera di Monique da Parigi, che racconta la sua l’ultima crisi depressiva, conseguenza di un amore intenso, ma finito bruscamente, la bozza della sceneggiatura per il mitico regista Yanich Demongeot, dieci righe che confermano l’esodo californiano di Marianne, psicanalista attratta dalla scuola di Palo Alto e una nota di Hachette sui progetti della casa editrice; il compact-disc di Aretha Olsen, due sfere d’acciaio in una coppa dorata, le chiavi della Porsche; la scatola del sonnifero in capsule: Marta accomoda due cuscini dietro le spalle e si prepara a rivisitare James Joyce. Nella strip sono rimaste sette capsule allineate due a due, la settima accanto al piccolo contenitore di plastica, vuoto e ricoperto alla meglio dal tondino di carta argentata. Con l’unghia, Marta incide i bordi del cerchio argentato che blocca l’ultima capsula e l’ingoia con la solita difficoltà.
Gustav non ha mai capito se ammira la disciplina mentale della moglie, il suo fanatismo per la precisione, o se ne ha fastidio. Alle undici del mattino, puntualissima, Marta è uscita per comprare i giornali. Nel piccolo armadietto farmaceutico, in bagno, la scatola di “EVC” è al suo posto e isolata, a portata di mano senza guastare l’ordine metodico con cui Marta tiene in ordine gli altri medicinali. Gustav l’apre, vuota con un ago l’involucro gelatinoso di dodici capsule e versa il liquido incolore nel bicchiere d’acqua che Marta beve sistematicamente prima di ogni pasto. Nella mistura finiscono anche cinque gocce di un veleno che stroncherebbe anche un elefante.
Il sapore le sembra diverso, metallico, ma Marta lo attribuisce ai periodici interventi di purificazione dell’acquedotto. “Dublino, Gente di Dublino…” Un dolore tremendo al petto, il respiro che manca e una fitta, all’imboccatura dello stomaco.
Gustav rientra come sempre in ritardo sull’ora del pranzo.
“Pronto, polizia?”
“Purché Kimbau si accontenti di quanto gli ho dato per garantirmi il silenzio sul veleno”. L’ha portato con sé dal Kenia, nascosto in un medaglione che non ha destato sospetti e lo ha venduto al pianista per una somma che non avrebbe mai visto in tutta la vita.
Suicidio. E’ il verdetto comodo per liquidare la morte della scrittrice, avvalorato dalla strip vuota del sonnifero, sul comodino accanto al letto dove Gustav ha portato la moglie senza vita.
L’acume dell’occhialuto Olaf Gustafsson, neo assunto al dipartimento di polizia, rimette tutto in gioco e riapre il caso, partendo dalla lettura del testamento di Marta che evidentemente non ha fatto in tempo a modificare. E’ Gustav il destinatario di un fortuna in corone norvegesi e immobili. Non ne godrà, condannato a trascorrere il resto della vita in carcere, dove ha chiesto inutilmente di disporre di un pianoforte nella sala delle assemblee plenarie dei detenuti.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto del Referendum del 4 dicembre
Quel Paese dove il SI suona…
di Cristiano Mais
Maria Elena svela il segreto della sua verginità. E finalmente dice SI a Matteo
Matteo moltiplica pani, pesci, voti in Italia e all’estero. SI vola con Jp Morgan
Jp e il suo plenipotenziario Blair-Liar a Natale SI mangiano panettone, panforte e Monte Paschi
Monte Paschi festeggia il suo terzo salvataggio, SI fotte un bel bottino e brinda con Etruria
Etruria brinda alle sue assoluzioni e SI fa un baffo di tutti i fottuti e cornuti risparmiatori
I risparmiatori, chissenefrega, SI beccano sempre calci dall’Europa
l’Europa festeggia il magico SI a tre giorni dal voto del suo prode Romano
Romano stappa lo champagne con l’amico tedesco che aveva già detto SI, Junker
Junker SI getta tra le braccia del compagno di tutte le merende, il finto nemico Scheuble
Scheuble SI butta il passato alle spalle e anche la carrozzella, leggendo il Financial Times
il Financial Time SI interroga sul perchè abbia fatto un’inversione a U in 24 ore l’Economist
l’Economist SI chiede perchè il Financial Time non SI occupi del Sole 24 ore
il Sole 24 ore SI aggroviglia tra bilanci dopati e i SI di Confindustria
Confindustria SI Boccia
Boccia non SI dimette e pensa caso mai di nominare direttore Santoro
Santoro SI convince subito e nomina suo vice Briatore
Briatore ha votato SI facendosi riprendere su Istagram dall’estero
dall’estero può arrivare quel 3 per cento di SI sollecitato dalle letterine, tutto ok per Gentiloni
Gentiloni ha implorato per tre mesi il SI ad un incontro con la Clinton
la Clinton e la sua Foundation sono per il SI così come Obama
Obama è per il SI e forse lo è anche il suo successore Trump
Trump SI è appena scelto come ministro del Tesoro un pezzo da novanta di Goldman Sachs
Goldman Sachs SI fida moltissimo, tra i nostri, di Prodi, Monti e Draghi
Draghi SI pronuncerà sul fresco aumento per gli statali, dopo otto anni, da 80 euro?
80 euro, ok il prezzo è giusto, un numero che SI vede sempre nel pallottoliere di Renzi
Renzi spera in un SI all’ultimo respiro di papa Francesco
papa Francesco SI è rivolto con grande asprezza contro tutti i politici corrotti
i politici corrotti SI siederanno comodamente in Senato travestiti da consiglieri regionali
i consiglieri regionali SI occuperanno ancora da palazzo Madama di trasporti e sanità
sanità più facile, cure sicure e vaccini per tutti se il SI vince, promette Lorenzin
Lorenzin non SI pronuncia sul processo per il sangue infetto che investe il gruppo Marcucci
Marcucci Andrea, l’ex braccio destro di De Lorenzo, oggi SI fa in 4 per Renzi al Senato
il Senato non SI eleggerà più dai cittadini espropriati perfino del diritto di voto
il voto è ormai un voto di scambio, SI compra e SI vende, come era anche all’epoca di mamma Dc
mamma Dc ha partorito babbo Renzi e nel suo grembo SI è fatto le ossa figliol Matteo
Matteo è stato denunciato per alto tradimento – ma di questo non SI parla – su voto estero e Jp
Jp Morgan ha scritto tre anni fa che SI deve rottamare la Costituzione
la Costituzione non SI tocca, disse Calamandrei, può farlo solo il Parlamento, mai il Governo
il Governo prima del referendum per il SI ha promesso sgravi fiscali a tutte le imprese del Sud
il Sud è in condizioni sempre più schifose, ma SI può andare avanti così, Renzi e Delrio?
Delrio inaugura a Napoli il più costoso e devastante dei metrò, e non SI parla mai di camorra
la camorra SI mangia il territorio, brucia, investe, estorce, ricicla e manda in Parlamento
il Parlamento SI è ormai popolato di corrotti, ladri, stupratori e satanassi come l’Inferno
l’Inferno venne cantato da un mister SI portato scodinzolante in gita alla Casa bianca, Benigni
Benigni e Sorrentino, il genio eruttato dal Vesuvio, mentre SI vede anche la sagoma di Fazio
Fazio e il suo Rischiatutto nuovo di zecca, dove SI lanciò ai tempi di Mike proprio Matteo
Matteo che il suo gemello Berlusconi vorrebbe SI desse proprio a presentare i talk
i talk e i faccia a faccia dove SI fatica ormai a reggere i conati e mantenere le viscere
le viscere della terra delle città delle montagne massacrate un giorno SI e l’altro pure
pure il fango SI rimescola SI rigira e non SI vergogna, Matteo…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 27 novembre 2016
MARGOT – seconda parte
di Margherita B.
La prima parte, che il lettore trova qui a seguire, è stata pubblicata domenica 20 novembre
Cominciò a sollevarsi dopo una settimana. Due grossi cuscini dietro le spalle, uno sguardo alla finestra. Ebbe una strana sensazione: il cielo di un colore mai visto prima, il verde degli alberi più intenso, anche le rondini che volteggiavano parevano diverse, forse più veloci. Pensò: la malattia mi procura ancora dei disturbi, la debolezza può fare degli scherzi. E infatti, quando la misero seduta sul letto ebbe un capogiro, normale. Ma era se come anche dentro le cose stessero cambiando: si sentiva un’altra persona.
La mattina dopo, davanti allo specchio, quasi non si riconosceva. Pallida, sì, ma gli occhi come più grandi, più luccicanti. I capelli le correvano lungo le spalle: pensò di tagliarli. Le infermiere la accontentarono, ed ebbe un caschetto biondo. Adesso era proprio lei: era sbocciata Margherita.
Quando fu in piedi, e vide quel letto, ebbe la sensazione che tra quelle lenzuola restava a dormire, per sempre, un’altra persona, forse Margot. E lei solo adesso cominciava a camminare, con un passo diverso: si sentiva più leggera, più viva. Come se fino a quel momento fosse stato tutto un lungo sonno, forse un sogno. Vide i suoi vestiti nell’armadio: si domandò come avesse potuto mai indossarli. Chiese un camice bianco, proprio come quelli delle infermiere che l’avevano assistita con tanto affetto. E volle parlare con la direttrice della clinica.
Aveva deciso di rimanere, chiese se poteva lavorare, avrebbe fatto qualsiasi cosa, in cucina oppure per pulire le camere e i corridoi. Ma voleva anche studiare, per diventare infermiera. I genitori erano felici: qualsiasi cosa per il suo bene, e dopo tante sofferenze quella era una buona soluzione. La direttrice accettò e Margherita trovò la sua casa.
Le forze tornarono rapidamente, cominciò subito i turni, rassettava, puliva, lucidava i pavimenti, il sorriso sempre sulle labbra, non aveva mai fatto in vita sua quelle cose e invece era come se non avesse fatto altro. Una parola per tutti i pazienti, si informava sulle loro condizioni, voleva sapere, capire. Appena possibile, correva dai suoi libri, due volumoni per il diploma. Il tempo correva, passavano i giorni: ma per Margherita era sempre come il primo mattino, quando aveva aperto gli occhi dopo la grande paura.
Arriva il giorno del diploma, col massimo dei voti, e subito la chiamano in chirurgia, assistente. E’ la più brava, osserva tutto con grande attenzione, non le sfugge un dettaglio, e poi è come se già lo avesse fatto mille volte. Ha finalmente trovato la sua strada, quella che il destino ha disegnato per lei.
In clinica fanno i turni medici giovani, freschi di laurea, venuti a Parigi per specializzarsi. Ne sono passati diversi, negli ultimi mesi. Ma solo uno, Michele, ha suscitato la sua curiosità. Arriva dall’Italia, è pugliese, bruno, si incontrano quasi tutti i giorni in chirurgia. Studia, Michele, per diventare urologo. Anche lui è incuriosita da Margherita, le piace la sua dedizione per il lavoro, le piacciono i suoi occhi intensi, il suo caschetto biondo. Parla poco, lei, ma quelle parole riescono sempre a colpirlo: forse per la loro soavità, come carezze.
Le chiede di andare a un cinema, Michele, fare quattro chiacchiere per conoscersi meglio. Aspettava quell’invito, Margherita. Ha dentro di sé un po’ di paura, come un salto nel vuoto dopo tanto tempo. Ma decide di volare.
E sono sempre in volo, dopo qualche settimana, a parlare del loro futuro, dell’Italia. Hanno la stessa passione, è il destino che ha voluto quell’incontro. Ragionano così: è stata la volontà del Signore e far sì che lei, dopo la malattia, restasse proprio lì, e a portare lui per la specializzazione da lei, a Parigi, e in quella clinica, per potersi mantenere agli studi. Il cuore di Margherita è in estasi: dopo la guarigione, il lavoro e ora l’amore. E’ davvero la sua seconda vita. Forse la prima non è mai neanche esistita.
Cominciano a fare progetti. Michele ha le idee chiare: so che a Napoli ci sono delle buone possibilità – dice – ho un paio di amici che hanno parecchie conoscenze, mi possono aiutare; e poi mettiamo su qualcosa per conto nostro. Napoli è bella, racconta lui, ci sono stato da ragazzo, il mare profuma la città, le carrozze per le strade, tante chiese nella parte antica, il monastero di Santa Chiara che ne parlano in tutto il mondo, e poi si mangia bene, l’aria è pulita. Ci possiamo mettere radici, fare due figli, la Puglia non è così lontana e andiamo ogni tanto dai miei. Margherita beve dalle sue labbra il racconto del loro futuro, le sembra subito a portata di mano, stanno già passeggiando lungo gli azzurri di via Caracciolo.
 Non sarà tutto facile, bisognerà stringere i denti, almeno nei primi tempi, ma ce la faremo: parola di Michele. E così i due colombi volano verso il Vesuvio, che quel giorno presenta un pennacchio più marcato del solito. Il mare è appena increspato: mare di sotto – imparerà presto Margherita – sembra abbastanza tranquillo ma non è così, meglio stare in guardia.
Non sarà tutto facile, bisognerà stringere i denti, almeno nei primi tempi, ma ce la faremo: parola di Michele. E così i due colombi volano verso il Vesuvio, che quel giorno presenta un pennacchio più marcato del solito. Il mare è appena increspato: mare di sotto – imparerà presto Margherita – sembra abbastanza tranquillo ma non è così, meglio stare in guardia.
Vanno a vivere in due stanzette lungo la Riviera di Chiaia, il mare è a un passo, basta attraversare la Villa Comunale ed è lì, che ti aspetta. Lui lavora, fa le notti in una clinica del centro, ma intanto ha già preso contatti per riavviare una casa di cura chiusa da anni al Parco Margherita, una delle zone migliori della città, a pochi metri una delle vie principali, il corso Vittorio Emanuele, poi sempre salendo ci si arrampica verso il Vomero, pieno di verde e di colline, dove le famiglie vanno per prendere il fresco e fare un pic nic.
Sono trascorsi otto mesi, quasi una maternità, e Margherita si sta accorgendo, ogni giorno che passa, di una cosa strana: era lui, prima, a parlare sempre di matrimonio. Ora quella parola quasi non la pronuncia più. Sarà di certo perchè lui è così immerso nel suo lavoro, nella clinica che gli porta via il sonno, la banca che gli deve prestare i soldi, i lavori per rimetterla in sesto, i macchinari da prendere in fitto. Le ha chiesto di stargli vicino, di dargli una, due mani, altrimenti il loro progetto non decolla. E’ certo per quei tanti pensieri che di nozze non si parla più…
E poi, la clinica porterà il suo nome, “Margherita”, come la pizza, la regina, il parco ma soprattutto lei, che con lui ha partorito quel sogno. Le sembra di essere tornata a Parigi, quando lavorava e studiava giorno e notte, poche ore per riprendere le forze e via di nuovo, senza sabati né domeniche. E sempre con gli occhi a guardare il domani. Allora le acque della Senna, oggi quel mare del golfo che tutti nel mondo ci invidiano. E Margherita era sicura: chiunque farebbe i salti mortali per essere come loro, come lei, la donna più felice: un sogno che sta diventando realtà.
Anche stavolta, però, arriva il giorno in cui quella realtà si capovolge. Si rompe in mille pezzi come uno specchio. Michele, infatti, non parla più del loro sogno, di quel matrimonio: una mattina d’autunno la prende per mano, la abbraccia forte e le sussurra, “ti devo parlare”. Le viene, per un attimo, una sorta di vertigine, come se quel momento lei lo avesse già vissuto. In quell’abbraccio – ancora non riesce a spiegarselo – sente l’abbraccio di suo padre che la confortava, tanti anni prima, nella clinica di Parigi.
Michele l’abbracciava e la stringeva a sé proprio come un padre che deve consolare una figlia forse per una brutta notizia in arrivo. La notizia è che Michele non può più pensare alle nozze con lei perchè ha appena preso in sposa una ragazza spagnola: la sua famiglia non voleva una Margherita bella ma povera, preferiva di gran lunga quella Escobar arrivata da Madrid con i genitori e un carico di pesetas al seguito. Margherita va giù, giù, in quelle acque blu cobalto. Quel mare di sotto la travolge. Ma non annega.
Come un naufrago, ubriaco d’acqua, la testa che gira all’impazzata. Non sa più su quale lembo di terra sia approdata, l’unica certezza è che i polmoni riescono a pompare ancora aria. E’ costretta a rialzarsi una seconda volta, Margherita, e va a vivere in una stanzetta tra i vicoli di spaccanapoli. Di giorno comunque si spacca la schiena per portare avanti la “sua” clinica, quella “Margherita”. Ancora una volta, si tuffa tra le carte, le ricevute, gli ordinativi, il personale da coordinare: meglio lavorare che pensare. Non vuole pensare al suo amore perduto che vede tutti i giorni, il suo amore molesto. Non ci dovrà mai più pensare. Solo il lavoro, la clinica.
Per Michele è tutto normale. La ama, la amerà sempre, ma non potevano coronare il loro sogno, i suoi non l’avrebbero mai accettato, e non poteva ferirli a morte. La sposa di Spagna gli darà dei figli, avrà la sua famiglia; con lei invece potrà condividere il lavoro, il sogno di una clinica tutta loro. Una clinica che va bene, ci vengono tanti signori, la Napoli che conta, quelli che nonostante i tempi non siano poi così prosperi i soldi li hanno. Lei, poi, adesso è diventata direttrice…
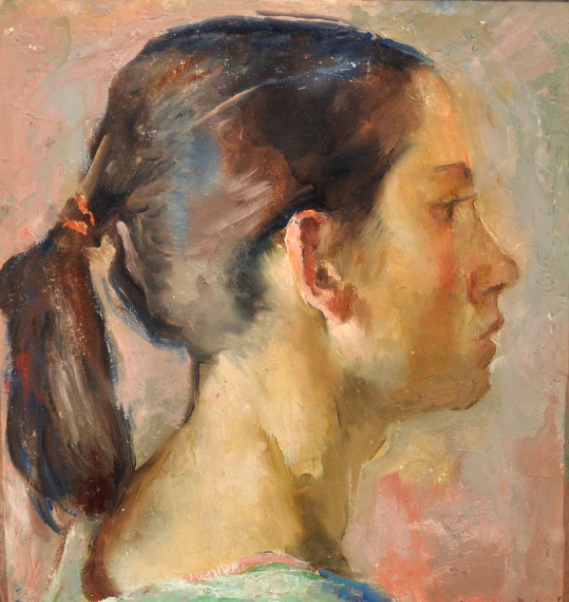 Gli affari vanno, ma anche la stagione della Margherita, per loro, sta finendo. Lui pensa ad un’altra iniziativa, stavolta nel cuore di Napoli, per fare le cose più in grande: non solo urologia, ma anche ginecologia. Ad un convegno ha conosciuto Enrico, un collega che si occupa, appunto, di ginecologia, lui gli ha parlato dell’idea che aveva in mente da un po’, sembra parecchio interessato. Si tratta di fare dei conti, trovare il posto giusto e partire. Michele vuole il parere di Margherita, senza il suo aiuto e i suoi consigli la cosa non può nascere. Fammi conoscere Enrico – dice lei – voglio vedere che impressione mi fa…
Gli affari vanno, ma anche la stagione della Margherita, per loro, sta finendo. Lui pensa ad un’altra iniziativa, stavolta nel cuore di Napoli, per fare le cose più in grande: non solo urologia, ma anche ginecologia. Ad un convegno ha conosciuto Enrico, un collega che si occupa, appunto, di ginecologia, lui gli ha parlato dell’idea che aveva in mente da un po’, sembra parecchio interessato. Si tratta di fare dei conti, trovare il posto giusto e partire. Michele vuole il parere di Margherita, senza il suo aiuto e i suoi consigli la cosa non può nascere. Fammi conoscere Enrico – dice lei – voglio vedere che impressione mi fa…
Sarà una buona impressione. Ottima. Ed eccellente sembra la nuova meta, piazza Bellini, uno dei salotti di Napoli, a un passo dal Conservatorio, poco distante dal Museo, tra le mete più frequentate dai turisti che poi passeggiano per via Roma traversando piazza Dante. A un passo, poi, c’è il Policlinico, il fiore all’occhiello per chi si cura a Napoli. Il cuore di Margherita torna a battere, il lavoro, i pazienti, i conti che tornano. E poi, quell’Enrico è un uomo pieno di risorse, di energie. Occhi acuti, baffi e barba ben curati, le torna in mente Jean Paul: anche stavolta, una sensazione che non riesce a spiegarsi. Ma è come se – onde su onde nel mare – quel suo passato ogni tanto riemergesse. Immagine per immagine, tassello su tassello di un grande mosaico.
Parte bene, la “Villa dei Glicini”, anche qui una clientela di tutto rispetto, il meglio delle cure urologiche e ginecologiche. Qui nasco anche io che vi racconto questa storia: mi hanno chiamato Bianca e poi Margherita, che mi ha vista nascere: i suoi occhi mi saranno sempre davanti, come due luci immense, anche quando la notte si fa più buia.
Margherita vive in un monolocale a un passo dalla clinica. In quella stanza non c’è grande spazio per i sogni, una vita in famiglia, dei figli, un marito come era lì lì per avere. Si fa coraggio e pensa alle cose positive che ha davanti: il suo lavoro, è direttrice e guadagna bene, i suoi nipoti a Parigi. A proposito, quando dopo sei mesi la clinica si è ben avviata e può contare su un paio di collaboratori di fiducia, è riuscita a tornarci per due settimane: quella sua Senna, un passeggiata come dentro una nuvola lontana. Ha portato tovaglie e merletti ricamati per i suoi nipoti, sono sempre nel suo cuore. Il cuore grande di Margherita.
E il cuore ha due ventricoli, come insegna la scienza medica, il destro e il sinistro. Fatto sta che, cammin facendo, la presenza di Enrico, nella vita di Margherita, si è creata un suo spazio. All’inizio lei non ci dava peso, né voleva crederci. Poi, un po’ alla volta, ha capito che forse quello era proprio il suo nuovo destino. Non sapeva spiegarselo, e non cercava spiegazioni, ma era come se la sua creatura, la clinica, quella creatura che in carne ed ossa non aveva mai potuto avere, avesse ora bisogno di due padri, quasi che senza uno dei due non riuscisse a mantenersi in piedi. Lo faceva di certo per lei, la sua Villa dei Glicini, per farla diventare sempre più forte e capace di curare tanta gente e portare tanta prosperità…
Ma ecco che il cielo diventa Celeste. Era lei l’amica che Margherita aspettava da sempre, Celeste. Quell’Angelo dei poveri, come la chiamavano le colleghe degli Incurabili, dove lavorava giorno e notte, senza un attimo di tregua, e anche quando aveva le sue ore libere preferiva restare con i suoi malati, i suoi poveri che avevano solo lei, le sue attenzioni, la sua dolcezza: proprio come un angelo custode.
Un giorno Enrico, che andava spesso agli Incurabili e l’aveva conosciuta, le dice: “vieni da noi a piazza Bellini, sei brava, abbiamo bisogno di te”. E lei nei primi mesi dividerà la sua vita, qui e là, per dare assistenza a tutti i suoi malati, quell’amore che non conosce pause, né fatica. Nella clinica troverà Margherita, che ha visto nascere la sua Bianca: come in un gioco del destino, si ritrovano insieme. Due amiche inseparabili.
E ha bisogno di legami, di chi le sta vicino, Margherita, perchè i tempi si fanno duri. Tanto più duri per lei che, francese, ora è chiamata ad una scelta: abbandonare la sua cittadinanza, diventare italiana a tutti gli effetti, o subire quelle conseguenze che il regime fascista contempla. E Margherita decide di non abbassare il capo, di non accettare compromessi: vuol restare francese e vivere a Napoli. Sarà un calvario, per lei: reclusa nella sua clinica, senza poter uscire. Ma è forse proprio quello che lei voleva: immergersi nel suo lavoro fino quasi ad annegarci dentro, senza un attimo di respiro. Senza una sua famiglia, quella famiglia che tanto aveva sognato. Ma con il suo lavoro. E l’amica Celeste al suo fianco.
Una vita non facile, quella di Celeste, l’Angelo dei poveri. Le verrà anche la “Spagnola”, febbri altissime, le colleghe pensavano di perderla. E raccontano una storia che sembra uscita dal libro dei sogni: una mattina trova la forza di alzarsi, afferra tre teste d’aglio, le ingurgita. E dopo alcune ore la febbre si attenua, fino a sparire il giorno dopo. Parleranno di miracolo.
 Passano le stagioni, cominciano a farsi dure, bisogna fare molta attenzione anche con i soldi, metterli da parte in attesa di tempi migliori. E finirà anche la stagione di piazza Bellini: c’è uno spazio su in collina, molto in alto, tra il verde. Costa meno, quella grande struttura, ma è proprio adatta per una clinica che ha bisogno di quiete e aria buona. Le Querce di San Martino, davanti vedi tutta Napoli, le pendici verdi, le vigne a piccole terrazze, giù Spaccanapoli, il Gesù Nuovo, a perdita d’occhio fra le case e laggiù, sullo sfondo il Vesuvio a dominare la scena. Arrivano che è primavera. Tutto sboccia: e anche questa nuova creatura deve sbocciare.
Passano le stagioni, cominciano a farsi dure, bisogna fare molta attenzione anche con i soldi, metterli da parte in attesa di tempi migliori. E finirà anche la stagione di piazza Bellini: c’è uno spazio su in collina, molto in alto, tra il verde. Costa meno, quella grande struttura, ma è proprio adatta per una clinica che ha bisogno di quiete e aria buona. Le Querce di San Martino, davanti vedi tutta Napoli, le pendici verdi, le vigne a piccole terrazze, giù Spaccanapoli, il Gesù Nuovo, a perdita d’occhio fra le case e laggiù, sullo sfondo il Vesuvio a dominare la scena. Arrivano che è primavera. Tutto sboccia: e anche questa nuova creatura deve sbocciare.
Fanno piani e progetti, Margherita, Enrico e Michele. Loro pensano sempre in grande, lei cura tutti i dettagli, non le sfugge un particolare. Gli spazi sono molto più ampi, si possono far le cose per bene, due grandi reparti, urologia e ginecologia. E nel piano di sotto si può organizzare una bella cucina, e anche per viverci. Ed è così che Margherita ha una sua bella stanza, spaziosa. In quella molto più grande a fianco, si sistemano due infermiere, ma anche la cuoca, Maddalena, e la sua bambina, Angela. Angela di nome e di fatto.
E’ una bimba già cresciuta, Angela, ha dodici anni e va a scuola. E a piccoli passi comincia ad entrare nel grande cuore di Margherita. La vede già signorina, col camice bianco, proprio come lei a Parigi, lavoro e studio. Ha i suoi occhi, la sua grazia, la sua voce soave, quasi un sussurro per non disturbare.
Cresce, cresce in fretta, Angela, ha iniziato il corso per infermiera e pensa già al futuro, ostetrica. Margherita la incoraggia: brava, Angela, così farai nascere tu i bambini, li prenderai in braccio, una carezza, il loro primo sguardo sarà tuo; io ho badato troppo alle carte, alle fatture, tu penserai più alle creature.
E’ quella figlia mai avuta, Angela. Che ora ha due madri. E’ felice, perchè da ognuna può imparare qualcosa. Maddalena le insegna tutto su come cucinare, tenere la casa, essere sempre in ordine, Margherita le dà consigli su come comportarsi in società, ricorda ancora Parigi, le cene, come affrontare i problemi, come non abbattersi mai e rialzarsi sempre. Ma non fare come me, Angela, riflette Margherita: creati una famiglia, fai nascere tanti bambini ma partoriscine uno tuo, fallo crescere, lo vedrai sorridere e per te si aprirà il mondo. E’ quello che io non ho mai potuto avere – riflette ancora – la pena della mia vita, quel grande vuoto che niente potrà mai colmare. E il tempo passa.
Trascorrono altre stagioni, ed è come se – anche stavolta – la vita si sdoppiasse. Ora c’è Angela, la clinica è come un po’ sbiadita; però c’è anche l’altro legame che invece non sbiadisce, quello con Celeste. Lavorano insieme e sono anche sempre più amiche. E’ Celeste che va a fare la spesa, e poi una volta al mese alla Sepral, dove la previdenza consente di far rifornimento di quel che serve, e soprattutto dei medicinali. Certo Margherita dedica tutto il suo tempo al lavoro, non fa mancare un minuto del suo impegno: del resto i suoi “maestri”, Michele ed Enrico, le chiedono sempre conto di ogni cosa. E i conti tornano, grazie a lei. Ma è come se ci fossero due Margherite: una che mette il pilota automatico e recita il copione di anni imparato a memoria; l’altra che si emoziona quando vede la sua Angela alle prime lezioni di ostetricia.
E quel sogno una notte d’estate, una grande casa Bianca, un parco immenso, stanze tutte linde e bianche, corridoi profumati come gelsomini ai balconi. E loro due, Margherita e Angela, col loro camice bianco a raccontarsi dell’ultimo parto, quel bimbo nato a 7 mesi più vispo che mai. Lontane, le tranquille acque della Senna, quello scorcio che aveva ammirato tante volte da bambina. Lo mostra ad Angela, si tengono per mano, le acque scorrono lente e riflettono le chiome degli alberi. Si sveglia e ricorda le sue chiome bionde, i boccoli sulle spalle, poi quel caschetto. Anche Angela da poco li ha tagliati, sono castani: e brillano i suoi occhi azzurri.
La vita a San Martino volge al termine, Enrico e Michele hanno deciso di godersi i soldi guadagnati in tanti anni, di godersi le famiglie, le case lussuose. Due vite parallele, le loro, e una comune stella di riferimento, Margherita. Non fosse stato per lei, quelle creature non sarebbero mai cresciute, mai diventate importanti cliniche. Lei ha seminato per loro, e loro ora possono ammirare i frutti di tanto impegno. Lavoro, amore, fatica, un grande affresco dai tanti colori, le musiche s’incrociano, la sinfonia è andata avanti per anni. I due “maestri”, adesso, vogliono che il sipario cali, la rappresentazione è terminata, e salutano Margherita. Un’altra fine, l’ennesimo addio, il sogno svapora.
Finisce la seconda guerra, fame e miseria intorno. La clinica sembra un piccolo vascello che ha resistito alla tempesta ma ormai non ce la fa più: le vele sono cariche d’acqua, non reggono altri viaggi. Uno dopo l’altro lasciano questo mondo prima Enrico, poi Michele. I figli si occuperanno d’altro e la clinica chiuderà i battenti.
Non sa cosa fare, Margherita. Anche i suoi petali sono gonfi d’acqua. Ha bisogno che la bufera si plachi, sente una grande stanchezza. Il suo corpo è privo delle forze necessarie per riprendere il cammino, c’è bisogno d’una sosta. Di un po’ di pace, di silenzio, forse per capire – dopo la guerra e tante fatiche – dove siamo, cosa dobbiamo fare. Ed è così che trascorrerà un mese dai padri francescani. “Dovevo trovare la mia serenità d’animo”, diceva.
 Passato quel mese, rimessi insieme anima e corpo, torna a vivere, Margherita. E prende in fitto due stanze nel cuore antico della città, Montesanto, un brulicare di mercatini e gente indaffarata. E anche lei, ora, è indaffarata con Angela: è venuta a stare da lei dopo la fine di Maddalena. Spesso si vede con l’amica Celeste, insieme parlano e si danno conforto. Ma è dura ricominciare ancora, un’altra salita. Come quella che portava su a San Martino.
Passato quel mese, rimessi insieme anima e corpo, torna a vivere, Margherita. E prende in fitto due stanze nel cuore antico della città, Montesanto, un brulicare di mercatini e gente indaffarata. E anche lei, ora, è indaffarata con Angela: è venuta a stare da lei dopo la fine di Maddalena. Spesso si vede con l’amica Celeste, insieme parlano e si danno conforto. Ma è dura ricominciare ancora, un’altra salita. Come quella che portava su a San Martino.
Quando Celeste vola su a colorare ancor di più il nostro cielo, sarà Bianca, sua figlia, la nuova amica di Margherita. L’aveva vista nascere, quel primo sguardo, e ora il rito si ripete. I loro occhi si incontrano di nuovo, passate tante bufere. Come due naufraghi che, dopo aver tanto nuotato, si ritrovano aggrappati allo stesso legno. Si vedranno tutte le settimane, Bianca le andrà a far visita ogni sabato mattina. E porterà con sé il piccolo Elio, tre anni, suo figlio. C’è ancora una forte luce, nello sguardo pur stanco di Margherita: e si ravviva, quando Bianca viene per abbracciarla e parlare con lei. Degli anni passati, di tante vite vissute. Quella di Margherita, vissuta e non vissuta. Forse spezzata.
Vivranno insieme per alcuni anni, Margherita e Angela, insieme al barboncino Mikì, la loro creatura. Margherita si muove e lui la segue passo passo, la sua piccola ombra dolce e discreta. Lei che ha sempre preferito i mastini, grandi e grossi, ora ama perdutamente Mikì, i suoi occhi dolci che la guardano e si perdono in lei. Se non era per lui – racconta Margherita – chissà cosa sarebbe successo quella notte che un ladro entrò in casa: Mikì sente un rumore, si alza di scatto, corre nel salottino abbaiando come non aveva mai fatto. E il ladro se la dà a gambe.
La capisce fin dal tono della voce, Mikì, se lei è inquieta o ha un problema: si mette ai suoi piedi, acciambellato, e ogni tanto solleva i suoi occhi verso di lei, come a capire se è passata. E Margherita ne ha passate tante… E ora è passata in altro posto, Margherita, dove non ci sono più nuvole minacciose, dove la Senna non è più scura, il pennacchio del Vesuvio sembra un candido svolazzo e il mare di sotto è diventato per sempre quieto. Può godersi d’ora in avanti il suo Mikì, tante passeggiate insieme nei prati dove l’erba profuma, possono andare a trovare tutti i giorni Angela e Celeste, ed insieme tutte e tre a parlare di vagiti, di bimbi al primo sorriso. Il sorriso che Bianca ha visto quella mattina, quando è venuta al mondo, tra le braccia di Margherita. Un fiore che non potrà mai appassire.
Bianca va a trovare spesso le sue tre stelle, Margherita, Celeste e Angela. Ora vivono insieme, in una cappella tutta per loro. Nessuno le potrà più separare: né guerre né altre tempeste. E ogni tanto qualcuno le vede camminare, parlottando allegre, sul lungomare di via Caracciolo. Dietro a loro, scodinzolando, arriva Mikì.
Il Racconto di Domenica 20 novembre 2016
MARGOT
di Margherita B.
Pubblichiamo la prima parte del lungo racconto di una nobildonna partenopea vissuta nei primi anni della giovinezza a Parigi, poi tornata a Napoli. Ecco allora le due vite di Margot, un’esistenza dedicata agli altri nel segno dell’amore, ma fatta anche di prove, patimenti, dolori. Una dolce fiaba di vita vera, dove non mancano momenti nel segno del fantastico e del mistery.
La seconda parte sarà pubblicata domenica prossima.
PRIMA PARTE
Stupenda anche appena nata, in quella primavera del 1899, Margot. Si dice che tutti i bimbi appena nati siano belli. Secondo altri “brutti in fasce belli in piazza”, nasci con fatica, poi sbocci man mano e da adulto cominci a risplendere. Per Margherita la bellezza, esteriore e poi vedremo anche interiore, era un elemento naturale, spontaneo, dato dal Signore. Lei era così, con i suoi occhioni azzurri, quei riccioli biondi che poi si trasformeranno nei suoi capelli di fata.
Sboccia a Parigi, in quel ’99, come il più bel fiore che il Signore possa aver mandato, quell’anno, sulla Terra. E’ la terza arrivata, dopo un fratello e una sorella. Una famiglia che vive in modo modesto ma dignitoso, il padre lavora come impiegato delle ferrovie, lei fa i suoi studi. Ama la natura, Margot, i fiori – e lei è un fiore – i colori, quell’azzurro dipinto nel cielo e anche tra le calme acque della sua Senna.
Ed è proprio in una delle sue frequenti passeggiate sulle rive della Senna che – ha appena compiuto diciott’anni – avviene l’incontro. Lei è stupenda nel suo abito pieno di lillà, maniche corte e merletti ai bordi, i boccoli biondi raccolti in su. Lui elegante nel suo abito blu che non fa una piega, cilindro e ghette. Lei è appena stata dalla modista, che ha in preparazione un cappellino per la madre, lui ha appena salutato due amici incontrati per caso in banca. Sono entrambi diretti verso le rispettive case, ma il destino vuole che i loro sguardi, su quel lungo Senna, riva sinistra, si incontrino.
Jean Paul è figlio di un proprietario di lavanderie, una famiglia in ottima salute finanziaria, la sua. Di bell’aspetto, alto, barba e capelli fluenti, aria da bohemien in carriera, ha tutti gli ingredienti per far innamorare una ragazza ancora inesperta. Lui, dall’alto dei suoi quasi quarant’anni, rappresenta quella maturità che forse il cuore di Margot sta cercando. I loro occhi si incrociano, lungo la Senna, le loro mani si inseguono, un primo fugace bacio per un arrivederci che è già domani.
Lei è presa da lui, vede in lui l’uomo sicuro, che potrà un giorno proteggerla, nelle cui braccia affidarsi e perdersi. Lui è rapito dalla sua bellezza, si tuffa nei suoi occhi, è estasiato dal suo profumo che ormai mescola con quello dei gelsomini in fiore. Man mano, passeggiata dopo passeggiata, stanno diventando una cosa sola.
Jean Paul, però, è rapito anche dal gioco. Ama la bella vita, le carte, non riesce a fare a meno di un tavolo da poker o di chemen. Ma questo Margot non lo sa.
Sa invece, Margot, dell’amore che cresce in lei. Per quel bohemien sicuro di sé, che ogni settimana le fa arrivare a casa un cesto di fiori o di frutta da far restare tutta la famiglia a bocca aperta, una sorpresa che ormai sta diventando una piacevole consuetudine. E arriva il giorno in cui lui la chiede in sposa.
Sarà un matrimonio da favola. Centinaia di ospiti, un’orchestra zigana per vederli volteggiare abbracciati, amici e parenti uniti nei sorrisi, l’odore dell’erba appena umida. Sullo sfondo, le acque della Senna, quel giorno meno trasparenti del solito. E un cielo che comincia a caricarsi di nuvole.
A questo punto della storia, la tavolozza si rovescia, i colori impazziscono, le musiche diventano strepiti e i profumi perdono ogni aroma. E un odore, quella notte, prende il sopravvento su ogni cosa: quello dell’alcol.
Accade che Margot, stanca dopo quelle nozze da favola, in quell’albergo da mille e una notte, abbracciati amici e parenti, cominci a guadagnare la via della camera da letto, in attesa del suo Jean Paul. Era consuetudine, come ben ricordate, che le giovani spose vi si recassero prima dello sposo, per farsi trovare pronte, vestite di quella camicia da notte tutta svolazzi e merletti confezionata dalla mamma o, per le famiglie più agiate, dalle sarte.
Aspetta, Margot, attende invano l’arrivo del suo amato. La pendola batte la mezzanotte, viene l’una e niente. Trascorrono i minuti senza un segnale, né una presenza. Il suo cuore batte forte, è in angoscia. I genitori sono lontani. Chiede l’aiuto del Signore, lo implora. Entra ed esce di continuo dalla stanza, c’è un saloncino prima dell’ingresso all’ampia camera. Niente. Passa un’altra ora. Poi sente qualcosa all’uscio, si affaccia, e vede il suo Jean Paul riverso sul divano. Cerca di rianimarlo, avverte subito un odore acre, forte: è alcol. Trova la forza di prenderlo sotto le braccia, farlo scivolare lievemente sul tappeto, poi piano piano, colando sudore dalla fronte, riesce ad arrivare fino al letto. Lui dà qualche segnale di risveglio, quanto basta perchè possa sollevarsi appena e – sempre con l’aiuto di Margot – approcciare il bordo del letto. Qui lei lo adagia. Lo spoglia. Gli avvolge intorno il lenzuolo. Lo bacia sulla bocca, tremante.
Passano i primi mesi, un paio di stagioni. Una vita apparentemente normale. Lui esce la mattina, dopo averla baciata sulla fronte, piccole raccomandazioni sulla salute, fa il consueto giro delle lavanderie di famiglia, si occupa del personale, o va dai clienti, oppure in banca. Torna per pranzo, poi la sera con gli amici; una volta al mese la porta fuori per il concerto. Lei passa la giornata in casa, la tiene come un nido d’amore, lucida come una bomboniera. Quasi tutte le mattine la madre viene per darle una mano, e parlano del tempo, del corredo, dei parenti. Margot non fa cenno a quella notte, si perde come nella nebbia, forse non c’è mai stata: cioè non è andata così, anche lei aveva bevuto troppo, tutti e due avevano esagerato, il tempo era volato via, lui si era sentito male, zuppo di sudore l’aveva raggiunta sul tardi in camera. Insomma, le cose avevano ripreso il loro ritmo tranquillo, una vita come tante altre.
Forse chiedo troppo alla vita, pensava di tanto in tanto Margot. Invece bisogna contentarsi di quel che viene, ed è già molto. Lui mi vuole bene, mi rispetta, se poi esce tutte le sere con gli amici così fan tutti. E poi quella sorpresa, quel viaggio a Torino, tutta la famiglia in treno – organizzava tutto papà, che di ferrovie se ne intende – tre giorni dipinti nel cuore. Come i colori del Valentino, le foglie che venivano giù dagli alberi, una tavolozza di gialli, rossi, verdi, la Gran Madre, i portici, il Po che scorreva grigio e maestoso. Si sentiva come a casa, leggera, quasi a farsi trasportare da quelle acque che ricordavano la sua Senna, come in un dondolio, in una ninna nanna. Rivedeva le sue carrozze, il passeggio di sera, le musiche davanti ai caffè, come se le immagini della sua Parigi e di Torino si confondessero, mescolando profumi e sensazioni.
 Un po’ faticoso, comunque, quel viaggio. Al ritorno qualche decimo di febbre, una tosse fastidiosa. La vita stenta a riprendere il suo solito tran tran, come quando il motore fatica a carburare. Il medico le ordina assoluto riposo e una cura ricostituente. Ma la situazione non migliora, Margot si sente sente giù, stanca, senza forze. Le manca persino la voglia di parlare con la madre che viene a trovarla tutti i giorni, Jean Paul è premuroso ma è come se la sua presenza fosse intermittente, e man mano sempre più opaca. Il medico di famiglia prescrive una serie di analisi, ci vogliono giorni per avere i risultati, e Margot è sempre più pallida, il viso scavato, gli occhi privi della luce di un tempo.
Un po’ faticoso, comunque, quel viaggio. Al ritorno qualche decimo di febbre, una tosse fastidiosa. La vita stenta a riprendere il suo solito tran tran, come quando il motore fatica a carburare. Il medico le ordina assoluto riposo e una cura ricostituente. Ma la situazione non migliora, Margot si sente sente giù, stanca, senza forze. Le manca persino la voglia di parlare con la madre che viene a trovarla tutti i giorni, Jean Paul è premuroso ma è come se la sua presenza fosse intermittente, e man mano sempre più opaca. Il medico di famiglia prescrive una serie di analisi, ci vogliono giorni per avere i risultati, e Margot è sempre più pallida, il viso scavato, gli occhi privi della luce di un tempo.
Margot viene ricoverata d’urgenza, deve essere operata al seno. I risultati delle analisi non davano scelta. Per fortuna il tumore è benigno, tutto andrà per il meglio – assicurano i medici – ma occorreranno diverse settimane di degenza. E succede un fatto strano: mentre in genitori di Margot la vanno a trovare tutti i giorni, Jean Paul non si fa vivo. E’ partito per una missione urgente di lavoro – la rassicura il padre – ti bacia e presto sarà qui. Passano i giorni, Margot sente man mano tornare le forze, sta riacquistando il suo colore rosato, ma i suoi occhi sono tristi, non più come prima. E trascorre il tempo leggendo le riviste, oppure parlando con i genitori, la mamma le ha portato l’uncinetto dove aveva già cominciato un lavoro. Ma lei ha un pensiero che la tormenta: perchè lui non corre da lei.
Una mattina Margherita capisce che qualcosa non torna, chissà perchè quella mattina non hanno portato i giornali. Arrivano i genitori, li vede con un’espressione strana. La abbracciano in mondo più amorevole del solito. Il padre le sussurra: “ti vogliamo tanto bene, Margot. Adesso hai finito di soffrire”. Lei ha come una fitta al capo, sente un improvviso brivido di freddo salirle lungo tutto il corpo, la vista si appanna, in un istante le corrono per la mente una sfilza di immagini sfuocate, il primo bacio con Jean Paul, il profumo lungo la Senna, Jean Paul svenuto quella prima notte all’ingresso della camera da letto, in un bagno di sudore.
Sui quotidiani parigini, quella mattina, c’era la foto di un giovane di bell’aspetto annegato nella Senna. “Si è dato la morte per debiti di gioco”, così titolavano. L’avevano scoperto, lungo la riva sinistra, un paio di pescatori. E le cronache si soffermavano su un dettaglio: il corpo ritrovato nelle acque del fiume aveva una capigliatura tagliata alla buona, la barba corta. Aveva perso tutto al gioco: anche le chiome fluenti e la barba che curava tutti i giorni.
Per Margot fu una lunga, lunghissima febbre. Rimase per diversi giorni a letto, praticamente senza muoversi. Come se il corpo non ne volesse sapere di rianimarsi, di riprendere il suo cammino quotidiano. La madre le era sempre vicino, la imboccava, la sollevava per le spalle, quasi a rianimarla, le carezzava le guance, ti ricordi il viaggio a Torino – le diceva – quelle belle passeggiate sotto i portici. Lei aveva gli occhi come fermi, a fissare un punto, chissà dove. Le sue labbra ogni tanto parevano muoversi per pronunciare dei suoni, forse un nome.
Trascorsero dodici giorni che sembravano non avere mai fine, un lungo fiume di ore tutte uguali, lo stesso colore delle foglie del Valentino. Poi, una mattina, Margot si aprì come solo le belle di giorno sanno fare, nel loro splendore color ciclamino: hanno paura delle tenebre, si chiudono in un abbraccio, per riaprirsi alle prime luci. Anche le suore e le infermiere che quella mattina accorsero al suo capezzale raccontarono poi di aver visto come un arcobaleno sopra il capo di Margot, bagliori dal bianco al giallo al ciclamino. E quelle parole sbocciarono come petali dalla sua bocca: “voglio rimanere qui con voi”.
E così cominciò la seconda vita di Margot. Forse la prima vita. Forse un’altra vita. Come se il tempo dovesse, per lei, cominciare da capo. Come se tutti i mesi, gli anni precedenti fossero stati scritti e vissuti per condurre a quell’istante.
fine prima parte
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 13 novembre 2016
DOPPIO INFERNO
di Manuela Mazzi
Qualche decennio fa, quando ancora non si era sviluppato il dibattito sulle modalità di ascolto del minore, la Procura di Napoli, in caso di minore vittima di abusi sessuali, si era empiricamente data la regola che il minore fosse ascoltato da un magistrato donna. In tali occasioni ci attenevamo ad un paio di metodologie empiriche così riassumibili: il minore non doveva uscire ulteriormente sconvolto dall’incontro con il pubblico ministero e quindi il campo psicologico doveva presentarsi rilassato, non incalzante e protettivo; qualsiasi messaggio anche indiretto, che potesse essere percepito come suggerimento o aspettativa , doveva essere accuratamente evitato.
Così io e la mia segretaria, una rossa morbida e con la faccia simpatica, accogliemmo Maria, una bambina di nove anni, il cui padre era stato arrestato per violenza carnale (all’epoca) nei suoi confronti. Nel frigorifero c’era l’aranciata e sulla scrivania, sgombrata da ogni carta, un piattino con dei biscottini al cioccolato. La finestra era spalancata sul sole del cortile di Castelcapuano. Maria era una bambina bellissima, con gli occhi chiari ed un visetto delicato incorniciato da corti capelli neri. Era sobria nei gesti ed aveva un portamento signorile che io e la mia segretaria, anche noi incrostate dei nostri pregiudizi, avremmo ritenuto impossibile rispetto al misero ambiente da cui proveniva. L’ascolto andò nel migliore dei modi. La bambina confermò con tranquillità e precisione, ciò che aveva già rivelato alla maestra. Io e la mia segretaria uscimmo da quell’incontro piene di ammirazione nei suoi confronti.
Dopo un paio di settimane fuori dalla porta dell’ufficio mi aspettavano di nuovo la bella bambina e la mamma. Quest’ultima , che anche fisicamente era mostruosa (mi si perdoni, ma non posso evitare di dirlo), mi disse che la bambina doveva dirmi delle cose. Cacciai la madre lontana dalla porta ed accolsi Maria in ufficio. Come la prima volta appariva tranquilla e serena. Chiamai segretaria, biscottini e aranciata. Ci fu tuttavia pochissimo tempo per i preamboli. La bambina si mostrò subito decisa a dire qualcosa. Ancora in piedi vicino alla scrivania, Maria mi guardò negli occhi impavida ed affermò: “Io poi volevo aggiungere che mi piaceva.”
“Che cosa ti piaceva?”
“Quello che mi faceva mio padre.” E poi Maria si denudò una spalla scostandosi il vestituccio, assunse una posa obliqua da vamp dei tempi andati ed aggiunse: “ Io provocavo mio padre. Io lo provocavo.”
Oh certo, Maria è stata allontanata dalla mostruosa madre! Ma di quel terribile gesto cinematografico mi è rimasta addosso una grande pena. Il gesto suggeriva la sequenza di un doppio inferno. Il primo inferno è la violazione del sacrosanto diritto all’innocenza ed all’integrità della propria carne; il diavolo sembra solo uno, anche se i diavoli secondo me stanno sempre in compagnia. Chissà come si arrampica Maria fuori da quel girone interminabile! E’ finalmente fuori! Ed ecco il secondo inferno! Una masnada di diavoli le piomba addosso. Le ignoranti confabulazioni familiari hanno decretato che Maria ha combinato un guaio e che deve riparare. Che deve andare dal giudice e convincerlo che la colpa è sua, perché a nove anni è una puttana, alle cui seduzioni il povero padre non ha resistito.
Ma mi è rimasta addosso anche una grande ammirazione per la coraggiosa bambina. Quel gesto incredibile, secondo me non suggerito dalla massa ignorante dei suoi persecutori, frutto forse di un ricordo televisivo conturbante, esprimeva una potente energia di autoconservazione. Maria ha fatto del suo meglio per modularsi, sopravvivere ed essere lasciata in pace. Questo alla fine fanno tutti i bambini, quando si trovano dinanzi frequentissimi doppi inferni.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 6 novembre 2016
Presagi
di Gordon Poole
Lei girò la testa un po’ verso sinistra, senza distogliere lo sguardo dalla strada.
“A che ora incominciano?”
Egli cambiò la marcia dalla seconda alla terza prima di rispondere, infastidito: “Te l’ho già detto”.
Lei aspettò finché entrarono nella rotonda, procedettero fino alla terza uscita e imboccarono Kilkaney Road. Che fosse il silenzio o il nome della strada, lei sentì un brivido e accostò lo scialle nero più strettamente attorno alle spalle.
“Sì, l’hai detto. Ma non mi ricordo”.
“Non è come se stessimo andando al cinema, lo sai?!”
Accortosi che inavvertitamente aveva superato il limite di velocità, scese un pò al di sotto dei trenta miglia all’ora. Ci mancava soltanto di essere fermati per eccesso di velocità!
“Comunque, il necrologio nel giornale diceva a partire dalle diciotto e trenta.”
Lei scostò la frangia dello scialle per guardare l’orologio. “Sono quasi le sette.”
Lui non rispose. Di nuovo la freccia del tachimetro un po’ alla volta era salito a trentacinque miglia all’ora, come se fosse viva e malintenzionata. Di nuovo egli alleggerì la pressione sull’acceleratore.
Scandendo le parole, disse,“Non ti preoccupare, Kane non scappa!”
Lei fece una smorfia di sofferenza e si guardò le mani che si strofinavano nervosamente l’una contro l’altra, finché le costrinse a smetterla.
Dopo un paio di minuti, lui disse, “Non voglio che arriviamo lì quando non c’è ancora quasi nessuno, capisci?”
Lei annuì, indicando che capiva la logica di quanto aveva detto. “Vorrei che non ci dovessimo andare per niente!”
A questo lui non rispose. Imboccarono Macbeth Highway, dove si poteva aumentare la velocità. Lei sentì un brivido, senza sapere perché. Buttò uno sguardo fuori dal finestrino dal lato suo, proprio quando stavano passando davanti al Last Chance Bar&Grill, dove l’aveva conosciuto per la prima volta.
Egli disse, “Vedi, questa è una di quelle tali funzioni che se ci vai, nessuno ci bada più di tanto. Ti siedi in mezzo agli altri, e neanche ci fanno molto caso. Ma se non ci vai, ecco che si accorgono di te.”
“Così, pensi di aver calcolato tutto, vero?”
“Tu devi solo sperare di sì!”
Dopo una pausa, stropicciando lo scialle con le dita, lei disse, “Spero che avranno qualcosa da bere.”
“Qualcosa da bere?! Questa non è uno di quelle veglie bisboccia dei tuoi parenti irlandesi, tienilo a mente! Questi sono luterani, per amor di Dio! Lui era ebreo, ma si è convertito. Se ci sarà qualcosa da bere, sarà un po’ di brodo di pollo acquoso!”
Avevano abbandonato Macbeth Highway per Findecours Road e raggiunto Vico Rip Van Winkle con il cartello “Via senza uscita” all’imbocco. Trovarono un posto per parcheggiare di fronte al numero civico 13. Era l’ultimo posto libero rimasto. Uscirono dalla macchina, lui la chiuse, e procedettero a piedi fino al numero 17, la residenza di Kane Klein. Fu soltanto quando furono entrati nel vialetto che portava alla porta principale che lei si accorse dell’automobile della polizia parcheggiata nel viale di accesso dall’altro lato della casa con due poliziotti all’interno. Lei afferrò il braccio del suo compagno con un gesto convulso e si fermarono di botto. Ma era ormai troppo tardi.
—————————————————————————————————–
“Go … fix … coffee.”
She stayed, still holding his hand.
With an effort, he spoke again: “Fix yourself some coffee.” It had been several days since he took his last cup of coffee.
 She still stayed, smiling sadly down at him.
She still stayed, smiling sadly down at him.
“You here, I can’t think my long thoughts.”
She nodded compliantly, let his hand fall, and went to make herself some coffee.
His thoughts got longer and longer, began to dwindle. Then they ceased.
“Vai … a fare … il caffè”.
Ma lei non si mosse, e gli teneva ancora la mano.
Con uno sforzo, egli parlò di nuovo: “Fatti un po’ di caffè”. Erano diversi giorni da quando egli aveva preso l’ultimo caffé.
Lei rimase ancora, guardandolo con un sorriso mesto.
“Tu qui … non posso pensare i miei pensieri lunghi”.
Lei annuì, per compiacerlo, lasciando andare la mano, andò a farsi il caffè.
I pensieri di lui si fecero lunghi, e ancora più lunghi, e cominciarono ad assottigliarsi. Poi cessarono.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 30 ottobre 2016
UNA RIMA PETROSA PER IMMA
ED ALTRE POESIE
di Gordon Poole
La genialità di Gordon Poole, politologo di origini americane trapiantato a Napoli da decenni, è nota per le sue stringenti analisi sugli scenari internazionali e la sua lotta senza tregua in difesa della pace. Non tutti conoscono la sua fervida vena poetica.
Per questa domenica Gordon dona ai lettori della Voce alcune sue poesie in lingua napoletana, quasi tutte scritte a cavallo tra gli anni ’80 e primi anni ’90.
Una rima petrosa per Imma
Ched’è? Pe tte mo m’aggio squaquiglià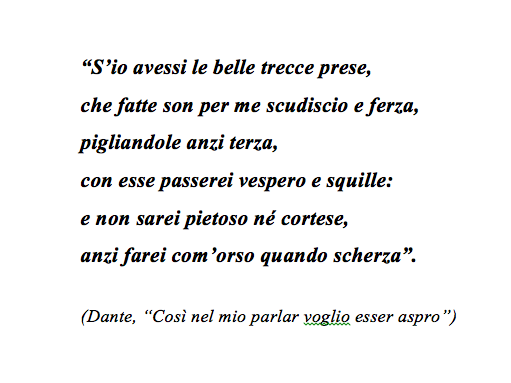
e perdere lu suonno e l’appetito?
E sulo pecché te si’ divertita
a ccagnà core e a te ne ghì a stà
luntano? Ma va fatte spernacchià!
Ca i’ senza premesso e senza ’mmito
te chiavarria a dint’ all’uocchio ’o rito
cchiù piccerillo e lo farria girà.
E mmo te dico appriesso tutt’ ’o riesto:
attiento a tte ca ce sta aria ’e trubbeja.
Si tu te mietti a coppa, sai che farria?
Pe niente te squinternarria ’a veste,
te muzzecarria ’a vocca e ’a vasarria
com’ a ’n urzo peluso che pazzèa!
A Eva Uva
Comm’ a le pire quanno so’ maturi,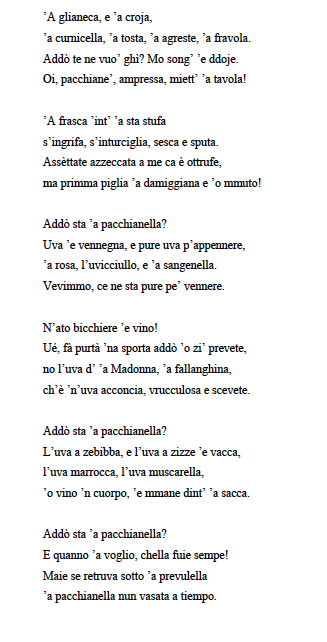
accussì e ’core nuoste ’o tiempo ’e tanno
cadeano ’nterra senza ’o turceturo,
e i’, speranno pe’ me fà squasià,
’ncoppa ’o campo, spierto, ievo truvanno
’a vocca toia pe’ me fa muzzecà.
Mmo vene ottrufe, ’o cielo se fa scuro,
ma ’o core mio nun pere pe’ aspettà,
e spera ’n anno, ’n anno e poì ’n at’anno.
20/7/1985
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 23 ottobre 2016
di Manuela Mazzi
I due racconti che vi proponiamo questa settimana sono tratti da un numero storico della Voce, quello di luglio del 2001. A firmarli è ancora Manuela Mazzi, oggi avvocato, a quel tempo pubblico ministero di prima linea a Napoli.
Il primo ci conduce dentro una fiaba, metafora come sempre del tempo e dei nascosti, umani sentimenti, attraverso la storia del folletto Hob e del suo incontro col Misantropo.
Il secondo è un flash sui muri, quei muri a secco che dividono invece di unire i popoli e le persone.
Qui il pdf con le pagine originali della Voce luglio 2001.

…………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 16 ottobre 2016
L’ULTIMA TELEFONATA
di Manuela Mazzi
Si parla di una donna che si è gettata con la macchina giù dalla scogliera; si dice che non è stato un incidente, perché c’è chi ha visto la macchina ferma dinanzi al baratro, prima che, con una marcia rabbiosa, l’utilitaria si avventasse contro quel muretto basso, che era stato lasciato così perché nulla impedisse alla vista del mare di invadere la strada.
La stessa persona sarebbe accorsa, mentre la macchina rimbalzava tra le rocce.
Se la donna si era immaginata un tuffo disperato ma profondo nella distesa di acqua che luceva sotto la luna, non c’è riuscita; la macchina si è incastrata tra una roccia ed un declivio sabbioso in posizione perfettamente orizzontale.
Prima di innestare la marcia verso il baratro è stata vista telefonare; poi ha acceso la luce del cruscotto e si è truccata le labbra.
Dopo, ha riacceso il motore.
Ieri sera ad una cena si parlava oziosamente del fatto e tutti erano concordi nel dire che quella telefonata terribile doveva essere stata d’amore.
Un amico giornalista ha mostrato di saperne di più e, quasi sottovoce, ci ha raccontato che la polizia è risalita all’ultimo numero chiamato dal cellulare.
Era effettivamente quello di un uomo, che ha ammesso che da poco si era esaurita una storia con quella donna e che lei non si era rassegnata.
La telefonata era durata dodici secondi.
Si è congetturato molto, sorseggiando il wisky, su quante parole devastanti possono essere espresse in quella manciata di tempo.
C’è stato chi ha obbiettato che è la mansueta cautela delle parole pietose a ferire più profondamente.
L’uomo aveva affermato di non avere comunque ricevuto alcuna telefonata.
Nessuno gli aveva creduto.
Io sì.
Conosco quella rupe e so quello che vi succede, perché una volta anche io mi fermai là per una telefonata solitaria.
Posso quindi arrogarmi, per quel che allora sentii, il diritto di fare un resoconto e di giurare che è andata così.
La donna formò il numero.
Aveva la bocca spalancata per spingere nei polmoni l’aria che non voleva entrare.
“Ciao, come stai?”, chiese.
La voce che le rispose era lontana: “Come stai?”
Distorta dalla distanza, ma forse affettuosa.
“Io bene”, rispose lei, abbandonando la testa sullo schienale per cercare le parole successive.
“ Bene“, rispose la voce, trasmettendole un brivido di disagio.
“Sai, volevo dirti che…”. Esitò. Era calato un muro , che le impediva di trovare le parole che aveva già cercato.
Ma la risposta arrivò. Metallica e vibrante, come uscita da una cupola di ferro percossa sul fondo del mare.
“Sai volevo dirti che…”
Avrà gettato il telefono a terra o lo avrà chiuso di scatto? Serrato le labbra o gridato, quando si è resa conto che quella voce era solo l’eco della sua.
Che era lei a chiedere e rispondere.
Come se un pianeta deserto rimandasse il grido dell’unico vivente e questi allora si accorgesse che attorno a lui c’era solo acqua e pietra.
Io provai l’enigma di un’eternità solitaria: gettai il telefono a terra ed accesi la radio a tutto volume.
Poi , con una retromarcia convulsa, abbandonai la rupe.
Riesco perfino ad assaporare quel momento ed a ritrovarvi la vastità sconosciuta da ultimo istante dell’attesa, come se fossi ad un passo dal capire di quale cosa quella situazione fu simbolo.
Lei, attonita, si truccò le labbra ed anche lo specchietto le rimandò il solo eco del suo volto pallido.
Troppo invadente fu quell’attimo per la sua volontà fiaccata dalle ossessioni. Si abbandonò all’oblio di sé e la attrasse l’abisso dentro cui la sua voce si era perduta.
Complice di questo, penso, fu il bianco demone generato dalla luce della luna.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 9 ottobre 2016
La prigione. Quella che ci danno gli altri. Quella che tante volte ci diamo noi stessi. Per la paura di scappare, per il timore di ribellarci, per non andare incontro al nostro destino. Che spesso è il vuoto assoluto della solitudine. C’è tutto questo, ma c’è anche la mano dell’investigatrice di razza nel bel racconto di Manuela Mazzi, toscana d’origine, napoletana di adozione, per anni pubblico ministero impegnata in delicate indagini di camorra, poi passata al non meno incandescente ruolo di pm degli affari civili. Quegli ‘affari’ che, appunto, spesso vedono in gioco la vita, e la morte, dei minori.
PRIGIONI FAMILIARI
di Manuela Mazzi
Tenevo la bocca aperta e guardavo la parete di fondo come mi aveva insegnato mio padre. Ogni tanto dondolavo la testa, come se fosse una zucca vuota. Quando lo sguardo del giudice scivolò su di me per un attimo, solo per un attimo, lo guardai negli occhi sperando che cogliesse in quello sguardo furtivo la consapevolezza disperata che avevo che d’allora in poi la mia vita non sarebbe più stata mia.
Il giudice mi sorrise benevolo e chinò la testa per scrivere.
Fuori dalla sua porta mi gettai a terra a faccia in giù; battevo gomiti e mani sul pavimento ed urlavo così forte che la gola mi faceva male ed alla fine le mie grida sembravano quelle di una cornacchia.
Il giudice si affacciò e con un gesto tranquillizzò mio padre, che cercava di rialzarmi e si scusava.
Fuori dal Tribunale dei Minorenni mio padre mi sussurrò all’orecchio: “Brava!”
Avevo diciassette anni ed ero stata interdetta.
La mia storia alla fine è molto semplice, è quella che i giornalisti definiscono “di ignoranza e di miseria”. I protagonisti sono un padre fannullone e violento, una madre accondiscendente e silenziosa, un figlio maschio che urla e sbatte la porta quando la madre vuole accarezzarlo, una figlia più piccola timida e taciturna, a cui inspiegabilmente piace leggere.
Una sera il padre rientra da uno dei suoi vagabondaggi inconcludenti, canticchia, fa un cenno verso di me e dice, rivolto alla moglie: “Sempre con quei libri. Mi sembra scema. C’è uno che ha un figlio scemo, l’hanno interdetto e a lui gli hanno dato una pensione.”
E lì mia madre risponde: “Beati loro.”
Il mio addestramento dura un pomeriggio; mio padre mi insegna a tenere la bocca aperta, a guardare il pavimento o il soffitto, a fare qualche verso con le labbra, a dondolare la testa come se avessi il collo di gomma, a camminare ingobbita, a cercare sempre la mano di mia madre. E soprattutto a stare zitta, cosa alla quale sono già abituata.
Passiamo l’esame della commissione per l’invalidità, io ho dodici anni (deficit mentale grave), passiamo l’esame davanti al giudice ed io sono ufficialmente interdetta. Tutore mio padre.
Da quel momento ogni controllo è finito, la pensione arriva regolarmente e mio padre la riscuote e la spende.
 Io sparisco. Questa è l’unica condizione.
Io sparisco. Questa è l’unica condizione.
Sparisco dalla scuola, dalle amiche, dalle chiacchiere, dai concerti, dal cinema, dalle passeggiate, dagli innamoramenti, dal telefono… la lista è totale. Sparisco da tutto quello che c’è e da tutto quello che sarebbe arrivato.
Solo qualche volta mia madre mi manda a prendere il pane e si raccomanda che io alla bottega lo indichi con un dito e mi faccia prendere i soldi dal palmo della mano, perché la gente è invidiosa.
Vado a servizio da una vecchia che vive da sola al piano di sopra.
E’ una vecchia che urla e vaneggia ed io urlo e vaneggio con lei. Le piacciono le storie, quelle di fantasmi, ed io invento storie terribili di fantasmi con le unghie di tigre che sbranano intere famiglie, di fantasmi con le orbite vuote, perché da vivi gli furono tolti gli occhi, che seguono l’odore della gente, di fantasmi bambini che uccidono i genitori… anche le specie di fantasmi sono infinite.
Così la vecchia sta buona e per questo a volte l’abbraccio e la bacio.
Ogni mese la figlia porta a mia madre quattrocentocinquanta euro.
In totale con la pensione rappresento per la mia famiglia una rendita mensile di milleduecento euro. C’è anche il vantaggio che, con la vita che faccio, non spendo niente per me.
Ma perché non mi ribello?
Le ragioni sono tante ed anche confuse.
La prima che mi viene in mente è il timore di essere equivocata e di peggiorare quindi la mia condizione. Fuori dalla porta del giudice io mi ribellai. Ma tanto era l’affanno che mi stringeva il respiro, tanta la paura, tanta era la confusione di agire, che la mia ribellione fu un grido inconsulto, un agitare di piedi e mani, che alla fine confermò le diagnosi frettolose che mi avevano riguardato e mio padre mi disse: “Brava.”
Ma la più importante è che amo mia madre. Lei è buona con me. Fa la cresta sulla spesa per comprarmi i libri ed i quaderni su cui scrivo i miei pensieri. E’ la mia guardiana, forse anche il mio carnefice, ma è anche la vittima di mio padre. Le sbarre che mi ha confezionato grondano delle sue lacrime e delle mie mischiate assieme.
Divide la meschinità della mia esistenza.
La terza ragione è che ora ho paura ad uscire.
Ho venticinque anni e finalmente la madre che ho tanto amato è morta. Ora sono sola in casa, proprio sola.
Ma dal fornaio indico sempre il pane con l’indice ed il pianerottolo è ancora un limite invalicabile.
Ormai potrei continuare così per sempre e sono tentata di farlo.
Potrei organizzarmi per comprare i libri in un altro quartiere, facendo la cresta sulla spesa; quando la sera sbircio giù nella strada e vedo i motorini che si rincorrono e le ragazze che ci saltano sopra al volo, i ragazzi che fanno i galletti, e quel rombo delle marmitte e la musica degli stereo e le fiammelle degli accendini ed il vocio, le grida… mi ritraggo colpita da tanta violenza.
Ma poi succede una cosa… una cosa che è un’altra storia ancora… che forse poi racconterò.
Ed allora una bella mattina, una bella mattina piovigginosa con l’acqua e la bruma che velano l’immagine dei negozi e delle strade, indosso il vestito più bello di mia madre, un tailleur grigio che fa chic, comprato con la mia pensione, le sue scarpe con i tacchi dei matrimoni, mi metto anche il rossetto, scompiglio i miei capelli ricci e neri ed esco. Barcollo un po’ sui tacchi a cui non sono abituata, inforco anche gli occhiali da sole e il mondo diventa buio, ho scordato l’ombrello e l’acqua mi inzuppa i capelli, mi bagna la faccia e forse impiastriccia il rossetto. Ma cammino impettita (altro che gobba, papà) e ad un certo punto dondolo anche la borsa.
Incespico sulle scale della caserma dei carabinieri, il piantone mi prende per una battona, l’appuntato per una drogata. Ma io con voce ferma ripeto: “Voglio parlare con il vostro capo”.
Mi fanno aspettare su una panca ed io sento crescere il panico dentro di me e penso che, quando sarà il momento, riuscirò solo ad urlare e a buttarmi a terra, come davanti alla porta del giudice.
Il capo mi riceve; seduta davanti a lui cerco le parole. Sembra un tipo paziente, non mi mette fretta.
In qualche parte segreta del mio cervello c’è tutta la storia che voglio raccontare; è lucida, nitida, ma si è acquattata e non esce. Per fortuna non escono neppure rantoli, urletti o cose simili.
Sì, il capo è paziente, il mio silenzio non lo irrita. Anzi, ad un certo punto, il vecchio volpone di carabiniere dice: “Signorina, se vuole mi può raccontare una storia di un’altra persona e mi può anche non dire il nome”.
“Come la storia di un libro?”, chiedo io.
“Sì, proprio come la storia di un libro”, risponde lui.
Ed io comincio: “C’era una bambina di dodici anni che ora è una ragazza di ventisei anni…”.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
I Racconti di Domenica 2 ottobre 2016
RESISTERE AI NANI DA GIARDINO
di Luigi Vivese
Se stai leggendo questa lettera sei fortunato: hai buone probabilità di salvare la tua vita ed evitare l’orrendo destino riservato ai tanti che ignorano quanto sto per raccontarti.
Vogliono ucciderci tutti! Nel segreto dei loro covi, stanno progettando un nuovo ordine mondiale… senza noi umani. Stanno pianificando di invadere le nostre case. Ci hanno circondato. Si nascondono in piena vista, nei luoghi dove giocano i nostri figli, intorno a noi.
La loro macchina propagandistica è potente ed efficace. Da tempo sfruttano i mezzi di comunicazione per trasmetterci un immagine di loro amichevole e tranquillizzante. Il loro successo più grande è stato riuscire a spacciarsi per simboli di bontà e allegria. Ma il vero capolavoro mediatico è stato farci credere che tenerli nei nostri giardini porti fortuna.
So che è difficile crederci ma i nani da giardino vogliono sterminare l’umanità, eliminandoci uno alla volta. Se vivi in città probabilmente dovrai aspettare anni prima di ritrovarti a fronteggiarne uno in un corpo a corpo. Ma se vivi in campagna è solo questione di giorni, forse di ore. Quindi non importa dove abiti, sei comunque in pericolo di vita.
Ma ora che sai, puoi salvarti se avrai la pazienza di leggere fino in fondo.
Prima di continuare, assicurati che porte e finestre siano ben chiuse.
La prima cosa da fare è armarsi. Prendi un taglierino, mettilo in tasca e tienilo sempre con te. Senza sarebbe difficile sopravvivere all’attacco di un nano di giardino.
Se dovessi incontrarne uno, magari nel giardino di un amico, ricordati sempre di non dargli mai le spalle. I nani sono codardi: attaccano sempre e solo alle spalle. Se ciò dovesse capitare, tira calci da tute le parti, con un po’ di fortuna basterà un calcio ben assestato per spedire il nano assassino all’altro mondo. Ma se non dovesse bastare recupera il taglierino e finisci il lavoro in fretta, prima che si riprenda. Se hai dimenticato di portare con te il taglierino e stai soccombendo hai un ultimissima possibilità: buttati su di lui a peso morto. Se non sei troppo magro, questa mossa, con un po’ di fortuna lo stordirà il tempo di fuggire.
Anche se nei prossimi giorni non dovessi incontrarne, non significa che sei al sicuro. In questo preciso istante da qualche parte c’è un nano che sta già cospirando contro di te. E’ solo questione di tempo. Prima o poi verranno a prenderti. Non puoi fare nulla per impedire che accada. Ma quando accadrà ci saranno dei segnali premonitori: ti sentirai osservato e gli animali domestici si comporteranno in modo strano. Altri segni rivelatori di un imminente attacco, saranno tracce di piccole impronte e la sparizione della cassetta degli attrezzi. Ma soprattutto il presagio è quell’ombra che si allunga sul prato.
Quando tutto ciò accadrà dovrai farti trovare pronto.
Lascia in giro per casa bevande avvelenate e trappole costruite usando una comune colla per topi. Di vitale importanza sarà munire ogni ambiente di un’arma. Un coltello ben affilato o un martello sono pratici e poco ingombranti.
Trasforma la tua casa in un fortino inespugnabile. Armati fino ai denti. Preparati ad una vita di ordinaria resistenza. E ricorda che l’unico nano portafortuna è un nano morto.
MIMI’ SI SENTIVA MENO SOLO
di Luigi Vivese
Come ogni giorno, andava su è giù per la banchina del binario 3 della Stazione Ferroviaria di Mergellina. Quella bella, quella liberty da morire, quella dalle decorazioni a stucco, dalle colonne sporgenti, dalla pensilina a sbalzo in ghisa Romantica, dal bugnato rustico e dall’orologio sorretto da angeli. Dormiva da tre anni nei saloni interni. Sistemato nel suo giacinto di cartone, preferiva la sala centrale, adibita a punto di ristoro. Ma quando pioveva si spostava, a sinistra, nel più riparato salone degli arrivi, mentre d’estate sceglieva il più fresco salone delle partenze. Sarà stato per la volta a botte cassettonata, o per il pavimento marmoreo, ma Mimì si sentiva fortunato a dormire li. Ci aveva provato a spostarsi nei più moderni e riparati metrò dell’arte, ma quell’austera bellezza d’antan gli mancava troppo. Mimì non riusciva più a vivere lontano da quell’angolo di Napoli dall’inconsueto fascino parigino.
Di giorno Mimì si spostava sotto la pensilina liberty in ghisa, in fondo al binario 3. Anche perché la scelta non era più ampia come una volta. Originariamente, infatti, i binari erano in tutto sei, ma a seguito delle opere di “ammodernamento” i vecchi binari 1 e 2 sono stati totalmente rimossi ed eliminati.
Mimì parlava, da solo, con voce alta e squillante. Ma non erano i deliri di un pazzo. Erano discorsi compiuti e pieni di buon senso. Talvolta erano discorsi dotti, talvolta vere e proprie filippiche di grande spessore morale. Spesso cominciava grandi dibattiti con un lampione.
Indimenticabile quando guardando una coppia di fidanzatini in partenza che si salutavano con un appassionato bacio, esclamò: “si vive d’istanti e d’istinti ! ma anche distanti e distinti”.
Entro nella soria quando ad un passante visibilmente eccitato dal decolté della donna che l’accompagnava sussurrò : “L’erezione è come un regalo, alle volte basta il pensiero.”
Divenne leggenda quando, sentendo un ragazzo spiegare alla sua donna l’importanza di avere suoi spazi e della sua autonomia, si avvicino alla coppia e serio esclamò: “Chissà cosa avrebbe risposto Biancaneve se il principe azzurro dopo averla baciata le avesse detto che non voleva una storia seria.”
Era irresistibile quando corteggiava l’immagine di una bella donna stampata su un cartellone. Conquistò il cuore delle donne che ebbero la fortuna di ascoltarlo quando rivolgendosi all’immagine di Belen disse con voce suadente e sensuale: “voglio essere, per te, un dettaglio. Quel dettaglio che migliora. Lo zucchero a velo sul croissant, la panna sul caffè, il pezzo preferito di una canzone, il ciondolo di un braccialetto. Non voglio essere essenziale, perché non c’è nulla di cui in realtà non si possa fare a meno o non possa venir sostituito.. Voglio essere solo un dettaglio.”
Mimì aveva qualche rotella fuori posto, ma non era pericoloso. Non aveva mai fatto male a nessuno, ma la gente ne aveva ugualmente paura. Come quando si ha paura di qualcosa che non si conosce o non si capisce. Nelle ore di punta, quando la stazione brulicava di pendolari, intorno a Mimi c’era sempre del vuoto. Solo pochi avevano avuto la fortuna di conoscerlo bene e avevano per lui parole di comprensione e affetto. Ma per i più era solo un barbone.
Mimì da un po’ si sentiva meno solo. Da qualche anno sulla banchina erano comparsi diversi compagni di strada. Altre anime vaganti che, con lo sguardo fisso nel vuoto, parlavano al vento. Ruotavano su se stessi, seguivano percorsi astrusi, gesticolavano ampiamente…
Erano diversi da lui. Se interrogati non rispondevano. Non guardavano in faccia a nessuno… Gli occhi fissi nel vuoto. Procedevano ignari di quanto succedeva intorno. Nulla poteva distoglierli dalle loro conversazioni. Chiusi in se stessi e nelle loro miserie quotidiane.
Mimì aveva invece una particolare capacità di capire qual’era la linea da non superare. Percepiva quando stava diventando ingombrante. I nuovi compagni non avevano la stessa sensibilità. Erano molto invadenti e meno garbati di Mimì.
Mimi aveva studiato con cura questi nuovi compagni. Li aveva osservati a lungo. Aveva anche cercato, invano, un contatto. Erano di tutte le età: giovani e vecchi. Erano donne, uomini e ragazzi. Oltre a quell’insolito comportamento avevano poco in comune tra loro, tranne un sottile filo che usciva dalle orecchie talvolta fino a una scatolina, con dei tasti e un piccolo schermo, tenuta spesso in tasca.
Ma anche se non li capiva poco importa… Mimì da un po’ si sentiva meno solo.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 25 settembre 2016
QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA CANI
di Andrea Cinquegrani
Siamo usciti come tutti i pomeriggi. Ci guardiamo negli occhi lui fa un cenno appena con la testa e io sono già fuori.
Capita sempre così, basta un piccolo cenno e io so quello che mi vuol dire so cosa c’è nella sua testa. Come quando è nervoso o non gli va qualcosa. Sento una sua parola e ho già capito, lo vedo come camminare e so che qualcosa non va. Come quando mi sta a fianco, schiena contro schiena e ci capiamo in un movimento. Basta un soffio.
Quel pomeriggio c’è il sole, è la nostra ora di libertà ci mescoliamo con l’aria gli odori i colori io sento il suo lui sente il mio siamo sempre una sola cosa.
Non so proprio perchè tanti dicono ‘queste sono stronzate’, ci chiamano bestie animali cani gatti. Mi ricordo una volta, una signora dice ‘ma guarda quanto si amano non sei gelosa?’ e l’altra ‘ma se è solo un cane!’. Quella volta lo giuro mi sono incazzata e mi sono detta gliela faccio vedere io. Ma è possibile che abbiano il cervello di una gallina? scusami gallina non ti volevo offendere. La pensano così, ho riflettuto, c’è poco da fare non li convinci neanche con mille discorsi. Hanno la testa quadrata e non puoi fargliela diventare tonda nemmeno con un colpo di bacchetta magica come capita eppure con le zucche.
Il sole picchia l’erba verde mi piace ha il profumo di bagnato quei papaveri poi sono la fine del mondo.
Io non so perchè mi ama io non so perchè lo amo ma ci amiamo. Adesso è bello tutto ogni momento quello che mangio quello che lui mangia quello che odoro quello che lui odora quello che guardo quello che lui guarda. Come mescolarsi non sai dove c’è uno o l’altro. Mi ha letto un articolo di una tipa che diceva in un libro ognuno deve stare al suo posto, i cani fanno i cani le persone le persone, mi pare non ha capito niente di noi e di tante cose.
C’è quel prato di girasoli ai bordi nella collina un vero spettacolo. E il vento comincia a soffiare non senti altri rumori e mi sento una regina.
Gli dicono che ha un comportamento strano dovrebbe andare più in giro fra la gente al cinema o a ballare. Lui se ne frega fa quello che gli pare caso mai legge per ore o scrive o vede due film uno dopo l’altro. Quei pochi che vuole vedere li sceglie lui. Anche io faccio così, mi piace fare le cose che fa lui perchè le faccio con lui quello che mi va è stare con lui. E penso che per lui è lo stesso. Ma gli altri dicono che lui è strano…
Si comincia a vedere la rotaia sembra un vecchio addormentato stanco arrugginito, chissà da dove viene dove va quante persone ha fatto viaggiare nella sua vita.
Mi sembra ieri la prima volta, io ero arrivata a casa piccola piccola lui non mi aveva quasi guardato. Mi sentivo strana non sapevo cosa fare dove andare mi giravano le cose intorno. Come dopo un lungo viaggio eppure per me era il primo e poi è stata tutta una musica quando balli e non ti fermi più e continua il valzer quel danubio ti dondola lungo le acque del fiume e tu ti fai portare e ti rassereni man mano poi ti svegli e ti riaddormenti piano, e lui schiena a schiena.
Corro lungo i binari rossi di ruggine sento quella musica si fa man mano più forte e più forte e copre gli altri rumori…
Mi tengono fermo, sono in quattro, uno camice bianco uno bianco e chiazze rosse due in jeans una maglietta e bretelle, tre hanno la faccia grossa e le vene al collo grosse. Mi gira la testa mi sembra tutto mi gira intorno mi viene da vomitare ho la lingua che non ho più saliva il cuore va a duecento. Sono le quattro di pomeriggio.
Stavo bene ma adesso sto male non so che succede il terremoto le cose girano e non riesco più a capire le cose.
Vedo le loro facce che sono su di me occhi aperti spalancati grossi rossi. Sento le loro parole che però non solo parole grugniti dammi questo dammi quello tienilo così.
Mi fa male tutto le forze mi mancano. Stavo meglio una settimana fa un mese fa e anche ieri che stavo uno schifo in quei quattro metri, tieni mangia una scodella di roba e via. Almeno non soffocavo così.
Vedo gli occhi di quello bianco e rosso, li ho visti altre volte quando mi venivano vicino per guardarmi come un marziano, cosa gli ho fatto perchè mi guarda così che colpa ho sono stato abbastanza buono in questi mesi.
Tre anni fa era bello ma è finito mi hanno imballato come un mobile vecchio. Prima era bello andavo in giro facevo quello che mi pareva mangiavo bevevo andavo con gli amici. Poi zac.
Guardo l’altro che mi guarda strano. Non so che ha non sta bene neanche lui. Ha gli occhi diversi non so che ha forse non è amico degli altri e gli altri gli stanno facendo qualcosa. Io mi sento male ma anche lui non sta bene.
Appena nato era proprio bello, eravamo tanti il latte era buono e subito a fare passeggiate.
Mi stanno tirando, vedo più vicini gli occhi di quell’altro gli dice fai presto mi fa male sento una cosa come un calcio in pancia gira tutto.
Era meglio tre giorni fa che non girava tutto così. Era bello quando sentivo l’odore delle pizzerie, quella nuotata l’anno scorso a Bagnoli eravamo in quattro e poi ci siamo presi il sole e tutto il tempo a rotolarci.
Dio che male, è come mi hanno raccontato gli amici finiti sotto un’auto. Ma perchè lui non mi aiuta non fa niente anzi mi fa peggio cosa gli ho fatto e gli altri tre stanno a guardare anzi due mi tengono fermo e l’altro è sempre strano.
Era meglio anche quel periodo là dentro tutto il giorno e poi veniva quello con l’acqua gelata che a pensarlo mi vengono ancora i brividi e poi quello che buttava lì la scodella e poi l’altro che aveva la faccia di un poliziotto.
Sento un odore che mi fa schifo e tutto bagnato, ho fatto sicuro la pipì come mi succedeva sempre da bambino che poi stavo tutta la notte zuppo ma mi piaceva perchè le stelle mi guardavano e io guardavo loro.
Quasi non mi sento comincio a sognare mi sto addormentando mi sento andare giù giù giù come alcuni amici raccontano in aereo giù giù.
Giù.
dedicato a Marco Frangipani, 33 anni, morto il 21 aprile con i suoi due barboncini, travolti da un treno a Bellaria. E a un pastore tedesco ucciso per vivisezione: Bruno Fedi vide i suoi occhi piangere prima di morire.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 17 settembre 2016
LA ROBA DI NATALE
di PEPPE LANZETTA
Il Bronx di Peppe Lanzetta vestito a festa. Il Capodanno tra le Vele. L’atmosfera è già tutta nell’incipit: “I capitoni erano nella vasca da bagno. Prima d’ammazzarli li avevano lasciati illudere ancora un po’”. Un 31 dicembre tragico, Michele muore per overdose (“ancora poco e avrebbe visto l’inizio del nuovo anno per il quale aveva fatto tanti bei propositi”). La sua ragazza, Antonella, è disperata: “aveva gli occhi bruciati dalle lacrime. Stringeva in bocca un nodo che aveva fatto al fazzoletto e lo morsicava continuamente”. Poi “aprì la sua finestra con l’aria di uno che avrebbe voluto buttare giù tonnellate di cose cattive, ricordi, vetri, sparare botti, vomitare odio contro l’Umanità. L’ultima cosa che guardò fu l’accappatoio azzurro di Michele”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 11 settembre 2016
LE SAMARCANDE DI NAPOLI
di PEPPE LANZETTA
Due monologhi, due sberleffi firmati da Peppe Lanzetta. Il Peppe col basco verde ai tempi della Samarcanda di Michele Santoro, 1989.
I due monologhi, “Il fumo” e “’O semaforo” facevano parte di uno spettacolo portato in giro per l’Italia, tappa d’obbligo Napoli, nel mitico teatro Sancarluccio.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 4 settembre 2016
BASTARDA NEW YORK
di Peppe Lanzetta
Se le testa ti brucia e muori ogni giorno nel bronx napoletano, l’unica via di fuga per qualche istante è volare nel bronx a stelle e strisce, l’originale.
“Pensavo alle tonnellate di hamburger e alle montagne di patate fritte”, “pensavo ai pompini delle negre ferme nei drive in”, “pensavo ai chilometri di pasta dentifricia che gli Americani tutte le mattine spalmavano sugli spazzolini”, “pensavo a tutte le siringhe usate e abbandonate a NY”, “pensavo che la cosa più triste in NY sia non avere un amico, un conoscente a cui poter dire: questo è il mio numero, chiamami quando vuoi”.
Un Lanzetta in piena forma, quello di “Bastarda New York”.
nella foto Lenny Bruce e a destra Peppe Lanzetta
——————————————————————————————————————————————————-
Il Racconto di Domenica 28 agosto 2016
GIRUZZO TENE ‘O ZUCCHERO
di Peppe Lanzetta
La tragica storia di “Giruzzo” tutta in napoletano “verace” quella raccontata da Peppe Lanzetta. Il dolore di una madre che perde il figlio di appena vent’anni, una droga che ti uccide e una città che non ti lascia scampo.
“Dduje uocchie comme ‘a dduje fari… chi s’o aspettava ca’ a 20 anni l’eva truva’ muorto dinto ‘o cesso, cu ‘a capa ‘ncoppo ‘o lavandino, ‘o pizzo a riso, ancora chill’ago dint’o raccio, ‘o filo ‘e sanghe ‘ncoppa ‘a cammisa e ‘a faccia soja nera comme ‘a paura”.
E’ la Napoli del Bronx, quella dipinta da Lanzetta con l’inchiostro del sangue, tutti i morti per overdose, vite spezzate, i senzasperanza, ogni giorno uguale all’altro, un cielo sempre nero, il sole impazzito.
“Ma si stammo durmenno nun ce scetate… pecche’ ca’ ‘nterra gia’ nun se dorme cchiu’…”.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 21 agosto 2016
COMME COCE ‘STA CITTA’
di Peppe Lanzetta
Tre imperdibili poesie di Peppe Lanzetta pubblicate per la prima volta su La Voce della Campania di luglio 1989
—————————————————————————————————————————————————–
Il Racconto di Domenica 14 agosto 2016
JOHARA JOHARA
di Peppe Lanzetta
Le esistenze di Slim e Najib nel racconto di questa domenica per la penna di Peppe Lanzetta. Tragiche storie scritte quasi trent’anni fa, nell’estate ’89, e più che mai vive oggi, con i drammi dei migranti quotidiani, dei barconi, delle vite nei ghetti del grasso occidente. “Slim a Dakar aveva lasciato Johara, la sua fidanzata. Le aveva promesso che a Napoli sarebbe diventato ricco, avrebbe fatto fortuna e se la sarebbe sposata”.
 Non potrà più vederla, la sua Johara, i suoi occhi bruceranno in quel fuoco che gli appiccheranno gli accoglienti amici di piazza Garibaldi. “Quando gli diedero fuoco bruciò tutta l’Africa. Piansero tutti i bambini denutriti, le madri in pena, le fidanzata, le donne, i figli che non sarebbero mai nati. Fu trovato il giorno dopo. Carbonizzato quasi cenere. Irriconoscibile. Nessuno avrebbe mai saputo niente. Un negro in più, uno meno, chi vuoi che se ne sarebbe accorto nella grandecasbah della Ferrovia napoletana. Mentre a Dakar Johara guardava le stelle…”.
Non potrà più vederla, la sua Johara, i suoi occhi bruceranno in quel fuoco che gli appiccheranno gli accoglienti amici di piazza Garibaldi. “Quando gli diedero fuoco bruciò tutta l’Africa. Piansero tutti i bambini denutriti, le madri in pena, le fidanzata, le donne, i figli che non sarebbero mai nati. Fu trovato il giorno dopo. Carbonizzato quasi cenere. Irriconoscibile. Nessuno avrebbe mai saputo niente. Un negro in più, uno meno, chi vuoi che se ne sarebbe accorto nella grandecasbah della Ferrovia napoletana. Mentre a Dakar Johara guardava le stelle…”.
Lanzetta racconto giugno 89
————————————————————————————————————————————————————
Il Racconto di Domenica 6 agosto 2016
CASABLANCA
DI PEPPE LANZETTA
 Un’altra imperdibile “bronx story” per la penna di Peppe Lanzetta nel racconto di questa domenica. I sogni di “Lisa Gastoni”, al secolo Alfredo ‘o benzinaio, per raggiungere la bollente Casablanca e diventare quello che da sempre sente di essere. Condivide le sue speranze con “Paola Di Liegi”, alias Ciro. Un autentico viaggio della speranza, che così coloriva alla madre: “andiamo a Madrid a vedere la Corrida e forse ci allunghiamo pure a Lourdes”. E la madre gli suggeriva: “se vai a Lourdes portami un po’ d’acqua santa che io ce la spalmo sulle gambe di tuo padre, e vuoi vedere che la Madonna si impietosisce e ci fa la grazia?”. Un popolo da sempre in attesa di grazie, quello del Bronx. E non solo quello…
Un’altra imperdibile “bronx story” per la penna di Peppe Lanzetta nel racconto di questa domenica. I sogni di “Lisa Gastoni”, al secolo Alfredo ‘o benzinaio, per raggiungere la bollente Casablanca e diventare quello che da sempre sente di essere. Condivide le sue speranze con “Paola Di Liegi”, alias Ciro. Un autentico viaggio della speranza, che così coloriva alla madre: “andiamo a Madrid a vedere la Corrida e forse ci allunghiamo pure a Lourdes”. E la madre gli suggeriva: “se vai a Lourdes portami un po’ d’acqua santa che io ce la spalmo sulle gambe di tuo padre, e vuoi vedere che la Madonna si impietosisce e ci fa la grazia?”. Un popolo da sempre in attesa di grazie, quello del Bronx. E non solo quello…
leggi qui il racconto in pdf
————————————————————————————————————————————
Il Racconto di Domenica 24 luglio 2016
‘NA SERA ‘E MAGGIO
DI PEPPE LANZETTA
Intorno al 1980, nella Napoli caotica di un terremoto che non sarebbe mai effettivamente terminato, stava crescendo il talento artistico di un giovane delle periferie che sapeva già coniugare perfettamente in se stesso il grande attore con il poeta, l’affilata ironia di stampo partenopeo con l’esterrefatta osservazione del mondo, capace di superare ogni latitudine per connettersi con quella dei suoi coetanei in ogni angolo del pianeta. Si sentiva portato per grandi cose, Peppe Lanzetta, che dal suo bronx neapolitano allungava lo sguardo lontano, verso l’America dei grandi one man show, lungo un inedito asse Secondigliano New York che passava attraverso giganti come Lenny Bruce, ma tornava inevitabilmente a schiantarsi con le miserie e l’abbandono di una Napoli dove tutto è estremo.
Il suo straordinario talento non sfugge a geniacci della tv come Maurizio Costanzo e Michele Santoro, che lo vogliono personaggio fisso dei loro talk. Arriva la popolarità, un successo che va oltre le aspettative. Ma lui, Peppe, sente che può fare di più. E così, già da sempre autore dei suoi testi teatrali, in maniera quasi naturale entra nel mondo della letteratura. Prima come autore di racconti sulla Voce poi, anni dopo, dalla porta principale, firmando romanzi quali l’indimenticabile Giugno Picasso, vero come è vero l’amore, che nel 2006 gli varrà il Premio Domenico Rea.
E’ nel 1989 che Peppe Lanzetta pubblica il suo primo racconto per la Voce della Campania. Siamo ad aprile, si avvicina la chiusura del campionato di calcio – il sangue nelle vene dei napoletani – e Peppe immagina il futuribile 2023 in cui la squadra partenopea vincerà nuovamente uno scudetto.
A quel primo racconto nel seguiranno altri, altrettanti implacabili, blasfemi racconti di una città e dei suoi abitanti visti con l’occhio sferzante, mai accondiscendente, di un artista che conosce a fondo il bene e il male di questo bizzarro luogo della terra e riesce sempre a proporlo con quel misto di realismo, fatalità e amore che rappresenta la cifra più autentica di Napoli.
L’amore fra Lanzetta e la Voce non si è mai interrotto. Anche dopo pause di silenzio durate anni, ha trovato momenti di travolgente passione, specialmente quando Peppe ha dato vita a quello che continuiamo a considerare il più grande musical degli ultimi anni, quell’ Opera di Periferia che ha anticipato e superato alla grande, fin dal 2006, il valore artistico della Gomorra di oggi. Confermando ciò che abbiamo sempre creduto: nessuno come Lanzetta è stato ed è in grado oggi di guardare con occhi lucidi, di raccontare con mano libera e irriverente la vera storia di questa città, ben oltre l’affollato coro, pagato a peso d’oro, dei servitori di Palazzo e di bottega.
Così ora, mentre Peppe riceve il meritato successo come interprete di un film di produzione internazionale su James Bond, ed esce il nuovo L’isola delle femmine, 22 racconti sul femminicidio, noi proponiamo qui, in jpeg e pdf dalla pagina originale, il suo primo racconto per la Voce. Era l’aprile del 1989. (r. p.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 16 luglio 2016
Ci vuole un fisico bestiale per realizzare imprese del genere. L’uomo degli “astri” quarant’anni fa sbarca sul pianeta Napoli in arrivo dalle terre del centro nord, la “giovane” Romagna gli scorre nelle vene, perfetto mix con la volontà altoatesina che, improvvisamente, si tuffa nelle acque di Marechiaro.
E’ lì, in una microcasa a un tuffo dal blu, che la Voce incontra per la prima volta Vittorio Silvestrini, professore di belle speranze al Politecnico di Napoli, fresco docente di Fisica. Ha un pallino, il Sole. Che mostra con orgoglio sul tetto di casa, il primo pannello partenopeo. Quell’intervista e quel reportage della vecchia Voce – diretta da Michele Santoro – sul fotovoltaico, sulle (dopo tanti anni) stracelebrate “energie rinnovabili” che contrassegnano le “green economy”, ci restano impresse nel cuore. Come quell’intelligenza fuori dal comune, lo spirito da autentico pioniere, le utopie che brillavano subito nel verdeblù dei suoi occhi: terre e concimi che dovevano solo trovare il tempo per tradursi in un magnifico parto.
La creatura che, nell’impossibile mare di Napoli, è riuscito a generare, “Città della Scienza”. A furia di idee e volontà. Anche contro i destini che spesso ti sbattono in faccia come uno tsunami: e sono le macchine del fango (una folle inchiesta della magistratura che avrebbe abbattuto un bisonte, ma non lui) o il rogo di camorra (su cui ancora s’ha da far luce).
A ottant’anni, quel fisico bestiale è ancora in trincea. Per diffondere la rara virtù della Conoscenza, del Sapere e soprattutto la possibilità di “Trasmetterlo”, di renderlo unico, autentico cibo per i cittadini.
Siamo felici di ripubblicare un suo mitico racconto uscito nel 2003 sulla Voce: “La Citroen nera”. Un altro viaggio. Via autostop, un “mezzo” che ha fatto sognare tanti ragazzi, allora, e oggi dimenticato. Era il simbolo della scoperta, della curiosità “verace”, degli orizzonti che si aprono, di una autentica eguaglianza. E quella Citroen nera che sfreccia fra le terre francesi… (a. c.)
LA CITROEN NERA
di Vittorio Silvestrini
Tanti anni fa, non avevo ancora diciotto anni, andai solo soletto a fare una vacanza in giro per l’Europa. Soldi ne avevo pochi. Così viaggiavo in autostop, mangiavo panini – con salame, formaggio, frutta – comprati nei negozi di alimentari, e la notte dormivo negli ostelli della gioventù. Di solito, in questi, si dorme in camerata. La ditta ti fornisce una branda e un materasso, per dormirci sopra con il sacco a pelo. Quasi sempre c’è anche una cucina, ciascuno si cucina quello che vuole; e io ne approfittavo per farmi due uova al tegamino o una fetta di carne all’olio.
Nelle varie città ci passavo in gran fretta, non avevo mai tempo per fare una visita approfondita; e così tutta la vacanza consisteva in sostanza nel dar sfogo allo spirito di avventura, che compensava abbondantemente i sacrifici di quella vita randagia.
Allora non c’erano ancora le grandi autostrade, arterie di scorrimento su cui la gente in macchina percorre di norma centinaia e centinaia di chilometri di seguito. C’erano solo le normali strade statali, a una sola carreggiata, che attraversavano la piazza di ogni singolo villaggio. Le macchine erano poche, e ognuna faceva di regola venti o trenta chilometri appena, da un villaggio all’altro. Il viaggio in autostop era dunque lento e faticoso; in fondo a una giornata, avevi fatto forse centocinquanta o duecento chilometri, eri rimasto ore ed ore per le strade a imprecare contro chi non si fermava, ed avevi trasbordato da una all’altra su qualcosa come dieci o quindici vetture diverse, dalle piccole utilitarie ai camion, e talvolta qualche tratto lo si faceva anche in motocarro, o sul rimorchio pieno di balle di paglia trainato dal trattore di un contadino.
Nell’autostop, capitano le giornate buone, i passaggi si infilano uno dopo l’altro che è un piacere. Capita che il tuo autista, quando sta per finire il suo viaggio, sorpassi un’altra automobile; e allora tu, dal finestrino, fai cenno a quella di fermarsi. E lei si ferma davvero, e tu trasbordi da una macchina all’altra senza nemmeno fermarti un attimo sulla strada. Mi è capitato di dirmi, in quelle occasioni, che l’autostop è meglio delle ferrovie svizzere, che puoi programmare le coincidenze con precisione cronometrica.
Ma nelle giornate “no” non si ferma proprio nessuno; pare che tutte le persone gentili, in quei giorni, abbiano deciso di restarsene a casa, per lasciare le strade a disposizione dei più scortesi. Allora tu te ne stai per ore e ore seduto su un paracarro. Di macchine ne passano poche, e quando una si avvicina e rallenta, magari svolta giusto prima di essere arrivata alla tua altezza. E comunque non si fermano mai, e ti lasciano lì a intristire nello sconforto e nella solitudine.
Ad ogni modo, fra alti e bassi, avevo attraversato mezza Italia, tutta la Svizzera, e ora ero già nel Nord della Francia; dalla cartina vedevo che mi stavo avvicinando sempre più alla Manica. La mia meta era l’Inghilterra, dove contavo di restare per un mese intero, in un campo di lavoro per studenti. Là non solo ti danno da mangiare e da dormire gratis, ma raccogliendo frutta, o tagliando boschi, ti guadagni anche un salario. Io contavo di guadagnare, in Inghilterra, quanto serviva per fare un ricco viaggio di ritorno verso casa.
Quella, era una giornata decisamente no. Era pomeriggio pieno, forse le due e mezzo o le tre; ed ero lì fermo da tre o quattro ore, seduto sul mio zaino. Dopo di allora non sono più stato da quelle parti, e non so se il ricordo del paesaggio squallido sia filtrato attraverso lo sconforto di quel giorno, o se sia davvero così. Ricordo una landa desolata con poca vegetazione, e quella poca era ingiallita dall’arsura dell’estate non ancora finita.
La strada lastricata di largo acciottolato, e polverosa ai bordi; le case a uno o due piani, tinteggiate di colori chiari ingrigiti dalla polvere, le insegne dei negozi pitturate direttamente sui muri e sbiadite dal tempo. E soprattutto, in mezzo alla campagna, le colline regolari a forma di cono, costruite con la polvere di carbone estratta dalle miniere; anche sulle più alte e vecchie di queste colline artificiali, l’erba faceva fatica a crescere, e si limitava a formare una specie di rada peluria che col suo giallo sbiadito non riusciva a coprire il terreno scuro, e nemmeno a ravvivarlo con una macchia di colore.
Dal borgo vicino, distante non più di qualche centinaio di metri, venne camminando con passo elastico un ragazzo che poteva avere all’incirca la mia età. Una figura che appariva irreale, che col paesaggio circostante sembrava non aver nulla a che fare, una specie di illustrazione in un libro di fiabe.
Era un biondino vestito alla tirolese, con calzettoni rossi ricamati con fiori multicolori, pantaloncini corti di pelle con le bretelle, un maglione bianco, e un cappello verde con la tesa e una penna fermata su una specie di ponpon. Aveva un leggero bagaglio, una borsa di tela che portava in mano, e mangiava una mela. Si sedette su un paracarro non lontano da me.
Quando ebbe finito di mangiare la mela, buttò via il torsolo, e dalla tasca laterale della sua borsa ne trasse fuori un’altra ancora, e me la mostrò, come dire: la vuoi? Non avevo mangiato, e quella mela mi faceva gola; ma per una sorta di ritrosia, propria del mio carattere, feci segno di no, e mormorai a fior di labbra: no grazie.
Non credo di aver parlato abbastanza forte da essere udito; ma forse lui lesse la parola sulle mie labbra. «Non mi dire che sei italiano! – mi disse – Vieni, non fare storie, fammi compagnia». E così, mangiando la mela, cominciammo a chiacchierare. Era fiorentino, ma di madre austriaca. Per fare l’autostop, mi disse, preferiva dichiarare la cittadinanza della madre, e difatti per questo si era camuffato con quell’abbigliamento.
«Italiano – disse – sa sempre un po’ di straccione. Austriaco fa più fino, la gente si ferma più volentieri, con meno sospetti».
Mi lamentai con lui della giornata nera. E lui mi disse: «L’avevo capito che non sei un professionista dell’autostop. Per uno che ci sappia fare non esistono giornate nere, in questa attività, se così vogliamo chiamarla. Tu sei uno di quelli che, il passaggio, lo chiedono con umiltà, lo mendicano quasi. La gente non fa volentieri l’elemosina; e se la fa, preferisce farla esplicitamente, regalandoti qualche soldo, almeno ne viene gratificata la coscienza, uno si dice che ha fatto del bene. Ma a un vagabondo che va in giro per divertirsi, perché si dovrebbe fare per l’elemosina un genere, per così dire, voluttuario, come è quello di portarlo a spasso comodamente seduto in automobile? Io in questo momento sto riposando, avevo voglia di mangiare un po’ di frutta. Ma quando voglio ripartire, parto subito. Io scelgo la macchina su cui voglio salire, e concedo al conducente l’onore di trasportarmi. E’ una questione di atteggiamento psicologico, ma loro se ne accorgono, e il prescelto si sente lusingato».
Più tardi, quando decise di partire – «mai in due», disse – ebbi modo di vedere la sua tecnica. Prese in mano una bandierina austriaca, bianca e rossa, che teneva usando l’indice e il pollice della destra, aperti, a mo’ di asta. Quando si avvicinò l’automobile, fece un passo deciso verso il centro della strada, e sventolò con un movimento ampio, una volta sola, la sua bandierina. Il movimento terminava, quando la macchina era ormai vicina, con una specie di inchino. La macchina si fermò alla sua altezza, e lui montò con atteggiamento regale, come un gran signore cui l’autista apra la portiera della sua Rolls Royce. Mi salutò dal finestrino posteriore sventolando la sua bandierina bianca e rossa.
Decisi di provare anch’io.
Apparve in fondo alla strada, uscendo dal paese, una macchina scura; vidi subito che si trattava di una Citroen. A quei tempi, era ancora in circolazione, ed era abbastanza comune, il vecchio modello della Citroen. Quella berlina con l’abitacolo a forma di scatola squadrata, larga e bassa, coi grandi parafanghi bombati, e i predellini a fianco degli sportelli; quella macchina che si vede nei film di gangsters marsigliesi degli anni trenta. Di solito era nera, e sembrava un grande scarafaggio. Era nota per essere una macchina comoda e sicura, a dispetto della sua bruttezza. Non mi era mai capitato che se ne fermasse una. Avevo viaggiato su macchine di ogni tipo, ma non su quella. Avevo fatto la teoria che uno che si comprasse una macchina come quella, calpestando fino in fondo il senso dell’estetica pur di starsene comodo, doveva essere un egoista incallito, senza la minima apertura mentale verso gli altri, e senza un minimo di comprensione per il viandante solitario dell’autostop.
Non poteva capitare cavia più adatta di quella, per il mio esperimento. Sfoderai dunque la migliore imitazione della tecnica del mio giovane maestro austro-fiorentino.
La macchina si fermò. Provai una certa delusione quando vidi che non era nera, ma color sanguinaccio. Il mio esperimento era riuscito, e già era molto; ma non con il peggiore fra tutti i possibili clienti dell’autostoppista, il peggiore di tutti era certamente la Citroen nera. Comunque sia, salii di buon grado. Non parlavo una sola parola di francese, e così i miei viaggi erano sempre silenziosi, di solito non sapevo nemmeno di preciso dove mi stessero portando, salvo il fatto che la strada su cui mi trovavo, e la direzione di marcia, puntavano più o meno verso la mia meta.
Il guidatore della Citroen era un signore grande e grosso, con la faccia rossa e butterata, somigliava un po’ all’attore Charles Laughton. Mi portò fino ad Arras, e mi lasciò praticamente al centro del paese.
Arras è poco più di un villaggio; in una strada del centro, benché fosse quasi sera – ma era una lunga giornata estiva – c’era una specie di mercato della frutta, tante bancarelle in fila in cui si vendevano banane, di ogni dimensione e prezzo. Quelle più piccole e mature costavano veramente pochissimo.
A quel tempo, le banane non erano ancora molto comuni in Italia, avevano per me ancora il sapore dell’esotico e del proibito. E così, approfittando del basso prezzo, ne comprai un grande sacchetto pieno, e mi aggirai a lungo per la strada piena di gente mangiando le mie banane. Ne feci una vera scorpacciata.
Nel frattempo si fece sera, ed era ormai troppo tardi per riprendere il mio viaggio. Scoprii allora che ad Arras non c’era l’Ostello della Gioventù; e mi trovai, all’imbrunire, senza sapere dove andare a dormire. Mi avviai a piedi verso Nord, e così uscii nella vicina campagna; era già scuro e non si vedeva da lontano. A un certo punto, sul bordo della strada, si apriva un grande campo non recintato, e c’era una tettoia ampia e alta, sostenuta da tralicci metallici, una specie di capannone senza pareti. E sotto la tettoia c’era un grande pagliaio: un enorme cumulo di paglia, soffice ed accogliente.
Ero stanchissimo, e quale migliore albergo avrei potuto desiderare per passarvi la notte? Mi spaparanzai sulla paglia, supino, con le braccia e le gambe allargate per prendere più spazio, e un po’ di paglia me la misi anche addosso, per proteggermi dal freddo della notte. Nel Nord, anche in estate piena, le notti sono fresche, e l’aria pungente. Mi addormentai subito come un sasso. La mattina, quando mi svegliai, era ancora presto. C’era una leggera foschia, bassa sulla campagna. E il cielo si schiariva lentamente, pareva che il sole indugiasse a lungo prima di trovare la forza e la voglia di svegliarsi del tutto, e di alzarsi sull’orizzonte. Più ti avvicini al Nord, e più lunghi sono i crepuscoli, più lente le albe e più malinconici i tramonti.
Me ne restai a lungo sprofondato nella paglia morbida. Lentamente mi venne in mente una specie di sogno che avevo fatto. Mi sembrava di essere stato svegliato, nel cuore della notte rischiarata appena da lontano dall’ultimo lampione all’uscita del paese, dal tepore di un corpo steso vicino a me. E c’era nell’aria profumo di donna.
Io non avevo mai fatto all’amore, prima di allora; e la donna era per me un essere inesplorato che mi metteva paura, eppure sollecitava la mia fantasia con mille lusinghe di meravigliosi peccati. E così, in uno stato di semi incoscienza, il mio spirito aveva lottato a lungo; fra la voglia di svegliarsi per vedere chi mi giaceva accanto, e per assaporarne i piaceri, e la stanchezza che, alleandosi con la paura dell’ignoto, mi invitava a riprendere il sonno. La paura e la stanchezza avevano vinto, e così mi ero addormentato di nuovo, senza esplorare il mistero che lì vicino emanava il suo tepore.
Ora, via via che svegliandomi riprendevo piena coscienza, mi andavo rendendo conto che non si era trattato di un sogno, ma di una sensazione reale.
A un tratto, come un fulmine, un dubbio mi percorse la mente, e mentre affannosamente le mie mani andavano a fare la verifica, già sapevo che il mio subconscio aveva visto, e il mio sospetto corrispondeva a verità. Nelle tasche dello zaino, tenevo da un lato i documenti, e dall’altro i soldi, pochi ma indispensabili. La tasca di destra era aperta, e vuota. Non possedevo più nemmeno uno spicciolo. Lontano da casa, in un paese straniero, in mezzo a gente di cui non conoscevo la lingua, ero stato privato all’improvviso di ogni mezzo di sussistenza, di ogni strumento di indipendenza e di libertà.
Mi ributtai steso sulla paglia, e rimasi a lungo come vuoto di pensieri. Col passare del tempo, la mente riprese a lavorare lentamente. E scacciando il senso di impotenza, piano piano andava costruendosi una ragione, cercando una soluzione, una via di uscita. Non vi era speranza di affrontare, con qualche probabilità di successo, il lungo viaggio di ritorno verso casa. L’unica possibilità per me era quella di procedere il più speditamente possibile verso la mia meta, l’Inghilterra, dove avrei trovato vitto e alloggio, e un salario. Con un po’ di fortuna potevo sperare di arrivare l’indomani, e si può sopravvivere senza mangiare per un giorno o poco più.
C’era il problema di attraversare la Manica, ma arrivato al porto di imbarco forse qualche santo mi poteva aiutare.
Vicino al posto dove avevo dormito scorreva un canale, e lì feci le mie abluzioni mattutine. Poi dal fondo dello zaino tirai fuori il mio vestito “buono”. Di solito giravo in pantaloncini corti, una maglietta e scarpe da ginnastica. Ma avevo anche un paio di pantaloni lunghi di lino, che dopo avere ben piegato arrotolavo con cura, e uscivano allora dallo zaino lisci come se fossero stati sulla gruccia in un armadio. Avevo anche una camicia bianca sportiva con i taschini, e un paio di mocassini di pelle morbida. Così vestito mi sentivo un milord.
Non avevo una bandierina austriaca, né una italiana, che comunque non sarebbe servita. Così strappai un ramoscello da un albero di gelso, e mi disposi a fare con atteggiamento spavaldo il magico gesto che avevo imparato dal mio occasionale maestro di autostop, e mi parve che fosse qualcosa di simile al gesto di saluto che D’Artagnan faceva col grande cappello piumato. Nemmeno a farlo apposta, la prima macchina che comparve sulla strada era una Citroen, e questa non v’era dubbio che fosse nera, ed era anche il modello più grande, più lussuoso, e dunque anche più inaccessibile. Ma senza lasciarmi spaventare feci il mio spavaldo saluto, e la macchina si fermò vicino a me. Scese un autista in livrea, che compitamente mi aprì lo sportello, e mi fece sedere avanti, vicino a lui.
L’automobile aveva i vetri azzurrati, e così prima di salire non avevo potuto distinguere i suoi occupanti. Quando salii dentro l’abitacolo foderato di velluto a coste, vidi che dietro erano seduti un signore e una signora. Lui era magro ed apparentemente alto, aveva capelli bianchi, e un’aria di grande distinzione. Vidi più tardi che aveva un piede ingessato, e camminava a stento col bastone. Lei era una signora che dall’osservatorio dei miei diciassette anni giudicai “matura”: ma ripensandoci oggi poteva avere poco più di trent’anni. Aveva un vestito attillato color verde smeraldo, era truccata con cura – le sopracciglia sottili, le ciglia nere, le labbra a cuore disegnate con un rossetto molto scuro – la sua pelle era bianchissima, gli occhi azzurri e i capelli di un bel rosso fiamma. A me parve non bella, ma stupenda. Lei provò ad attaccare discorso con me, ma fu poi scoraggiata dal fatto che io non sapevo una sola parola della sua lingua. Mi parve di capire che per sua intercessione la macchina si era fermata, e mi resi così conto di non avere ancora infranto la regola secondo cui il proprietario di una Citroen nera, spontaneamente, non concede mai un passaggio: perché, non v’era dubbio alcuno, il padrone, lì dentro, era lui, il vecchio signore distinto.
La macchina procedeva con grande lentezza, pareva quasi che andassero a zonzo. Attraversando i villaggi andavano a passo d’uomo, e ci fermavano a guardare la chiesetta, o se fra le case c’era anche un solo palazzo con una parvenza di aspetto monumentale.
Intorno a mezzogiorno eravamo a Lille, e girammo a lungo per le strade della città. Io fremevo, perché volevo muovermi velocemente verso la mia meta. Ma poi ci fermammo a un ristorante, e fui ricompensato della mia pazienza, perché fui invitato a pranzo. Durante il viaggio non avevo mai fatto un pasto completo, e al ristorante ci andavo assai raramente anche quando ero a casa. L’autista andò a sedersi a un tavolo da solo; ma a me fu fatto l’onore di farmi sedere al tavolo coi padroni. Avvertivo, fra i due, una forte tensione; ma io non ero estraneo, e mi beavo del cibo buono e del servizio raffinato.
Più tardi riprendemmo la strada, e allora in macchina la tensione scoppiò in un litigio, un alterco condotto a bassa voce ma con tono acceso, e con cipiglio violento. Io non potevo capire l’argomento del litigio. A un certo punto svoltammo dentro un cancello di ferro battuto, con due colonne a fianco, aperto in un alto muro di cinta, e percorremmo un lungo viale di tigli fino ad una grande villa, quasi un castello. Il signore distinto scese, e si avviò zoppicando sulla scalinata che portava verso la porta di ingresso. La signora mi fece cenno di andarmi a sedere di dietro, vicino a lei. L’autista riprese il suo posto, e ricominciammo il lento viaggio diretti verso il Nord.
Potevano essere le cinque quando arrivammo in vista del mare. Eravamo dalle parti di Dunquerque, ma la zona era deserta, e la strada che correva parallela al mare era separata dalla spiaggia da un irregolare dorso di dune ricoperte di ginestre. Di tanto in tanto, oltre le dune, si vedeva una spiaggia bianca e larghissima, e il mare grigio ferro increspato di onde lunghe e lente, che venivano a frangersi dissolvendosi in una larga chiazza di schiuma bianca.
A un certo punto, ci stavamo ormai avvicinando al paese, c’era fra la strada e il mare un grande edificio bianco. Non restano, nella mia memoria, che vaghe impressioni di quello che a me parve un castello incantato; i grandi balconi con le ringhiere di ghisa lavorata tinta con smalto bianco; gli stucchi ad ornare la facciata; l’enorme sala a piano terra con grandi vetrate sostenute da cornici floreali. I colori dominanti, all’interno, erano il rosa e il verde pallido; e da una sala all’altra si passava attraverso grandi vetrate colorate come quelle di una cattedrale, popolate di figure femminili in stile liberty, con le vesti svolazzanti in mille pieghe arabescate, e i capelli a riccioli fluenti sotto lo stretto cappello a cloche.
Era un albergo. Io entrai guidato dalla mia dama, ed eravamo seguiti dall’autista che portava in una mano la rossa valigia di lei, e nell’altra il mio zaino di tela grezza.
Lei mi portò in una grande camera, anch’essa rosa e verde pallido; e nella camera oltre al letto c’erano poltrone, e divani, e mobili laccati bianco e oro, con la porta aperta che affacciava su un enorme bagno rivestito di marmo
bianco. Mi sedetti su una poltrona, e dopo poco, mentre lei era chiusa in bagno, un cameriere portò un carrello, con un secchiello di ghiaccio e dentro una bottiglia di champagne, e due lunghi calici snelli.
Lei uscì dal bagno con una vestaglia trasparente. Si avvicinò al carrello e versò lo champagne nelle coppe. Ma prima ancora di brindare, io ero già completamente ubriacato dall’atmosfera di lusso e di peccato, e dalla bellezza di lei. Lasciò cadere la vestaglia, ed era la prima volta che vedevo la pelle bianchissima di una donna nuda. Mi slacciò la camicia e me la tolse, e poi leggendo lo smarrimento nei miei occhi mi prese per mano e mi portò verso il letto.
E anche lì fu lei a guidarmi per mano attraverso la mia prima esperienza d’amore. Da allora fino al buio della sera facemmo all’amore molte volte. Più tardi, nel cuore della notte, molte volte mi sono svegliato. Appena la toccavo lei apriva gli occhi, e facevamo all’amore nella penombra.
La mattina mi svegliai in piena luce, la stanza ne era inondata e fuori il sole era già alto. Lei non c’era più. Ne fui quasi contento, perché non so se avrei potuto sopportare l’emozione di un altro giorno vissuto nell’atmosfera di peccato e di adulto di cui le riempiva la mollezza e il lusso di quel grande letto rosa.
Ma poi fui assalito dalla paura. La paura dei portieri gallonati, dei camerieri impeccabili, dei funzionari altezzosi; di tutta quella organizzazione con cui avrei dovuto scontrarmi di lì a poco, senza un soldo in tasca e con un favoloso conto da pagare.
Mi vestii in fretta e scesi nella hall. Mi avvicinai al grande banco, per informarmi sulla consistenza del conto. I portieri in divisa, che sembravano saper parlare ogni lingua, non conoscevano tuttavia l’italiano. Mentre cercavo di arrangiarmi con il mio stentato inglese, intervenne un giovanotto che già si trovava in vicinanza del banco. Era vestito di bianco, era biondo con una barba appuntita in avanti, che gli dava un’aria di malizia. Era uno studente di Venezia. Mi fece da interprete, e si informò sui miei fatti con l’impettito direttore.
«Pare che tu fossi in compagnia di una gran dama – mi disse a conclusione della sua indagine – Se ne è andata stamattina presto. Ha lasciato detto che ripasserà fra due settimane. Da oggi fino a quando vorrai restare, prima che lei ritorni, tu sei ospite suo, penserà lei a saldare il conto. – Una fortuna – aggiunse – che dovrebbe capitare a me. Sono qui con la più bella norvegese della Terra, ma ci resta solo di che pagare tre notti». Mi venne fatto di proporgli di cedergli i miei quindici giorni di ospitalità gratuita, se lui mi pagava il costo di tre notti. Lui accettò. Era un albergo di gran lusso, e la cifra che mi diede lo sconosciuto giovanotto di Venezia era la più alta che mai mi fossi ritrovato in tasca. Col mio zaino, ripresi la via dell’Inghilterra, quasi come se andassi alla conquista del mondo. Ero fiero e spavaldo come D’Artagnan. Non c’era barba di Citroen nera che mi mettesse soggezione.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 10 luglio 2016
IL PARLAMENTO GATTOCOMUNISTA
di Andrea Cinquegrani
Il dibattito si fece acceso. Da mesi era in atto una campagna di stampa per fermare, o quantomeno diminuire, il consumo di carne umana. In allarme tutto il settore che ruotava intorno, dai macelli ai trasporti fino ai negozi: in questo modo, soprattutto fra cani e gatti, ma anche polli, conigli e tacchini, sarebbe cresciuta in modo vertiginoso la disoccupazione. Al solito, a pagarne le più pesanti conseguenze le giovani leve, in cerca del loro primo lavoro.
Ma a quanto pare il parlamento Gattocomunista era ben deciso a non tornare più indietro sui suoi passi. Quella legge che impediva l’allevamento di uomini in batteria e poi la macellazione per finire sule tavole era ormai cosa fatta. Chissà, in futuro solo un referendum popolare avrebbe potuto abrogarla.
A questo punto, però, occorreva organizzare il domani. Come riuscire a nutrire quei branchi di umani senza far saltare le casse dello stato? E allo stesso tempo come incrementare le risorse alimentari per nutrire la popolazione animale senza incorrere nelle sanzioni comunitarie? Secondo il segretario del partito Bau, Vanni Bracco, solo il tempo avrebbe consentito di risolvere il problema: era necessario liberare gli umani da stalle recinti e gabbie in modo graduale, altrimenti l’impatto sarebbe stato troppo massiccio. Scaglioni da 100 mila a settimana, in modo tale che nell’arco di un anno tutti sarebbero usciti. I primi a ritrovare la libertà, ovviamente, quelli in condizioni di salute più precarie, anziani e bambini.
Una tassa una tantum avrebbe coperto le spese necessarie a soddisfare il fabbisogno alimentare. Non tutti erano d’accordo, stanchi di balzelli che ormai avevano ridotto pesantemente il potere d’acquisto di salari e stipendi. Ad esempio il segretario del partito Miao, Felix Soriano: da giovane a capo del movimento di liberazione “Occhio di lince”, d’ispirazione maoista, ora si batteva per l’introduzione di una patrimoniale sulle ricchezze più alte, proprio per non toccare pensioni minime e bassi salari. Sia Bracco che Soriano comunque erano favorevoli ad una lotta senza quartiere all’evasione fiscale, da sradicare definitivamente dopo i primi già consistenti successi ottenuti dal governo in carica.
In un comunicato congiunto, i due segretari sottolineavano “la portata storica di questa lotta, mai condotta, se non per finta, da tutti i governi che avevano preceduto la rivoluzione”. Prima della presa del potere, e cioè prima della nascita del governo Gattocomunista per circa cent’anni gli esecutivi avevano promesso e ripromesso che le tasse sono un dovere civico, tutti devono pagarle e blablabla, ma poi a farlo erano sempre i soliti povericristi mentre lorsignori se ne fregavano altamente. Adesso la legge non ammetteva deroghe. E la punizione era severissima: tutti quelli che non pagano in misura giusta e proporzionata alle loro entrate, non avranno più diritto ad avere in casa uno o più umani domestici, e così i piccoli non avranno più modo di divertirsi giocando con loro, portandoli a fare la pipì a spasso, in gita o al parco.
Fortissime le sanzioni per i macelli clandestini. Sequestro e immediata confisca dei beni, dopo un processo lampo, a carico di tutti coloro che continuano ad allevare controlegge umani, macellarli e distribuirli in modo illegale. Pugno di ferro anche per stroncare il lucroso business delle scommesse clandestine sulle lotte fra umani. Un blitz delle forze dell’ordine ha chiuso una cinquantina di strutture la scorsa settimana: nel settore, infatti, domina il clan dei “Gattopardi”, che ricicla il danaro ricavato dalle cruente lotte tra umani soprattutto nel grande commercio di prodotti ortofrutticoli vegetali vegani in rapidissima crescita nel corso degli ultimi anni.
 Ma uno dei terreni più accesi di scontro politico è quello sul fronte della “sperimentazione umana”, ossia la vivisezione di corpi di umani, umanoidi e simili a fini non solo di ricerca scientifica, ma anche educativi. Il ministro della salute, Rossella Volpe, ha appena presentato un disegno di legge che prevede la totale abolizione della sperimentazione, considerata crudele nei confronti di umani indifesi, privati di ogni diritto, fatti a pezzi nei modi più brutali per soddisfare le esigenze di PIG Pharma, il colosso che ha bisogno assoluto del bollino blu – recante la scritta ‘medicina sperimentata su cavie umane’ – per poter vendere i suoi prodotti in tutto il regno animale. Un disegno molto articolato, che vieta il ricorso a questa pratica anche perchè ritenuta inutile, superflua visto che gli esperimenti fatti sugli umani non sono poi utilizzabili per gli animali e non servono per fabbricare i farmaci. Quindi bandite laparoscopie tracheotomie tagli orizzontali verticali sbudellamenti radiazioni scosse elettriche trapianti espianti infezioni provocate apposta virus iniettati pervedereleffettochefa bruciature tumori indotti segregazioni shoc perfartimpazzire. Tutte cose spaventosamente crudeli su poveri e indifesi umani senza ricorrere ad anestesie se non in una minima percentuale dei casi o altre volte con anestesie appena parziali.
Ma uno dei terreni più accesi di scontro politico è quello sul fronte della “sperimentazione umana”, ossia la vivisezione di corpi di umani, umanoidi e simili a fini non solo di ricerca scientifica, ma anche educativi. Il ministro della salute, Rossella Volpe, ha appena presentato un disegno di legge che prevede la totale abolizione della sperimentazione, considerata crudele nei confronti di umani indifesi, privati di ogni diritto, fatti a pezzi nei modi più brutali per soddisfare le esigenze di PIG Pharma, il colosso che ha bisogno assoluto del bollino blu – recante la scritta ‘medicina sperimentata su cavie umane’ – per poter vendere i suoi prodotti in tutto il regno animale. Un disegno molto articolato, che vieta il ricorso a questa pratica anche perchè ritenuta inutile, superflua visto che gli esperimenti fatti sugli umani non sono poi utilizzabili per gli animali e non servono per fabbricare i farmaci. Quindi bandite laparoscopie tracheotomie tagli orizzontali verticali sbudellamenti radiazioni scosse elettriche trapianti espianti infezioni provocate apposta virus iniettati pervedereleffettochefa bruciature tumori indotti segregazioni shoc perfartimpazzire. Tutte cose spaventosamente crudeli su poveri e indifesi umani senza ricorrere ad anestesie se non in una minima percentuale dei casi o altre volte con anestesie appena parziali.
Accolte nel disegno ministeriale, quindi, le proteste e le proposte portate avanti per anni dai movimenti “umanisti”, dalla LDUU (Lega Difesa Umani e Umanoidi), dalle tante sigle dell’associazionismo e del volontariato canino, ferino, equino e via di questo passo. Una lotta per tutelare i diritti della minoranza umana – fanno rilevare i promotori – troppe volte disattesi, calpestati, violati, senza che alcuna autorità sia mai intervenuta in loro difesa, né a livello nazionale che internazionale. “Una battaglia di civiltà – fanno rilevare alla LDUU – perchè finalmente prevalgano i diritti dei più indifesi, come umani e umanoidi, delle minoranze storicamente stuprate dalla nostra violenza, dalla nostra ansia di far profitto sulla loro disgraziata pelle e soprattutto per ubbidire alle aziende capeggiate da tanti, troppi maiali”. Il riferimento, di tutta evidenza, è all’industria farmaceutica, a PIG Pharma, che nonostante la Rivoluzione ha continuato a macinare indisturbata i suoi guadagni.
 Ma a quanto pare quelli che non la pensano così non sono disposti ad arrendersi. Obietta uno scienziato, Giacomo, un orango di mole massiccia: “No, non dobbiamo smetterla con la sperimentazione umana, ci serve, eccome, sennò finiamo male, non c’è più futuro per le nostre ricerche se smettiamo di sperimentare l’effetto dei nostri farmaci sugli umani. Solo quei vecchi rincretiniti la pensano in modo diverso, e fanno tanti gli umanitari. Noi dobbiamo pensare al nostro futuro e per questo dobbiamo continuare con la vivisezione che facciamo nel mondo più indolore possibile. Siamo buoni, vogliamo bene alle nostre cavie, mi ricordo di quell’uomo che mi guardava negli occhi e si cominciavano a bagnare, i suoi occhi, ma io lo carezzavo, lo rassicuravo, gli dicevo che non era solo per il nostro bene ma anche per il suo. Lui si agitava, sbatteva contro i ferri della gabbia, io gli cantavo una bella canzone, come una ninna nanna per calmarlo, gli ripetevo che non avrebbe sentito molto dolore e poteva essere felice che tanti poi con il suo sacrificio potevano stare meglio”.
Ma a quanto pare quelli che non la pensano così non sono disposti ad arrendersi. Obietta uno scienziato, Giacomo, un orango di mole massiccia: “No, non dobbiamo smetterla con la sperimentazione umana, ci serve, eccome, sennò finiamo male, non c’è più futuro per le nostre ricerche se smettiamo di sperimentare l’effetto dei nostri farmaci sugli umani. Solo quei vecchi rincretiniti la pensano in modo diverso, e fanno tanti gli umanitari. Noi dobbiamo pensare al nostro futuro e per questo dobbiamo continuare con la vivisezione che facciamo nel mondo più indolore possibile. Siamo buoni, vogliamo bene alle nostre cavie, mi ricordo di quell’uomo che mi guardava negli occhi e si cominciavano a bagnare, i suoi occhi, ma io lo carezzavo, lo rassicuravo, gli dicevo che non era solo per il nostro bene ma anche per il suo. Lui si agitava, sbatteva contro i ferri della gabbia, io gli cantavo una bella canzone, come una ninna nanna per calmarlo, gli ripetevo che non avrebbe sentito molto dolore e poteva essere felice che tanti poi con il suo sacrificio potevano stare meglio”.
Osserva Gilda, una capretta dalla barba grigia: “Anch’io ho visto che tanti umani versano lacrime, non volevano quelle cose che gli facevamo. Sono sicura che soffrivano molto. Ho saputo di tanti di noi che di quella loro sofferenza se ne fregavano, li aprivano senza pensarci su, mentre loro strillavano come ossessi, li facevano in quattro ridendoci su con gli altri due che lo tenevano fermo, il sangue che usciva come un fiume, i suoi occhi di pietra, un odore che rimane nelle narici per sempre. Altro che, quegli umani soffrivano eccome. E per me non ne valeva la pena, non c’era motivo, non era possibile far soffrire in quel modo per niente. Ci potranno essere altri modi con tante scoperte che facciamo al giorno d’oggi, altrimenti vuol dire che siamo selvatici che siamo tornati ai tempi della pietra, non è possibile”.
Ma il grande PIG ragionava così: “io devo tutelare i miei interessi. Ho tante aziende, devo pagare i dipendenti devo pagare altra ricerca che faccio devo pagare gli azionisti devo diventare più grande sempre più grande. Sono cambiati i governi dopo la rivoluzione ma io devo continuare per la mia strada. Hanno fatto questa legge? Troveremo il modo di aggirarla. Perché la ragione è dalla nostra parte. Alcuni partiti sono contro di noi? Ce li compriamo. O ne facciamo un paio nuovi di zecca. Tutti devono capire che la legge siamo noi la facciamo noi con i nostri soldi. Servono i vaccini? Eccone una vagonata. Servono antibiotici? Eccovi serviti. Antidolorifici? Ok. Tutto pronto, basta che ci lasciano lavorare”.
 Racconta un vecchio saggio, un castoro di pelo lungo e lunga esperienza su questa terra: “Da piccolo mi dicevano che le cose andavano bene, che dovevamo stare buoni, contentarci di come stavamo, che era una grazia di Dio se non stavamo peggio, la vita poi prima o poi finisce. Quando sono cresciuto ho letto le storie di quelli umani che venivano portati lontano, grandi prigioni, poi torturati, messi neo forni a cuocere ben benino. Mi sono tante volte chiesto se per noi la vita è poi così buona, se per noi ogni giorno è come per loro un tempo, quel tempo che tutti ricordano come la più grande strage del mondo. Per noi, ho capito crescendo, ogni giorno è quello che succedeva in quei forni, per tanti per troppi”. E continua: “Ma adesso le cose stanno cambiando da quando c’è stata la rivoluzione. Almeno quelle cose non succedono più, non facciamo più a loro quello che loro facevano a noi: è un buon punto di partenza. Dicevano sempre l’amore l’amore l’amore: e poi si ammazzavano tutti i giorni, per un niente per fregarsi i soldi per rubarsi un pezzo di terra per portarsi via la moglie. E questo adesso da noi non succede: se ho da mangiare abbastanza perché devo saltare al collo del mio vicino? Se ho un bel pezzo di terra perché volerne il doppio che poi ci devo faticare di più?”.
Racconta un vecchio saggio, un castoro di pelo lungo e lunga esperienza su questa terra: “Da piccolo mi dicevano che le cose andavano bene, che dovevamo stare buoni, contentarci di come stavamo, che era una grazia di Dio se non stavamo peggio, la vita poi prima o poi finisce. Quando sono cresciuto ho letto le storie di quelli umani che venivano portati lontano, grandi prigioni, poi torturati, messi neo forni a cuocere ben benino. Mi sono tante volte chiesto se per noi la vita è poi così buona, se per noi ogni giorno è come per loro un tempo, quel tempo che tutti ricordano come la più grande strage del mondo. Per noi, ho capito crescendo, ogni giorno è quello che succedeva in quei forni, per tanti per troppi”. E continua: “Ma adesso le cose stanno cambiando da quando c’è stata la rivoluzione. Almeno quelle cose non succedono più, non facciamo più a loro quello che loro facevano a noi: è un buon punto di partenza. Dicevano sempre l’amore l’amore l’amore: e poi si ammazzavano tutti i giorni, per un niente per fregarsi i soldi per rubarsi un pezzo di terra per portarsi via la moglie. E questo adesso da noi non succede: se ho da mangiare abbastanza perché devo saltare al collo del mio vicino? Se ho un bel pezzo di terra perché volerne il doppio che poi ci devo faticare di più?”.
Una notte il saggio castoro ebbe un sogno. Che ricorda ancora bene. E lo racconta agli amici.
“Si respira un clima di festa. Per le strade un paradiso di cani gatti uccelli uomini donne cavalli pappagalli conigli lepri balene falene tutti a rincorrere tutti su prati sconfinati, arrampicarsi sugli alberi nuotare in fiumi e torrenti laghi o mari, far capriole girotondi, altri mangiano bevono dormono russano grattano si grattano baciano si baciano toccano si toccano. I dieci comandamenti funzionano, tutti ci credono e li mettono in pratica. A mare tutte le altre sciocche leggi, bastano quelle. Stanno tornando i colori che prima man mano sparivano. E gli odori i profumi gli aromi un tempo uccisi dal nero dei gas. Vanno tutti al cinema a teatro vedono spettacoli sentono musiche vanno molto quelli con le storie degli “umani”, che si prendono a cazzotti si inseguono si ammazzano di botte fanno a pistolettate. Ma tutti ridono a guardarli, sembrano mille mille mille anni fa…”.
————————————————————————————————————————————————————-
Il Racconto di Domenica 3 luglio 2016
PUCCIO – Amore e giustizia nella Vicaria
E’ ancora lui, un grande talento immaginifico, a sbalordirci sulla Voce di dicembre 2001. Dopo clamore e consensi suscitati da “Giovanni é tra noi”, il racconto pubblicato ad ottobre scorso, Amato Lamberti era tornato a proporci l’incredibile che diventa sotto i nostri occhi realtà. Sempre in bilico, proprio come il procedere della vita, tra anima e corpo, pensiero e sensi.
di Amato Lamberti
(Questa storia la racconto così come mi è stata raccontata. Mia è solo la trascrizione dal parlato allo scritto, anche se ho tentato di non perdere il ritmo e l’immediatezza della narrazione parlata).
Abitavamo in un palazzo a Napoli nel rione Vicaria. Un palazzo grande, scuro, pieno d’umidità nell’androne e al piano terra. Le macchie d’umido disegnavano facce antiche e tribolate come quelle dei pastori dei presepi di tante chiese napoletane.
Di notte, sotto la luce fioca delle lampade che rischiaravano l’androne, si animavano di braccia e di mani che sembravano voler afferrare i bambini che passavano di corsa, lo sguardo a terra e sbirciando di sottecchi. Per le scale le facce s’affollavano e sembravano tutte lamentarsi di qualcosa che le angustiava molto.
Noi, io, le mie due sorelle, mia madre e mio padre di scale ne dovevamo fare poche perché abitavamo al primo piano in un appartamento grande quattro stanze una dietro l’altra, la cucina, il salotto, la stanza da letto di noi ragazze, la stanza da letto dei genitori. Il bagno era sul terrazzino vicino alla cucina che era grande e aveva il soffitto molto alto e sempre al buio perché la lampadina era molto bassa. Della famiglia faceva parte anche un cane bastardino raccolto per strada da papà. Naturalmente il cane si era legato a papà in modo quasi morboso, gli stava sempre appresso quando stava a casa, guardandolo spesso come in adorazione.
Una famiglia modesta: papà lavorava in un grande negozio di ferramenta, mamma badava alla casa e faceva la sartina per il palazzo, noi figlie andavamo a scuola. Ci volevamo molto bene ed eravamo felici. Quando papà morì per una brutta malattia dopo pochi mesi di disperazione e di consunzione la nostra vita diventò piena di paura e d’angoscia. Io che ero la più grande facevo la quinta elementare e potevo capire l’angoscia di mia madre rimasta senza sostegno affettivo ed economico. Non avevamo parenti. Anche il funerale fu quello dei poveri con papà seppellito nella nuda terra. Mamma non si poteva rassegnare a pensarlo al freddo, all’acqua, specialmente quando pioveva. Il cane diventò triste e non mangiava neppure. Accucciato dietro la porta aspettava che il padrone tornasse.
Il primo a bussare fu il padrone di casa, un vecchio grasso sempre sudato ed arcigno che tutti odiavano perché prestava i soldi con l’interesse e non aveva pietà di nessuno. Tutto il palazzo era suo, compresi i negozi, e viveva solo come un cane in un appartamento grande tutto un piano. Non fece neppure le condoglianze, bofonchiò qualcosa, disse che era dispiaciuto ma l’affitto di casa bisognava pagarlo ed eravamo già in ritardo di una settimana. Papà era morto due giorni prima. Mamma chiese qualche giorno di pazienza e assicurò che avrebbe sicuramente provveduto.
Quando l’orco (così lo chiamavamo) uscì, si mise a piangere invocando il nome di mio padre. Ciro, Ciro, ed ora come faccio? Se pago il fitto non possiamo neppure mangiare. Non è per me, è per le bambine. Con il suo lavoro di sartina guadagnava troppo poco per poter mantenere una famiglia. Doveva cercare un altro lavoro, questo era certo, ma così su due piedi era difficile. I proprietari del negozio di ferramenta le avevano dato qualche soldo ma le avevano detto di non poterla assumere al posto del marito perché anche loro erano in difficoltà. Io tentai di consolarla dicendo che l’avrei aiutata, avrei cercato un lavoro ma questo non faceva che aumentare la sua disperazione.
Fuori tutte le strade erano illuminate, piene di gente e di bancarelle perché si avvicinava il Natale e tutti avevano l’aria felice. A me dava tristezza anche la musica dei zampognari. Andavamo a dormire tutti nel letto grande vicini vicini per darci coraggio più che per scaldarci. Non avevamo neppure acceso la stufa per risparmiare. Il cane non si muoveva dall’uscio.
Quando al mattino i rumori e le voci della strada insieme alla luce che filtrava dalle imposte ci svegliarono, ci accorgemmo che anche il cane era sul letto al solito posto a piedi dove dormiva papà. Aveva un’aria diversa e si mise subito a fare festa tentando di leccare tutti. Mamma mise la mano sul comodino per prendere l’orologio e vedere l’ora con un movimento stanco come di chi non ha riposato e vorrebbe ancora dormire. La vedemmo irrigidirsi e poi alzarsi di scatto per guardare sul comodino. Prese qualcosa sul ripiano e tornò a sedersi sul letto. In mano aveva un fascio di banconote. Cominciò a piangere a dirotto chiamando Ciro, Ciro, Ciro, Ciro stanotte ti ho sognato, come eri bello, mi dicevi di non preoccuparmi Ciro, Ciro, Ciro. Scoppiammo tutti a piangere e a chiamare papà. Solo Puccio, il cane, continuava a scodinzolare allegro.
Naturalmente la nostra vita cambiò perché cambiò l’aria che si respirava. Mamma trovò un lavoro nella tintoria sotto il palazzo, anch’io dopo la scuola guadagnavo qualche soldo portando la spesa a casa. Ci sentivamo tranquilli perché sapevamo che papà ci stava vicino. Noi non potevamo vederlo, ma Puccio forse poteva perché a volte si alzava di scatto, come se qualcuno fosse entrato in casa, prima guaiva e poi scodinzolava. Lo faceva di giorno e di notte e questo ci dava tranquillità. L’unico cruccio era il padrone di casa che prima ci aumentò l’affitto e poi ci diede lo sfratto. Ma noi non volevamo andare via da quella casa. Avevamo paura di restare nuovamente soli.
Un giorno sentimmo un gran frastuono, un correre su e giù per le scale, chiamate ad alta voce. L’avevano trovato morto, il vecchio usuraio, con la faccia stravolta. Le vecchiette dicevano “sembra morto di paura”. Nella casa l’avvocato non trovò niente, né soldi né libretti, solo un testamento nel quale lasciava tutte le proprietà alle Suore di Carità. Forse, dopo aver fatto tanto male, si voleva salvare l’anima. Al suo funerale c’era tutto il Palazzo o meglio i suoi abitanti. Qualcuno lo accompagnò fino al paese dove era nato forse per verificare che davvero fosse stato seppellito a dovere.
In casa il più contento era sempre Puccio perché era l’unico che si poteva godere senza angosce la situazione.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 26 giugno 2016
La jettatura al tempo del terremoto
di Amato Lamberti
Sospeso in bilico tra realtà e sogno immaginifico, un nuovo racconto di Amato Lamberti ad appassionarci.
Jella, magia, fatture a morte nella Napoli del terremoto. E al centro di tutto lui, Tullio, ossuta creatura gravida di misteri disvelati e arcani percorsi lungo le vie precluse agli umani…
Ecco il Racconto che Amato Lamberti scrisse per la Voce di GENNAIO 2002
Napoli è una strana città, come hanno notato nei secoli i viaggiatori stranieri che hanno avuto la ventura di soggiornarvi, dove la storia in qualche modo si solidifica lasciando grumi di comportamenti, di credenze, di atteggiamenti che diventano inattaccabili dal tempo e acquistano una sorta di immortalità. Tullio era un personaggio che avresti potuto tranquillamente ritrovare in una cronaca del ‘700 tra gli intellettuali di una delle tante Accademie fiorite in quel periodo.
Letterato, filosofo, amante dell’occulto e del mistero, ricercatore di tradizioni popolari, frequentatore di teatri e di feste suburbane, curioso della vita e della gente che popola i vicoli di quello che ancor oggi è il ventre della città. Come tutti gli intellettuali che a Napoli si rispettano scriveva spesso su quotidiani e periodici locali discettando sugli avvenimenti più diversi che, raggiunto l’onore della cronaca, sollevavano discussioni quasi sempre bizantine e prese di posizione sui versanti politici più diversi. La sua passione erano però le questioni culturali, le mode intellettuali, su cui aveva la possibilità di esercitare appieno la sua capacità di scrittura ma anche una cultura da autodidatta curioso di tutto e soprattutto di ciò che appariva controverso, strano, sostanzialmente irrazionale.
Ci incontrammo per caso in una delle tante occasioni di dibattito che quasi giornalmente si producono in città. L’argomento era serio: lo sforzo della amministrazione comunale di eliminare i “bassi” e dare abitazioni dignitose a quella popolazione che animava si i vicoli e il folklore di Napoli ma si trovava condannata ad una condizione di vita che ne impediva ogni possibilità di crescita culturale prima che sociale. La sua tesi era invece quella che bisognava difendere le sopravvivenze dei bassi perché era in quei luoghi che la napoletanità si riproduceva instancabile assicurando alla città quella fisionomia che la rendeva unica e irripetibile. Citando Pasolini affermava di essere contrario ad ogni forma di modernizzazione omologante. La distruzione dei bassi avrebbe prodotto una perdita culturale irrecuperabile come già era avvenuto all’inizio del ‘900 con lo sventramento della città. Naturalmente queste tesi un po’ paradossali non suscitarono molto consenso ma servirono ad attivare altre discussioni sulla cultura o subcultura dei vicoli e sulla necessità o meno di salvaguardarne almeno la memoria.
In seguito ci incontrammo spesso in dibattiti e confronti su tematiche diverse e sempre mi colpiva quel suo modo di affrontare le questioni dal rovescio, prendendo cioè i problemi sempre dal di dietro. Un approccio per così dire bestiale oltre che paradossale che finiva però sempre per offrire al dibattito spunti interessanti e innovativi. Una sera, durante un incontro in una libreria, mi resi conto – forse perché non lo vedevo da mesi – che era cambiato. Anche nel modo di vestire. Tutto nero, un bastone con pomello d’argento, gli occhiali tondi e scurissimi anche se era notte. Qualcuno in sala si grattava senza neppure nasconderlo tanto. Mi venne di fare una battuta e gli chiesi se si stava preparando per sostenere gli esami per la patente di pirandelliana memoria. Mi rispose tranquillo ed affabile che non aveva alcuna intenzione di esercitare una professione nella quale aveva comunque superato molti gradi di dottorato. La calma con cui mi faceva una dichiarazione ricca di tante implicazioni mi lasciò letteralmente congelato e ammutolito. Anche dopo il dibattito non ebbi il coraggio di riprendere l’argomento sia pure per soddisfare l’infinità di domande che la sua precedente risposta aveva fatto accumulare nella mia testa.
Il giorno dopo ci incontrammo però in biblioteca nazionale. Avevo avviato una ricerca sugli studi di antropologia criminale della scuola lombrosiana napoletana e stavo consultando alcuni volumi: me lo trovai seduto accanto e notai alcuni particolari che la sera precedente mi erano sfuggiti. Aveva le unghie di tutte le dita enormemente lunghe. Quelle dei mignoli erano addirittura spropositate. Il volto era rasato perfettamente ma sul collo la barba era folta e lunga. Quando si alzò mi resi conto che s’era molto incurvato sulle spalle e in modo sbilenco perché una spalla era molto più alta. I vestiti attillati rendevamo molto evidente la deformità. Mi disse che da diversi mesi stava lavorando ad una ricerca sulla jettatura a Napoli nel ‘700 e che aveva fatto delle scoperte fondamentali per la comprensione del fenomeno. Cogliendo forse lo scetticismo del mio sguardo mi guardò fisso e mi disse parlando in modo serio che la jettatura a Napoli nel ‘700 era diventata una scienza codificata in un corpus di regole e di procedure. L’impianto era quello delle dottrine esoteriche ma rivisitato attraverso l’applicazione del metodo spinoziano. Pur cominciando a nutrire dubbi sulle sue condizioni mentali, non riuscivo a frenare una curiosità che diventava sempre più grande. Quel giorno aveva però esaurito tutta la sua disponibilità e si immerse nella consultazione di testi consunti dagli anni e dall’umidità. Solo di uno riuscii a leggere autore e titolo: Gabalis, Ragionamenti sulle scienze segrete.
Continuammo a vederci tutti i giorni. Vederci e non incontrarci perché non sempre alzava lo sguardo dalle carte che consultava prendendo appunti con la mano sinistra. Anche questo mi colpì perché avrei giurato di averlo sempre visto scrivere con la mano destra. Non consultava più volumi ma fogli stampati, manoscritti, quaderni, piccoli libri che estraeva dalle buste polverose che l’addetto tirava fuori da chissà quale scaffale dell’immenso deposito della biblioteca nazionale. Si faceva sempre più curvo e sbilenco. Anche le mani sembravano attorcigliarsi come vecchie radici. Pensai che una artrite deformante lo stesse devastando in tutto il corpo.
Solo dopo settimane si sedette accanto e mi disse di essere molto vicino al completamento della ricerca anche se aveva scovato un pozzo senza fondo di notizie e informazioni sulla dottrina e sulla pratica della jettatura a Napoli, dal Settecento ai nostri giorni. Era soddisfatto perché aveva scoperto che a Napoli nel Settecento le ricerche sulla jettatura da parte di studiosi spesso insospettabili avevano prodotto non solo un accumulo di sapere ma avevano dato luogo a sperimentazioni pratiche coronate da grande successo. Molti esperimenti erano stati effettuati in pubblica adunanza sicché non si poteva parlare più di impostura e millanteria. Naturalmente ero incuriosito anche se continuavo a restare scettico. Non volle in alcun modo rivelare il nome dei tanti studiosi cui faceva riferimento. Mi disse solo che le ricerche e i loro risultati erano nascosti in molti libri che non parlavano apertamente di jettatura. Il problema era scoprire il cifrario che solo permetteva di accedere ad un sapere che doveva restare nascosto ai non iniziati proprio per la sua pericolosità sociale.
Dopo qualche sforzo, per una sorta di illuminazione, lui c’era riuscito. Questo significava che era diventato un illuminato e aveva potuto cominciare il lungo percorso dell’iniziazione. Quando diceva queste cose si illuminava nello sguardo e sembrava riprendere vigore fisico. Lo sguardo si faceva profondo, scavava abissi di interrogativi vorticosi nella mia testa, ma era l’unica cosa vitale in un corpo che sembrava avviato ad un rapido disfacimento.
Cominciò a non frequentare più assiduamente la biblioteca. Ogni volta lo vedevo sempre più curvo, più sbilenco, più aggrovigliato nelle mani, nelle braccia, nelle gambe. Anche il volto si andava deformando. Solo lo sguardo si faceva sempre più profondo, più vero, più acceso.
Poi, all’inizio dell’estate, sembrò sparire. Un’amica giornalista mi disse che stava molto male, era ricoverato in clinica e disperavano di salvarlo anche perché i medici non sapevano dare un nome alla sua malattia. Era come fosse stato colpito da decine di malattie diverse, ma per ogni parte del corpo. Qualche medico giudicava assolutamente inspiegabile la concomitante presenza di tante alterazioni fisiche e fisiologiche. Una vecchia zia sostenne con forza che l’unica spiegazione plausibile era quella della fattura a morte. Una vecchia janara fatta venire da un paese del Cilento confermò con dovizia di particolari la diagnosi aggiungendovi una definitiva condanna: si trattava di una fattura a morte aggrovigliata e inscioglibile, lo dimostrava l’intreccio delle dita delle mani e dei piedi. La vecchia zia non si arrese e fece ricorso ad un vecchio prete di Guardia Sanframondi in odore di santità e che più volte aveva scacciato il demonio dal corpo di poveri cristi posseduti. Pare che il vecchio prete si spaventasse a morte alla sola vista dell’ammalato e del suo sguardo ostile. Si allontanò subito senza neppure tirar fuori dalla tasca l’aspersorio. A qualcuno disse di avere visto il demonio.
Dopo qualche mese si riprese in modo inaspettato. Lo portarono in una casa in campagna. Lontano dai suoi libri e dalle sue ricerche sembrò rifiorire. Diventava ogni giorno sempre meno sbilenco e anche le dita delle mani e dei piedi si distesero. Un giorno me lo ritrovai di fronte nella biblioteca universitaria, quella al cortile del Salvatore. Aveva ripreso con grande lena le sue ricerche. Era soddisfatto perché aveva scoperto che le conoscenze sulla jettatura avevano continuato a tramandarsi attraverso gli iniziati. Ora stava cercando una traccia che gli permettesse di mettersi in contatto con qualcuno di loro che sicuramente esisteva a Napoli ma che si manteneva assolutamente celato. Scherzando gli dissi che dopo tanti studi poteva forse aprire una scuola. Di allievi ne avrebbe sicuramente trovati tanti. Mi guardò deluso dal mio scetticismo e mi disse che non potevo neppure immaginare quanto grande potesse essere il potere di un iniziato.
Lo incontrai ancora sempre più curvo e sbilenco e attorcigliato nelle dita.
In qualche modo e per qualche strana ragione somatizzava i suoi studi e le sue ricerche. Forse il groviglio delle dita rispecchiava il groviglio dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti. Il disfacimento fisico si accelerò improvvisamente. Lo trovarono morto nella sua stanza seduto dritto con le mani appoggiate alla scrivania, gli occhi sbarrati come a guardare qualcosa di meraviglioso o insopportabile che lo aveva fulminato e irrigidito. In quella stanza non è più entrato nessuno e nessuno ha avuto il coraggio di guardare e di raccogliere le migliaia di pagine di appunti conservati in vari faldoni, anche se in molti abbiamo sentito forte la curiosità di leggere quegli scritti per i quali Tullio aveva così rapidamente consumato la sua vita.
Qui sotto le due pagine originali
Lamberti racconto gennaio 2002
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 19 giugno 2016
IVANA LA BELLA ‘MBRIANA
di AMATO LAMBERTI
Sospeso in bilico tra il più affascinante dei sogni ed una sconvolgente realtà, ecco il racconto scritto per la Voce di febbraio 2003 da Amato Lamberti. Con un protagonista che ricorda da vicino (fin dal ‘quasi anagramma’ del cognome) lo straordinario sociologo-scrittore che tutti noi amiamo ancora.
Il vento scendeva a larghe folate giù dal Gran Sasso. Freddo, pungente, tagliava la faccia e le labbra. L’aria era tersa, di cristallo, il cielo azzurro carico tanto vicino da sembrare a portata di mano. Il secondo battaglione del Diciassettesimo Reggimento, Divisione Acqui “Martiri di Cefalonia” si apprestava a montare il campo per l’esercitazione invernale. Il colonnello aveva già dato le disposizioni generali e ciascun plotone era già intento a montare le tende sotto la guida del proprio comandante. Al plotone mortai da 120 era toccata un’area immediatamente a ridosso della pineta che da Barisciano sale a Campo Imperatore. Il sottotenente Orso Maria Bertani non aveva ancora scelto il luogo dove montare la tenda ufficiali quattro metri per quattro, pavimento in legno, teloni impermeabili. Cercava un posto tra gli alberi. Aveva voglia di un abbraccio forte di alberi, felci, animali del bosco. Passeggiava e cercava di sentire gli spiriti del luogo. Una piccola radura piena di voci fu scelta ed i fanti si misero alacremente al lavoro.
 Mentre i soldati lavoravano, il sottotenente Orso continuò a passeggiare nella pineta, un po’ per ispezionare e rendersi conto di eventuali problemi, un po’ per continuare a correre dietro ai suoi pensieri. La vita militare era per lui quasi insopportabile. Le esercitazioni rompevano però la routine ed introducevano una dimensione di gioco e di avventura che risvegliava energia e sentimenti. In quella situazione non potevano non risvegliarsi ricordi. Si trovò senza accorgersi nella pineta che da Mattie saliva a Pian Cervetto e poi all’Orsiera, sopra Bussoleno, in Val di Susa. Anche le voci sembravano le stesse. Oltre ai ghiri, alle gazze, agli scoiattoli, sentiva, come allora, i fruscii che fanno i folletti spostando i rami e lo strappare di radici dei coboldi dispettosi. Il richiamo del fante che comunicava il termine del lavoro di montaggio della tenda lo riportò nella pineta che da Barisciano porta a Campo Imperatore, vicino L’Aquila, in Abruzzo. Il bello delle esercitazioni erano le serate trascorse in piccoli paesi dove non si poteva fare altro che passeggiare, bere e mangiare ma dove si facevano tanti incontri. Per paesini come Barisciano, quattrocento – cinquecento anime, l’arrivo dei militari impegnati nelle esercitazioni era una festa ed un afflusso di denaro. Si fittavano camere per gli ufficiali, si aprivano locande e trattorie, bar e negozi si riempivano di avventori. Si diffondeva un’allegria contagiosa perché veramente tutti erano felici. I giovani, e soprattutto le ragazze, impazzivano ed impazzavano. Fino a notte fonda il paese era illuminato, pieno di voci, di canti, di risate. Una festa continua, come un Carnevale di giorni e settimane, dove molte regole saltavano o venivano per qualche tempo accantonate.
Mentre i soldati lavoravano, il sottotenente Orso continuò a passeggiare nella pineta, un po’ per ispezionare e rendersi conto di eventuali problemi, un po’ per continuare a correre dietro ai suoi pensieri. La vita militare era per lui quasi insopportabile. Le esercitazioni rompevano però la routine ed introducevano una dimensione di gioco e di avventura che risvegliava energia e sentimenti. In quella situazione non potevano non risvegliarsi ricordi. Si trovò senza accorgersi nella pineta che da Mattie saliva a Pian Cervetto e poi all’Orsiera, sopra Bussoleno, in Val di Susa. Anche le voci sembravano le stesse. Oltre ai ghiri, alle gazze, agli scoiattoli, sentiva, come allora, i fruscii che fanno i folletti spostando i rami e lo strappare di radici dei coboldi dispettosi. Il richiamo del fante che comunicava il termine del lavoro di montaggio della tenda lo riportò nella pineta che da Barisciano porta a Campo Imperatore, vicino L’Aquila, in Abruzzo. Il bello delle esercitazioni erano le serate trascorse in piccoli paesi dove non si poteva fare altro che passeggiare, bere e mangiare ma dove si facevano tanti incontri. Per paesini come Barisciano, quattrocento – cinquecento anime, l’arrivo dei militari impegnati nelle esercitazioni era una festa ed un afflusso di denaro. Si fittavano camere per gli ufficiali, si aprivano locande e trattorie, bar e negozi si riempivano di avventori. Si diffondeva un’allegria contagiosa perché veramente tutti erano felici. I giovani, e soprattutto le ragazze, impazzivano ed impazzavano. Fino a notte fonda il paese era illuminato, pieno di voci, di canti, di risate. Una festa continua, come un Carnevale di giorni e settimane, dove molte regole saltavano o venivano per qualche tempo accantonate.
Anche il sottotenente Orso, nonostante un carattere che ben si attagliava al nome, finiva sempre per essere contagiato dal clima di festa. D’altra parte era difficile tenersi fuori. La sera necessariamente si scendeva in paese, tutti tranne il picchetto di guardia, e si finiva in trattoria, dopo aver passeggiato, incontrato persone per la strada o nell’unico bar del paese. Il sabato la festa si trasferiva in piazza. Veniva gente anche dai paesi vicini. Si accendeva un gran fuoco. Vecchi e giovani cantori facevano musica con fisarmoniche e vecchi strumenti. Si ballava, si beveva, si parlava, si intrecciavano amicizie e brevi amori.
Anche se era martedì, la sera dell’arrivo del battaglione in paese fu festa grande. Un grande falò alimentato da fascine di rovi illuminava la piazza, addobbata di luci come per la festa del santo Patrono. Un gruppo folkloristico con i vestiti sgargianti della tradizione suonava, cantava, ballava accompagnato da una folla di giovani ed anziani. Davanti al bar, alla trattoria, ad alcune case tavoli pieni di bicchieri e di brocche di vino. I militari arrivavano a gruppi così come erano usciti dal campo e subito si lanciavano nei balli, nei canti, sulle brocche e sulle ragazze. Ma alla festa non partecipavano solo i giovani, anzi erano proprio le donne più anziane a sfrenarsi nelle danze tradizionali e ad invitare le giovani ad abbandonare la ritrosia che le faceva fermare al limitare della piazza.
Anche il sottotenente Orso raggiunse la piazza insieme ai suoi soldati ma un po’ in disparte. Non riusciva a legare con gli altri ufficiali per via della loro “grosserie”, figuriamoci con i suoi fanti, quasi tutti semianalfabeti. Da loro amava però farsi raccontare la vita dei paesi da cui provenivano e, soprattutto, le tradizioni legate al ciclo della nascita, della malattia e della morte. Continuava, praticamente, a coltivare i suoi studi etnologici e le sue curiosità sui rituali magici e stregoneschi. Giunto in piazza, conquistò un tavolino all’esterno della trattoria, ordinò delle olive nere, del formaggio pecorino, del vino, e si mise ad osservare il movimento della piazza che si faceva sempre più frenetico.
Ormai molte diffidenze erano state superate, militari e ragazze del luogo avevano familiarizzato. Si formavano tavolate all’interno ed all’esterno, ma il cibo era solo un pretesto per liberare i rapporti ed il vino serviva a sciogliere la lingua ed accendere il cuore.
Mentre osservava la piazza, il sottotenente Orso notò una figurina tutta vestita di nero, come infagottata in un paio di pantaloni larghi ed in un maglione di quelli fatti a mano in casa sempre un po’ sbilenchi. Faceva freddo, non aveva neppure un soprabito, si muoveva per la piazza tra la gente che ballava e cantava, come se cercasse qualcosa o qualcuno. Orso continuò ad osservarla ed ebbe come l’impressione che i movimenti della donna, che la portavano ad avvicinarsi di più e ad allontanarsi di poco rispetto al suo tavolino, avessero una sola logica, quella di attirare la sua attenzione. Questo pensiero lo fece alzare per andare incontro alla donna. «Posso aiutarla, forse ha perso qualcosa ?» le disse con molta semplicità. Lei alzò lo sguardo e gli mostrò il suo volto. Orso fu colpito come da una apparizione. Due occhi immensi, neri, profondi come un pozzo senza fine. Un volto antico di genti italiche, bruna come abbronzata, capelli corvini. Restò sbigottito e senza parole. Lo tolse lei dall’imbarazzo : «Avevo appuntamento con amici ma non sono ancora arrivati». «Potrei farle compagnia in attesa del loro arrivo», osò Orso e la invitò a sedersi al suo tavolo. Lei accettò con grazia e con un sorriso che le rese ancora più dolce il volto.
Dalle presentazioni Orso scoprì che si chiamava Ivana, che era di Barisciano ma aveva studiato prima a L’Aquila, poi a Firenze in un collegio per ragazze della buona borghesia, l’università l’aveva frequentata a Bologna. Era laureata in lettere, insegnava nella scuola media di un paese vicino, raccoglieva storie, canti, leggende di quella parte d’Abruzzo. Naturalmente l’interesse comune per le tradizioni popolari accese l’entusiasmo ed Orso vinse completamente la sua naturale ritrosia. Mentre mangiavano quasi senza accorgersene i piatti che la padrona della trattoria serviva personalmente illustrandone la composizione e la storia, si accesero entrambi in una discussione sulle tradizioni popolari e sul ruolo che esse potevano avere in una società avviata ad una modernizzazione scomposta, disarticolata, ma sempre più accelerata.
Ivana si dimostrò molto combattiva nella difesa della sua tesi che assegnava alle tradizioni popolari un valore che andava al di là della storia e della memoria da conservare. Per lei erano l’espressione di un pensiero fondato sul magico, sull’irrazionale, sui cicli della natura che inutilmente il pensiero razionalistico tentava di cancellare.
Orso ne era affascinato. Il suo naturale scetticismo si incrinava ad ogni parola di Ivana. Trovò anche il coraggio di esprimere i dubbi che lo tormentavano rispetto alle azioni rituali delle fattucchiere che annodavano e scioglievano destini fissati nelle “fatture”. Nella discussione gli sguardi s’incrociavano continuamente. Orso aveva ogni volta l’impressione di precipitare nelle profondità di quegli occhi neri. Pensò che al fondo ci fosse un fuoco molto più ardente di quello che bruciava in piazza. Dopo gli sguardi s’incrociarono anche le mani. Orso l’afferrò come per sorreggersi e non precipitare. Ivana sorrise, si accostò e gli mise per un attimo la testa sulla spalla.
In piazza tutti continuavano a ballare ed a cantare. Il vino aveva fatto bene il suo lavoro e la felicità avvolgeva tutti di un mantello d’ardore. Anche il cuore di Orso batteva più forte, tanto da bloccargli spesso le parole. Anche la voce di Ivana si spezzava a tratti. Orso continuava a parlare di fatture e fattucchiere ma il pensiero era altrove, in quegli occhi e tra quei capelli. Quando Ivana gli disse che s’era fatto tardi e che preferiva rientrare a casa, dato che comunque doveva alzarsi presto l’indomani, fece fatica ad allontanare i pensieri immersi nel sogno ed a rientrare nella realtà. Mentre si alzava, Orso si rese conto che forse Ivana tremava anche per il freddo che si era fatto più tagliente. La avvolse tutta con il suo giaccone imbottito e si avviarono attraverso la piazza verso la casa di Ivana.
Camminarono tenendosi stretti quasi senza parlare, lasciando correre liberamente i pensieri. Sull’uscio di casa, dopo aver aperto la porta, Ivana si girò e gli diede un bacio sulla bocca guardandolo fisso negli occhi. Poi scomparve dietro la porta, appena illuminata da un lampione stradale. Orso restò qualche minuto inebetito, poi si avviò lentamente verso il campo. L’autista, infreddolito, gli fece notare che aveva dimenticato il giaccone. Solo allora si rese conto che l’aveva lasciato ad Ivana e ne fu felice. L’indomani si sarebbe recato a casa per riprendersi il giaccone ed incontrarla di nuovo.
Non riuscì a dormire tanta era l’agitazione. Nella sua vita non si era mai trovato in una situazione di così forte sconvolgimento. Anche la giornata di esercitazioni passò come in un sogno. I soldati si meravigliavano della sua assenza mentale rispetto alle operazioni in corso. Qualcuno disse sottovoce che sicuramente il tenente si era innamorato. Nel pomeriggio fu il primo ad uscire dal campo. Di corsa, con il cuore in gola, tentando inutilmente di vincere l’agitazione, arrivò alla casa dove aveva accompagnato Ivana la sera prima. Davanti alla porta si rese conto che non c’era il campanello, ma solo un batacchio a forma di mano di donna. Bussò un paio di volte timidamente. Poi più forte. Nessuno rispondeva. Una strana agitazione lo faceva tremare tutto.
Nessuna risposta, tutto chiuso, quella casa sembrava disabitata. Mentre continuava a battere il batacchio, la voce di una vecchina, che poi vide girandosi affacciata alla finestra della casa di fronte, gli chiese: «Bel giovane, cosa cercate in quella casa?». Orso rispose: «La signorina Ivana, la professoressa». La vecchina lo guardò interdetta: «Bel giovane, in quella casa non abita più nessuno da almeno dieci anni e la signorina Ivana è morta, poverina, quindici anni fa per una broncopolmonite. Andava vestita sempre troppo leggera. Una ragazza bellissima che faceva impazzire gli uomini con gli occhi, ma nessuno ha potuto mai toccarla. Poverina, tanto bella e tanto sfortunata».
Orso restò impietrito. Avrebbe voluto dire che con Ivana aveva trascorso tutta la sera, avevano mangiato, bevuto e parlato. Ricordava tutte le cose che gli aveva detto, sentiva ancora sulle labbra le sue labbra. La vecchina, con voce di compassione, lo distolse dai suoi pensieri: «Bel giovane, se non ci credete entrate pure nella casa, la porta è aperta». Orso si precipitò dentro. La casa era vuota, abbandonata da anni, polvere e calcinacci ovunque, neppure un mobile. Solo nell’ultima stanza una sedia impagliata con, appoggiato sopra, il suo giaccone. Un raggio del sole al tramonto riempiva la stanza di luce.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Racconto di Domenica 12 giugno 2016
NOI, SPIRITI INQUIETI DENTRO NAPOLI
di AMATO LAMBERTI
Ancora l’incredibile che diventa realtà. Accade in un nuovo racconto di ordinario spiritismo e di straordinario fascino scritto per la Voce nel gennaio 2003 da Amato Lamberti. Dove sono ora, “loro”? Cosa fanno dopo la morte. Vagano? Restano? Cambiano? Interrogativi e misteri che, dentro una Napoli surreale, trovano risposta.
 Napoli è una città che di notte è abitata più dagli spiriti che dagli uomini. Non è facile per nessuno distinguerli. Si confondono benissimo con la popolazione miserabile che aspetta la notte per cercare di guadagnarsi la sopravvivenza. Ci sono spiriti che tutte le sere ritrovi nello stesso posto a fare le stesse cose. Tu pensi che siano persone, e invece no, sono spiriti, trapassati che si sono stabiliti a Napoli, provenienti dai posti più diversi».
Napoli è una città che di notte è abitata più dagli spiriti che dagli uomini. Non è facile per nessuno distinguerli. Si confondono benissimo con la popolazione miserabile che aspetta la notte per cercare di guadagnarsi la sopravvivenza. Ci sono spiriti che tutte le sere ritrovi nello stesso posto a fare le stesse cose. Tu pensi che siano persone, e invece no, sono spiriti, trapassati che si sono stabiliti a Napoli, provenienti dai posti più diversi».
Mentre ‘il professore’ parlava, un gruppetto di persone sedute ai tavolini sgangherati di una trattoria ai Tribunali annuiva con l’aria di chi queste cose già le sapeva. Lo chiamavano ‘il professore’ perché molti anni addietro – ormai superava gli ottanta anni – aveva insegnato davvero in un Istituto privato di cui poi era diventato proprietario sposando la figlia del titolare.
Una ragazza istruita, insegnava pianoforte, tutta casa e chiesa, una di una bruttezza fuori dal normale anche per via di una doppia flessione della colonna vertebrale e di una diffusa pelosità, tanto copiosa da farle meritare il soprannome di scignetella. Con il matrimonio si era sistemato, aveva trovato una casa, un lavoro stabile, una proprietà e si era potuto dedicare agli studi più improbabili. Le sue passioni erano l’alchimia e l’occultismo.
Nel rione da anni si raccontavano storie dei suoi commerci – come dicevano i preti – con i morti, le anime vaganti, il diavolo. Ma non era uno scomunicato: frequentava la parrocchia, partecipava alle funzioni religiose, a Pasqua si faceva anche la comunione. Naturalmente le sue teorie sollevavano anche numerosi dubbi, ma erano in molti quelli che ne erano affascinati.
Ogni sera, vivendo ormai da solo, si fermava a mangiare qualcosa sempre nella stessa trattoria e diverse persone lo aspettavano per sentirlo parlare. Quella sera c’erano anche due nuovi ascoltatori. Nuovi perché nessuno li aveva mai visti prima, né in trattoria, né nel rione. Non sembravano neppure conoscersi. Erano entrati separatamente. Si erano seduti a tavoli diversi. Il primo dimostrava cinquanta anni mal portati, forse infagottato com’era in una giacca di diverse misure più abbondante della sua taglia e con i capelli grigi arruffati dal vento e dal lontano ricordo di una spazzola. Il secondo aveva forse la stessa età ma sembrava più giovane per via dei capelli impomatati e di un vestito ben curato. Sembravano interessati ai discorsi del professore ma non annuivano, si limitavano ad osservarlo.
 «Quanta gente – continuava il professore – incontrate tutte le notti per la strada? Qualcuno lo incontrate anche di giorno, ma altri no, non li incontrate mai di giorno. Come mai? dove stanno? cosa fanno di giorno? Non ve lo siete mai domandato perché non avete mai realizzato che dietro quelle facce potessero nascondersi delle anime vaganti. Io invece ho studiato a lungo questi fenomeni di cui molti libri parlano e sono giunto ad una conclusione: quando si muore si resta sulla terra, non si va da nessuna altra parte. L’unica differenza è che non si può più uscire di giorno. Sei condannato a vivere di notte. E puoi scegliere anche dove. Magari sei morto in un piccolo paese e sognavi di vivere a Napoli, nella grande città. Da morto puoi fare quello che da vivo non avevi mai potuto fare, vivere a Napoli, vivere nella capitale. Molti stranieri da morti vengono a vivere a Napoli, soprattutto francesi e tedeschi, ma anche qualche americano. E proprio questi stranieri che incontri solo di notte mi hanno fatto capire il mistero. Se fossero vivi che ci farebbero in giro di notte per la città?».
«Quanta gente – continuava il professore – incontrate tutte le notti per la strada? Qualcuno lo incontrate anche di giorno, ma altri no, non li incontrate mai di giorno. Come mai? dove stanno? cosa fanno di giorno? Non ve lo siete mai domandato perché non avete mai realizzato che dietro quelle facce potessero nascondersi delle anime vaganti. Io invece ho studiato a lungo questi fenomeni di cui molti libri parlano e sono giunto ad una conclusione: quando si muore si resta sulla terra, non si va da nessuna altra parte. L’unica differenza è che non si può più uscire di giorno. Sei condannato a vivere di notte. E puoi scegliere anche dove. Magari sei morto in un piccolo paese e sognavi di vivere a Napoli, nella grande città. Da morto puoi fare quello che da vivo non avevi mai potuto fare, vivere a Napoli, vivere nella capitale. Molti stranieri da morti vengono a vivere a Napoli, soprattutto francesi e tedeschi, ma anche qualche americano. E proprio questi stranieri che incontri solo di notte mi hanno fatto capire il mistero. Se fossero vivi che ci farebbero in giro di notte per la città?».
A questo punto l’avventore nuovo, quello impomatato, intervenne con aria saccente: «Scusate, professore o come vi chiamate, a me sembra che la vostra teoria sia fondata solo su illazioni. Basterebbe chiedere a queste persone dove abitano e cosa fanno di giorno. Magari girano di notte per la città solo per guadagnare qualcosa. Ma anche per curiosità, per sete di avventure e di incontri, perché sono soli, perché vorrebbero fare qualcosa di eccitante». L’accento tradiva una provenienza non napoletana, forse lucana o molisana, e qualche studio alle spalle.
Il professore non sembrò seccato dell’intervento. «Non sarei così sicuro delle mie affermazioni se in tanti anni non avessi fatto centinaia, che dico, migliaia di verifiche. Ma di notte si incontra gente strana che magari ti dice che è a Napoli per lavoro, per cercare clienti per la sua azienda, il suo commercio, e poi si ferma per mesi. Certo, un giorno non li incontri più nelle zone abituali e pensi che se ne siano andati. Ma si sono spostati solo in un’altra zona della città. Tutti ti danno un indirizzo ma è così impreciso che non li ritrovi mai».
Il primo nuovo avventore, quello con i capelli arruffati, lo interruppe con tono quasi seccato. L’accento sembrava siciliano ma poteva essere anche calabrese. «Ammettiamo pure che lei abbia ragione e che i morti restano tra noi vivi con la limitazione di potersi muovere solo di notte. Essendo morti non dovrebbero avere le stesse esigenze di noi vivi, cioè mangiare, bere, dormire ad esempio. Per cui se uno mangia e beve è vivo. Se non mangia e non beve è morto. Io non ho mai incontrato qualcuno che non mangia, non beve e non ha nessun problema».
 Il professore lo guardò con un’aria come di commiserazione «Ma lei non può pensare di comprendere le mie osservazioni utilizzando le sue vecchie categorie di vivo e di morto. E chi le dice che i cosiddetti morti non abbiano corpo e bisogni corporali. Io non ho detto che sono ombre. Ho usato il termine spiriti per distinzione, ma anche i cosiddetti morti sono in qualche modo viventi».
Il professore lo guardò con un’aria come di commiserazione «Ma lei non può pensare di comprendere le mie osservazioni utilizzando le sue vecchie categorie di vivo e di morto. E chi le dice che i cosiddetti morti non abbiano corpo e bisogni corporali. Io non ho detto che sono ombre. Ho usato il termine spiriti per distinzione, ma anche i cosiddetti morti sono in qualche modo viventi».
«La discussione si fa filosofica – osservò l’avventore impomatato – ma si capisce anche che il professore non ha completato la sua teoria. Anche io ho maturato qualche esperienza – e sogghignò beffardo – su questi fenomeni come li chiama lei, professore. Personalmente mi sono fatto la convinzione che non tutte le anime vaganti restino sulla terra tra i vivi. La maggior parte preferisce ricollocarsi e ricominciare una vita tutta nuova».
Il professore sorrise di soddisfazione. «E’ la teoria della metempsicosi. Anche io comincio a pensare che quando si muore si hanno diverse possibilità di scelta perché l’anima non può morire e si deve trovare una collocazione. Il problema è se ha possibilità di scelta o c’è qualcun altro che decide. E comunque molti restano sulla terra e si confondono con i vivi. Non so se per loro decisione o per condanna».
L’interlocutore arruffato, alzandosi per uscire, aggiunse, guardando l’altro impomatato: «Bisognerebbe anche interrogarsi sulla durata di questa decisione o condanna. Per l’anima il tempo è interminabile. Se tutto quello che dite fosse vero – ma io sono assolutamente scettico – la spiegazione andrebbe ricercata molto lontano nel tempo, anzi all’inizio del tempo. Ognuno di noi che sta qui in questo momento avrebbe avuto innumerevoli vite di cui da qualche parte dovrebbe conservare almeno un lontano ricordo. Forse nei sogni brandelli di queste vite trascorse possono a volte riaffiorare. O forse la vita stessa è un sogno».
Lentamente anche gli altri lo seguirono e nella trattoria restarono soltanto il professore e l’avventore impomatato. Si guardarono negli occhi per un attimo. «Ho capito – disse il professore – sei venuto a dirmi che anche questa esperienza è finita. Mi ricordo, come fosse ieri, quando più di ottant’anni fa, ed allora ero solo un bambino imprudente precipitato dal tetto, mi consigliasti di ricominciare. Ero pieno di rabbia, volevo continuare a vivere, a giocare, a correre ma il mio corpo giaceva già rigido tra le pietre nel prato. Non volevo ricominciare, volevo continuare. Ora mi sono chiare molte cose ma tra poco tutto sarà come sepolto e dimenticato. Questa volta vorrei restare qualche giorno ancora sulla terra, ma non qui a Napoli: mi piacerebbe tornare nel paese dove sono nato e cresciuto da ragazzo, giusto per vedere com’è cambiato in questi anni».
Nella foto grande il Palazzo degli Spiriti a Marechiaro.
Qui il pdf originale del racconto
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 5 giugno 2016
Il maggiore esperto di camorra e sistemi criminali, lo studioso che intuì per primo la penetrazione della piovra mafiosa nelle istituzioni, lo sbarco all’estero dei clan (sue le ricerche d’inizio ’90 sugli investimenti scozzesi), il ruolo dei colletti bianchi, la seconda generazione dei rampolli che studiano ad Harvard o a Cambridge, il “lavoro” che lo Stato non dà (“la camorra è la Fiat del Sud”, diceva vent’anni fa). Fu il mitico fondatore dell’Osservatorio sulla camorra, Amato Lamberti, dove si formò a inizio ’80 Giancarlo Siani, che il “prof” sentì per telefono la sera prima del tragico assassinio: assicurati i killer – ha sempre sottolineato – sempre a volto coperto i mandanti. Come per le stragi di Capaci e via D’Amelio, e ancor prima per l’esecuzione di Aldo Moro. E lui, Lamberti, vedeva più lontano di tutti, e anni prima di tutti. Un torto gravissimo.
Un’intelligenza straordinaria, la sua, lontana anni luce dai livelli della classe politica di casa nostra. Eppure si tuffò in quell’arena, fu presidente della storicamente gavianea Provincia di Napoli, che arrivato lui buttò fuori i clan da appalti e subappalti (strade, scuole, fogne), riemerse dal dissesto e risanò in modo miracoloso i suoi conti pubblici. Proprio per questo non fece altra strada politica, né andò a sedere in parlamento, ma tornò alla sua Sociologia: troppo scomodo, alternativo, prassi e linguaggi del tutto diversi.
Una cultura sconfinata. Un’erudizione smisurata. E una vena artistica che la Voce ha avuto la fortuna di incontrare anni fa, una quindicina, quando pubblicammo alcuni suoi racconti. Che oggi, a quattro anni dalla scomparsa – un male divorante lo portò via il 28 giugno 2012 – offriamo come dono prezioso a chi ci segue. (a. c.)
GIOVANNI E’ TRA NOI
di Amato Lamberti
La giornata era radiosa, come spesso accade a Roma agli inizi della primavera. L’aria frizzante sotto un cielo luminoso d’azzurro accelerava la produzione di pensieri, di idee, di voglia di fare qualcosa di importante. Nemmeno il tanfo, l’odore acre, il rumore assordante di una metropolitana come al solito stipata di gente di tutti i colori e gli odori riusciva non dico a togliermi ma ad intaccare quel sentimento di benessere che mi vibrava per tutto il corpo.
La luce di Piazza di Spagna mi colse d’improvviso all’uscita del corridoio stretto di mura e di case. Con gli occhi abbacinati coglievo odori e voci forse già sentiti ma che oggi mi sorprendevano come del tutto nuovi ed inaspettati. Mentre attraversavo la piazza per raggiungere via Condotti, mi sorprese il pensiero che quella era forse una giornata particolare nella quale le decisioni che di lì a poco dovevo prendere avrebbero avuto grande importanza. Ero così preso dai miei pensieri che sentendomi chiamare per nome pensai ad un segno definitivo di suggello di una giornata che si apprestava a diventare straordinaria.
A chiamarmi ripetutamente dal marciapiede opposto e poi sempre più vicino era Giovanni C., un amico carissimo che non vedevo da anni e con il quale avevamo trascorso anni di grande entusiasmo intellettuale e creativo prima a Trieste e poi a Roma. Non era cambiato per nulla, lo stesso sorriso, la stessa barba sessantottina. Solo il segno di due lunghe cicatrici sulla fronte quasi all’attaccatura dei capelli e sulla guancia destra nascosta a tratti dalla barba. Un lungo abbraccio e poi tante domande reciproche. Come stai, cosa fai, cosa hai fatto di bello in questi anni, dove sei stato, dove stai ora. Decidemmo di fermarci al caffè Greco nella saletta in fondo per poter parlare come facevamo con gli altri amici tanti anni prima, soprattutto quando dovevamo progettare qualche iniziativa.
Ci piaceva il clima del caffè Greco anche se gli artisti erano sempre meno e sempre di più i turisti. Ma anche quelle voci straniere in lingue che non conoscevi o che conoscevi poco creavano un’atmosfera che stimolava il cervello e faceva sembrare più importanti le parole che si dicevano. Delle cicatrici mi disse che erano il ricordo certamente non piacevole di un pauroso incidente dal quale, per molti versi, non si sarebbe più ripreso. In quel momento stava a Roma per risolvere alcune questioni con le persone che ’avevano procurato. Cose noiose ma purtroppo necessarie. Mi colpì il ricordo con cui disse purtroppo – l’aria sembrava immobile – ma parlammo soprattutto d’altro. Dei progetti di lavoro che aveva realizzato girando mezzo mondo con le sue macchine fotografiche, le sue cineprese, i suoi taccuini.
Gli avevo sempre invidiato la sua capacità di mettersi in viaggio inseguendo un’idea e organizzandosi in pochissimi giorni. Partiva sempre con pochissimo bagaglio perché gli piaceva mimetizzarsi nei posti dove andava indossando i panni delle persone con cui doveva entrare in contatto o con cui doveva mescolarsi. Come una volta restai affascinato dai suoi racconti. Aveva la straordinaria capacità di raccontarti le esperienze fatte facendotele vivere da spettatore sul posto. Naturalmente dovetti raccontare a mia volta quello che avevo fatto negli anni in cui non c’eravamo visti; ma per quanto mi sembravano prima interessanti, al confronto delle sue mi apparivano sbiadite ed anche un po’ banali. Forse perché legate ad un quotidiano che quando ci stai dentro ti può sembrare anche eroico, ma quando le racconti, e quindi te le metti di fronte, finiscono per apparire molto più ordinarie.
C’eravamo persi di vista nel 19977 perché io avevo scelto l’università e lui, come diceva, la vita. Poiché la sua creatività era senza limiti, come testimoniavano i brain-storming che dietro compenso faceva per agenzie di pubblicità, aveva deciso che la sua professione sarebbe stata quella di venditore di idee, di progetti, di sogni. Anche per questo lo invidiai molto. Decise di affrontare il viaggio della vita con la stessa nonchalance con la quale affrontava il viaggio nel paese più sperduto e disagiato del mondo senza farsi neppure il problema dei soldi che sarebbero stati necessari.
Gli raccontai così le lotte alle quali avevo partecipato, i movimenti di cui avevo fatto parte, le iniziative politiche portate a termine e quelle fallite nonostante tutti gli sforzi. Evitai di parlare delle tante disillusioni, dei sogni infranti, delle sconfitte, ma il suo sguardo era troppo acuto, perché mi disse che mi vedeva più segnato da cicatrici mal rimarginate di quanto lui stesso non fosse. Passammo insieme due ore, dilatate a dismisura dalle parole, dalle sensazioni, dai ricordi, bevendo due caffè e due pastis tanto per ricordare i tempi del bar Terzerteo a Trieste. Ci salutammo commossi con la promessa di rivederci. Gli avevo lasciato tutti i miei recapiti. Mi avrebbe cercato lui perché stava in giro e, come sempre, non aveva fissa dimora.
La giornata era sempre ridente e l’aria frizzante ma l’incontro con Giovanni mi aveva cambiato d’umore. Sentivo come un rimpianto per scelte che non avevo avuto il coraggio di fare. Raggiunsi senza quasi rendermene conto il luogo di riunione in piazza Sant’Eustachio. Mi resi conto davanti al portone che avevo traversato piazza del Pantheon senza neppure vederla, eppure non credo fosse deserta. Naturalmente ero in ritardo mostruoso. A Saro che mi venne incontro chiedendomi che fine avevo fatto risposi che forse non mi avrebbe creduto, ma avevo incontrato dopo tanti anni Giovanni. Giovanni chi? Giovanni C. ti ricordi? Te lo presentai a Bologna e poi avete fatto insieme quel bellissimo documentario… Saro mi guardava perplesso e serio. Giovanni C. è morto due tre mesi fa in un incidente d’auto sull’autostrada Roma-L’Aquila. E’ stato investito da un’auto mentre cambiava una gomma sulla corsia d’emergenza. Non solo non l’hanno soccorso, forse si poteva salvare, ma l’hanno anche derubato di tutto portafogli, orologio, catenina e naturalmente macchina fotografica e cinepresa. Per il medico legale è morto dopo almeno due ore di agonia. Potevi trovare una scusa migliore.
La voce e lo sguardo di Saro erano severi e tristi. Erano diventati grandi amici. Anche lui non si era potuto sottrarre alla fascinazione dell’incontro con Giovanni. Restai muto e sconvolto. Non so cosa dirti, Giovani l’ho incontrato davvero. Ci siamo fermati al caffè Greco. Ci hanno visti diverse persone. Qualcuno ci ha anche salutati. Abbiamo bevuto insieme un caffè e un pastis per ricordare i tempi di Trieste. Aveva anche due profonde cicatrici, una sulla fronte, una sulla guancia destra. Mi aveva detto che stava in giro per risolvere questioni con le persone che avevano causato l’incidente. Fossi al posto di quelle persone sarei molto preoccupato, mi disse beffardo Saro, ma tu devi aver sognato ad occhi aperti, a meno che non ti sei proprio addormentato al caffè Greco nel tuo solito angolo in fondo all’ultima sala. Comunque la riunione l’abbiamo aggiornata al prossimo venerdì. Senza salutarmi se ne andò lasciando aperta la porta. Non so come fosse la giornata fuori. Attorno a me era scesa una cappa di nebbia. La testa mi ronzava forte e le pareti della stanza sembravano muoversi oscillando. Mi sedetti, tirai fuori dalla tasca lo scontrino del caffè Greco. Inequivocabile due caffè, due aperitivi, ora, giorno, mese, anno. Giovanni l’avevo veramente incontrato. Chissà ora dove poteva stare. Magari potevo cercarlo in giro per Roma. Potevo anche essere fortunato. Non ero particolarmente sconvolto per il fatto di averlo incontrato. Mi aveva sconvolto molto di più il breve racconto della sua orribile fine.
Non fine, morte. Perché con la morte non finisce niente. Ho sempre pensato che i morti non vanno da nessuna parte. Restano tra noi. E prima o poi li incontri. L’importante è riconoscerli. Non sempre ciò che si vede è riconosciuto.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 29 maggio 2016
UN ANNO SUL MONTE ALBANO
di Bruno Fedi
Pubblichiamo la prefazione di Bruno fedi ad un volume dedicato alla resistenza dei cittadini di Pistoia, scritto da Ivan Illich e di prossima pubblicazione. Un vero “racconto” in presa diretta di quel tragico anno.
Tutti morimmo a stento, tirando calci al vento
Vedemmo sfumar la luce
Dalla fine della guerra è trascorso moltissimo tempo, ma le conseguenze degli avvenimenti si sentono ancora. La più grave sconfitta subita dall’Italia, la dissoluzione di un intero esercito, anzi di uno Stato, in poche ore, le gravissime violenze ed atrocità che ne seguirono, la quasi totale distruzione del Paese, sono tutte ferite non rimarginate, perché le ragioni che determinarono i fatti non sono state mai eliminate. Per questa ragione un libro che riporti una documentazione che dimostri la verità, come quello di Ivan Illich, ha un grande merito: è una fonte di prove. Questo è importante per opporsi ai tentativi di falsificazione storica, tendenti a mettere sulla stesso piano coloro che difesero la giustizia, il diritto alla libertà e coloro che erano pronti a lasciare il proprio Paese alla “razza superiore”, pur di poter continuare a commettere prepotenze e delitti.
Nel dopoguerra, in nome di principi astratti come la “pacificazione degli animi” e la ”continuità dello stato”, non fu fatta giustizia, anzi chi poteva essere d’impaccio fu come minimo emarginato. O qualcosa di più. Il giudizio sulla situazione è complicato dall’aver visto molti fatti con i miei occhi. Aver visto la viltà, l’ incapacità assoluta, la meschinità, l’interesse personale non puniti, anzi spesso premiati, influenza il giudizio. Tuttavia, il lungo tempo trascorso conferisce il vantaggio della conoscenza dei fatti, dell’intera vicenda bellica, nonché delle conseguenze successive. Dunque, il punto di vista diretto e lontano nel tempo è privilegiato.
Ci sono, nel libro di Illich, molti più fatti che in altri libri sull’argomento; si inserisce la resistenza pistoiese nel quadro generale della guerra ed in quello del comportamento dei vertici politico- militari. Nel periodo successivo alla Grande Guerra c’era stata una vasta acquiescenza al regime fascista. I fascisti avevano commesso ogni sorta di violenze e delitti ma, paradossalmente, raggiunsero il potere come restauratori dell’ordine pubblico. Ne risultò un regime di falsità assoluta, sfortunatamente continuata anche nel secondo dopoguerra. Il perbenismo apparente, la pseudo-grandezza ostentata dal regime, erano assolute falsità. L’arretratezza del Paese, invece, era reale ma non percepita dai cittadini: era nascosta da fiumi di parole. In questa situazione gli operai diventano fascisti di facciata. Si instaura un costume che presto diventa la prassi comune: “Facciamo finta che…”. Si sostituisce l’essere col sembrare. Per esempio, si fa finta che non esistano mafia e camorra: mafiosi e camorristi si chiamano latitanti.
Tutto è reso evidente dai documenti, nel libro di Illich. Questa finzione dura vent’anni, fino alla fine della guerra. Non giova all’Italia, nei rapporti internazionali, ma all’interno non viene avvertita. Viene intuita solo da alcuni che sono a conoscenza di quanto accade all’estero e sono sensibili a prepotenze, favoritismi, irrealtà della situazione. Nasce una convinzione: “Chi ha amici e quattrini può tutto”. E’ un ventennio di retorica asfissiante; le frasi di Mussolini sono su tutti i muri. Alcune sono particolarmente idiote, ma suscitano ammirazione egualmente. L’arroganza e la gerarchia dominano ogni settore, anche il più banale. I cinema sono pieni, la gente sta in piedi, ma la prima fila è vuota: è riservata alle autorità. I più tartassati sono i più poveri, che però non si rendono conto. Di ciò che non funziona, non si può scrivere sui giornali. I funzionari statali sono gratificati economicamente e come status sociale: dunque, sono favorevoli.
 Di tutto questo, è emblematica la storia di Silvano Fedi. La famiglia è borghese, dunque non sospetta per il regime. Si tratta di commercianti che hanno combattuto nella grande guerra e sono tornati feriti e mutilati. Ma, al contrario di molti ex combattenti, non approvano la violenza. La madre di Silvano, è una maestra; un intellettuale, per quei tempi. Vuole che i suoi figli siano professionisti, non commercianti. Così Silvano vive in un clima in cui c’è il senso di onestà del commerciante ottocentesco e si valuta molto la cultura. Silvano è avido di sapere: legge tutto, specialmente ciò che è proibito. Scopre gli anarchici e si forma una personalità libertaria. Nelle conversazioni con i compagni di liceo, esprime opinioni non conformi all’oppressivo regime. Viene arrestato e fa alcuni mesi di galera. In questo periodo, viene in contatto diretto con la brutalità del regime. Viene rilasciato in seguito a circostanze favorevoli, ma adesso è un antifascista pronto a combattere, mentre il regime gode di un effimero consenso, quasi generale. Ciò in seguito al crimine, particolarmente odioso, dell’aggressione all’Abissinia, che però sembra coronato da successo.
Di tutto questo, è emblematica la storia di Silvano Fedi. La famiglia è borghese, dunque non sospetta per il regime. Si tratta di commercianti che hanno combattuto nella grande guerra e sono tornati feriti e mutilati. Ma, al contrario di molti ex combattenti, non approvano la violenza. La madre di Silvano, è una maestra; un intellettuale, per quei tempi. Vuole che i suoi figli siano professionisti, non commercianti. Così Silvano vive in un clima in cui c’è il senso di onestà del commerciante ottocentesco e si valuta molto la cultura. Silvano è avido di sapere: legge tutto, specialmente ciò che è proibito. Scopre gli anarchici e si forma una personalità libertaria. Nelle conversazioni con i compagni di liceo, esprime opinioni non conformi all’oppressivo regime. Viene arrestato e fa alcuni mesi di galera. In questo periodo, viene in contatto diretto con la brutalità del regime. Viene rilasciato in seguito a circostanze favorevoli, ma adesso è un antifascista pronto a combattere, mentre il regime gode di un effimero consenso, quasi generale. Ciò in seguito al crimine, particolarmente odioso, dell’aggressione all’Abissinia, che però sembra coronato da successo.
Ad aprire gli occhi a tutti ci pensa la guerra. L’ Italia è una tigre di carta. Mussolini l’ha fatta così ed è egli stesso vittima del suo inganno. Crede di essere un generale romano, conquistatore di imperi. Crede che, facendo la voce grossa, gli altri avranno paura. Si crede il più astuto di tutti e crea un popolo di furbastri che ancora oggi credono nell’astuzia, nella raccomandazione, nel bluff. Così, ritenendosi astutissimo, capace di vincere la guerra senza combatterla, si fa complice di un altro criminale e dichiara guerra al mondo. Ma il mondo non si arrende, come lui aveva previsto. Il mondo non cede al bluff: vuole vedere se veramente Mussolini è quello che dice. Così, un Paese povero, impreparato, senza riserve, stremato da precedenti guerre, si trova a combattere contro Inghilterra, Stati Uniti e Russia contemporaneamente. Ma il crimine e la stupidità sono ancora più grandi. L’Italia non vuole la guerra e non vuole combattere. Mussolini, granitico condottiero, aveva dichiarato di avere otto milioni di baionette, invece non ha neppure otto milioni di calzini, tanto meno ha cannoni, aerei, camion. Mancano soprattutto i progressi scientifici, che gli altri hanno conseguito. Gli inglesi hanno il radar, mentre l’Italia non ha neppure comandi efficienti. Il Paese è stato spinto in guerra con un esercito più debole di quello del 1914. La stessa industria italiana non segue gli ordini del condottiero. La Fiat non produce la 1100 militare; si limita a montare ruote più grandi sulla stessa macchina venduta ai civili. Il risultato della situazione è una serie di disastri militari sempre più gravi che la propaganda fascista non riesce a nascondere, anche se tenta di spacciare le sconfitte per ritirate strategiche. Si arriva così al 25 luglio 1943, con l’esito segretamente desiderato da tutti.
Nei mesi precedenti, Silvano è stato richiamato alle armi. Passa alcuni mesi a Roma, viene promosso sergente e, col 25 luglio, rientra a Pistoia. Lo sfacelo è già cominciato. Silvano non rientrerà più nell’ esercito, il quale non si accorge che il sergente Fedi è diventato un antifascista combattente. La situazione è confusa: chi ha silurato Mussolini è un gruppo di gerarchi e di vecchi, non migliori dell’ex duce, ma soprattutto incapaci, inadeguati alla situazione. Possiedono l’arte grossolana della furbizia e pensano di poter ingannare tedeschi ed angloamericani. Naturalmente non ingannano nessuno, perché gli alleati sbriciolano il nostro territorio con i bombardamenti, mentre i tedeschi superano la frontiera del Brennero, come se non esistesse ed invadono il Paese, l’8 settembre. L’Italia è nel caos: non c’è cibo, se non al mercato nero; le scarpe sono fatte col cartone, ma soprattutto non ci sono notizie veritiere. Così nessuno sa quale sia la situazione reale. Il gruppo che ha sostituito Mussolini non fa quello che dovrebbe, ma fa quello che non dovrebbe: continua il bluff dell’ex duce.
A Pistoia, Silvano organizza un gruppo antifascista. Dalle riunioni, nella sua casa di via del Villino, di 5 o 6 persone, si passa ad altre, a cui partecipano V. Nardi (per il Psi) , G. Bianchi (per la Dc), T.Eschini (per gli Anarchici) ed altri. Si costituisce un comitato, in cui gli unici che contano sono Silvano ed il rappresentante del Pci, perché gli altri vogliono organizzarsi in vista del dopo, che appare inevitabile, ma non sono decisi a combattere. Qualcosa di paragonabile, avviene in tutta Italia. A Roma, in una riunione a cui partecipano De Gasperi e Bonomi, si costituisce il primo CLN. E’ una struttura astratta, perché, anche se formato da persone tanto più importanti di quelle di Pistoia, non sono molto conosciute ed hanno un seguito inesistente. Non si può trascurare il fatto che le comunicazioni, in quel periodo, quasi non esistono: la possibilità di decisioni, o anche di semplici scambi d’opinioni, non esiste. A Pistoia (ma certo avviene lo stesso in tutta Italia) non si sa quasi nulla di ciò che fanno Bonomi e De Gasperi a Roma, nè di quello che fanno Pertini e Parri a Milano. Ciascuno fa per conto proprio e poiché nel CLN pistoiese alcuni non vogliono fare, bensì vogliono aspettare che altri facciano, Silvano è quasi naturalmente e per temperamento portato a prendere la direzione delle azioni. La situazione fa di lui il capo, di fatto.
 Si arriva all’invasione tedesca ed al dissolvimento dell’esercito, che rappresenta bene l‘esito della pseudo-politica del re e di Badoglio. La dissoluzione dell’esercito è quella dello stato fascista. L’esercito avrebbe potuto combattere, perdere mezza Italia, ma dare il tempo di intervenire agli angloamericani e conservare l’altra metà del territorio. Però non combatte: i generali sono privi di ordini e non ne danno. Fuggono e spesso rifiutano di armare la popolazione, come avviene a Pistoia. I battaglioni, isolati e senza ordini, sono corpi senza cervello; non sanno cosa fare e perché. Così tutti scappano a casa. Io ne sono testimone oculare.
Si arriva all’invasione tedesca ed al dissolvimento dell’esercito, che rappresenta bene l‘esito della pseudo-politica del re e di Badoglio. La dissoluzione dell’esercito è quella dello stato fascista. L’esercito avrebbe potuto combattere, perdere mezza Italia, ma dare il tempo di intervenire agli angloamericani e conservare l’altra metà del territorio. Però non combatte: i generali sono privi di ordini e non ne danno. Fuggono e spesso rifiutano di armare la popolazione, come avviene a Pistoia. I battaglioni, isolati e senza ordini, sono corpi senza cervello; non sanno cosa fare e perché. Così tutti scappano a casa. Io ne sono testimone oculare.
Il 25 luglio ero a Cantagrillo, a casa della mia balia. Una voce circolava insistente: ”Mussolini è caduto!”. Ci volle un’intera giornata per trovare una radio ed ascoltare l’incredibile proclama: “La guerra continua”. Seguirono giorni di sbandamento totale, in cui vedemmo ricomparire alcuni soldati, tornati a casa in abiti civili dopo viaggi avventurosi. Mio padre venne a riprendermi ed a riportarmi a casa. Lungo la via Bonellina c’erano due file di soldati tedeschi, quasi tutti armati di mitra. Nel pomeriggio passò una colonna di enormi carri armati sul ponte dell’Arca. Non avevo mai visto carri così grandi. Mentre ancora i carri stavano passando, vedo due giovani correre sotto il ponte in via del Villino, armati con fucili da caccia. Adesso, senza Mussolini, senza Re, senza gerarchi pettoruti e abbigliati come pavoni, l’Italia combatte veramente. E’ il primo segno di resistenza armata: fucili da caccia contro carri armati “Tigre”. La scelta della Resistenza è, a Pistoia come in tutta Italia, una scelta individuale.
Il giorno stesso vado nel terreno che avevamo al di là del ponte, a guardare cos’è avvenuto della guarnigione. I soldati sono nascosti, in borghese, aspettando di poter fuggire. Le armi sono abbandonate. Rubo tutto, apparentemente non visto e porto le armi nella mia legnaia. Più tardi Silvano le porta via, sghignazzando sull’età del “ribelle”. Mio padre giudica la situazione pericolosissima e mi riporta a Cantagrillo. Tornerò a Pistoia in tempo per prendere il primo bombardamento, mentre i miei fratelli passano la notte disseppellendo morti e feriti. Ma Silvano ha ormai costituito un gruppo, una “formazione”, come si diceva allora e sa che siamo in pericolo. Ci separiamo: io e mia madre passiamo un anno tremendo, di vagabondaggio da un parente all’altro, da una famiglia amica ad un’altra. Poche notti o anche una sola notte e poi via. Facciamo decine di volte il giro da San Baronto a Cecina di Larciano, a Vinacciano, a villa Pagnini, a Cantagrillo e di nuovo a San Baronto o a San Pierino. Ripetiamo il giro con molte varianti, sempre a piedi, per strade interne. Mio padre e Franco fanno altri giri; i nonni sono da lontani parenti; Filiberto è nascosto presso la fidanzata. Silvano, chi sa dov’è. L’ho rivisto una sola volta a San Pierino e poi mai più. Solo a guerra finita sono venuto a sapere della sua intensa attività partigiana.
In questo ultimo anno disperato la situazione è terrificante. Niente cibo, niente acqua (sui Monti Albani non ci sono torrenti), niente trasporti, niente telefoni, niente notizie, se non a voce. Bombardamenti anche in aperta campagna (forse bombardieri danneggiati?). Trasmesse a voce le scarse notizie, ma si tratta sempre di deportazioni, rastrellamenti, fucilazioni. La strage del Padule. Siamo spesso a Cecina, dove dormiamo in una soffitta calda come un forno, invivibile. Particolarmente atroce è la mancanza di acqua. Mi alzo alle 5 e vado fino ad una roccia lontana, da cui esce acqua, goccia a goccia. Faccio una fila interminabile e raccolgo un fiasco che deve durare un giorno, per due persone. Sono colpito da scrofolosi: sono pieno di ulcere purulente. Questa malattia non esisteva più da oltre un secolo. Colpiva i bambini poveri e denutriti. Nel luglio ’44, siamo stremati; mia madre si sente insicura. Partiamo verso Montevettolini, giriamo a sinistra verso il monte della croce e scendiamo verso Vinacciano. E’ il 29 luglio 1944. Una contadina ci dice che c’è stato un combattimento e due partigiani sono stati uccisi. Mia madre è sconvolta; non andiamo più verso Villa Pagnini, ma verso Cantagrillo, a casa della mia balia che ci dice di andare via: troppo pericoloso. Senza cibo ne acqua, valichiamo il monte presso la Casa Al Vento e verso il tramonto siamo di nuovo a Cecina, nella soffitta. Non ricordo chi e quando ci hanno detto che Silvano era morto. Mia madre non vuole più fuggire, piange sempre…. A lungo le voci avevano dato gli americani a Cassino poi a Roma poi a Siena. In settembre improvvisamente i tedeschi se ne vanno in tutta fretta. Minano il “masso”, per interrompere la strada, ma strappo la miccia e la mina non scoppia. Rubo la dinamite che poi consegnerò a Vincenzo Nardi. Arriva la notizia che gli inglesi sono a pochi chilometri , a S. Rocco di Larciano. Increduli, andiamo a vedere; ci sono davvero. Sono sudafricani, della quinta armata. Due campi sono pieni di carri armati. Arriva una notizia: nel bosco di San Baronto, c’è una pattuglia tedesca. Per l’immaginaria pattuglia, partono 8 carri armati carichi di soldati, cioè 8 cannoni e 16 mitragliatrici. Riducono il bosco un deserto lunare, ma dei tedeschi neanche l’ombra. I sudafricani non passano il Monte Albano; a Pistoia arriva l’ottava armata americana che passa da San Baronto, ma la città è già liberata dai partigiani della “Silvano Fedi”.
Dopo la liberazione torniamo a San Pierino, sempre a piedi, perché la casa di Pistoia è danneggiata e gli altri edifici sono completamente distrutti. Incontro di nuovo mio padre, ma non mio fratello Franco: a 16 anni è andato con i partigiani ed era a Casalguidi durante il cannoneggiamento tedesco. Non sappiamo altro. Non viviamo più nel terrore della cattura e della morte, ma adesso il dolore e l’ angoscia ci divorano. Non riusciamo a sapere se Franco è vivo o morto: finalmente arriva la notizia che è ferito gravemente, forse, in un ospedale americano, presso Napoli. Mio padre, malato di cuore, va a Napoli in bicicletta attraverso un paese devastato e lo trova. Franco tornerà a Pistoia e andrà di nuovo a combattere contro i tedeschi, nella formazione di Pippo (Manrico Ducceschi) Un giorno, in un autunno in cui piove continuamente e siamo sempre infreddoliti, Franco mi viene incontro, sbucando dal nulla, in via di San Pierino. Non sorride, non parla. Quasi subito riparte per raggiungere Pippo, sulla Linea Gotica. In tutto il ’43-’44 avevano operato nel pistoiese, le formazioni di Silvano e Manrico. Silvano in città ed in pianura; Manrico in montagna, presso le Tre Potenze. Per noi ancora sfollati con gli americani è tornato un po’ di cibo: pane, fagioli, cioccolata, caffè, zucchero. Un sogno realizzato. Però non c’ è energia elettrica. Si fa luce con un po’ di petrolio in boccette da inchiostro e uno spago, per stoppino. Non ci si vede, ma in compenso il mattino seguente le narici sono nere di fuliggine. I soldati sono generosi, specialmente i neri, ma spesso si mangia ancora erba di campo, che provoca tremendi mal di pancia. Intanto, Franco è al fronte, Silvano è morto, la casa è semidistrutta e fino alla stazione ferroviaria c’è una distesa di macerie. Torniamo a Pistoia nell’estate ’45, ma prima io e mia madre andiamo al Bottegone, a casa di Marino Benesperi, che ospita Enzo Capecchi, ferito ad un ginocchio. Arriva il dottor Mariani e medica la ferita. Mi meraviglio che una cosa così grave possa guarire. Ma Enzo, Marino ed il Gargi, non sanno nulla della morte di Silvano, o dicono di non saper nulla. Andiamo via con l’impressione che non abbiano voluto parlare.
Da allora, per 70 anni, nessuno dice nulla, oppure dice fatti che non possono essere veri. Franco torna a casa, dopo il 25 aprile e l’insurrezione, deluso, amareggiato. Non chiede neppure il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente. Abbiamo perso Silvano; nessuno di noi si riprenderà completamente mai. La guerra è finita davvero. Ma la conseguenze rimangono. Oggi Ivan lllich scrive un libro perché quanto è avvenuto apra almeno gli occhi a chi legge. Il gran numero di documenti e di notizie raccolte dimostra la verità. Nulla è più facile di mentire, ma i documenti ristabiliscono il vero. Il libro è una miniera di documenti e fatti: apre gli occhi sul passato e fa capire il presente. Dal libro sappiamo che non è stata fatta giustizia. Chi aveva commesso delitti il più delle volte è riuscito a farla franca, o è finito deputato. Chi aveva rubato, nel ventennio, si è tenuto il maltolto, proprio come oggi. Sappiamo che nel dopoguerra le leggi sancirono la possibilità di ingannare l’intero paese, cioè commettere una truffa ai danno di tutti, senza punizione. Proprio come oggi. Uno dei fatti inediti che veniamo a sapere dal libro è che, nel pistoiese, alcune banche furono svaligiate, negli ultimi mesi della guerra ed alcuni divennero improvvisamente ricchi, ma nessuno chiese nulla. Silvano Fedi, ma anche Manrico Ducceschi, che non erano inseriti nel quadro politico, ma che certamente avrebbero fatto una grande carriera politica, morirono in circostanze oscure, ma nessuno chiese nulla. Nessuna indagine. Spero che il libro di lllich induca almeno qualcuno a chiedersi se è per questa società che i partigiani hanno combattuto e sono morti.
Bruno Fedi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 22 maggio 2016
DI STELLA CERVASIO
E’ un cielo meccanico, quello che avvolge la foresta. Invece che color nuvole è di un azzurro finto diluito fra volta e terra. Sembra impossibile che un cielo così cobalto sia uno sfondo amaro. La carne ha sfoderato nervi e sangue. Contorta nell’ultimo spasmo, la animale scava lenta la terra con un’unghia. Un urlo che graffia finisce in un sibilo, come un filo di vapore bollente dritto al cielo nero. Gli occhi, dopo tanta tristezza, mandano lampi. Il suo sangue si sparge, apre un poco la bocca e lo beve, perchè non si raggrumi. Mi chiamo Randi-noor. Non ho che pochi anni, ma abbastanza per mostrare più senno. Il posto dove sono nato è una scaglia di montagna; eravamo sospesi sul nulla, mia madre ed io, quando venni al mondo. Poi lei sparì. Un figlio è della madre, ma viene affidato al padre perchè gli insegni che cos’è il mondo. Ci sono padri che sono figli, il mio invece era un padre assoluto. Mi diceva sempre di calcolare ogni mossa dell’avversario, fermarsi a pensare, ponderare ogni mio movimento. Era inutile fuggire disordinatamente, diceva, bisognava invece nascondersi al momento giusto. Tra le fronde adatte, in una caverna gocciolante, bagnarsi fino alle ossa e aspettare l’eterno, finchè ogni eco della caccia non fosse spenta.
Io no. Non osavo dirlo al cospetto possente di lui, ma avrei preferito materializzarmi come dal nulla davanti al mio persecutore, inorridire alla vista delle sue armi affilate. E poi saggiare il potere della mia pelle scura e profumata di resina, scossa dalla febbre; fissarlo con occhi lucidi, una zampa puntata nel terreno duro, i nervi che ondeggino con un fremito lieve, pronti a scattare. Questo volevo, ma il coraggio della disubbidienza nel pensiero, mi mancava. Mi insegnavano a essere vittima nel migliore dei modi, ma io ero cattivo alunno. Loro dicevano di nascondersi, io volevo mostrarmi. Loro di controllare, io amavo perdermi. Mio padre leggeva in me ogni intuizione. La preveniva con uno sguardo indagatore. Nessuna offesa, in questo «possesso» totale. Il conflitto di generazione è una sovrapposizione dei tempi moderni. Io non ne ho sofferto.
Una volta l’ho visto, il cacciatore. Era svelto, pareva potesse lottare all’infinito. Era maledettamente bello, di una bellezza struggente. Si muoveva sulle gambe con la sicurezza di uno di noi, nel canneto, tra gli sterpi, un guizzo e mi stava davanti, ma non poteva vedermi. Non sapeva perchè, ma mi cercava, mi veniva incontro, non osava sottrarsi. Lo chiamava il sangue, l’attraeva il mio odore. Un brivido mi scosse fin nell’anima. Lui aveva l’arco, gli avevano dato un’arma, quel filo che si tendeva forte, cui non potevo opporre che la fibra dei miei nervi. A che cosa sarebbe servito sedurlo, se lui era la natura in quel momento, se la sua passione aveva un segno diverso dal mio, o uguale, ma valeva la mia vita. Morire, in nome di che cosa.
L’ho visto, il cacciatore, quella volta, ma non ho tremato.
Non trema chi conosce l’odore del sangue. Controlla l’andatura, scuote il manto nella macchia, solo quando ogni fuscello tace, non mosso dal minimo soffio di vento. L’ora migliore è la prima ombra del pomeriggio, quando la foresta si concede una tregua di rumori e odori, si prepara alla festa di profumi della sera: cortecce che stillano oli, erbe pungenti come sale su una ferita, corolle dai petali spessi come broccato da dove il sole scivola via lasciando solo qualche traccia tenue. E mille fruscii nei rami: piccoli mammiferi, come dicono anche i libri, minuscole zampe frenetiche, occhi grandi come sfere rossigne che scintillano sinistre nella notte.
 Ero la vittima. Ma potevo diventare il carnefice, secondo le leggi degli uomini, che possono rovesciare le nostre. E mi raccontavano una storia, nell’infanzia, che doveva essere una parabola. Mi apparve. Era uno di noi. Restai sul limitare della caverna, di sotto un ramo di foglie larghe lo spiai. Il sangue mi si gelò nelle vene. Anche adesso che la forza mi sfugge come l’acqua da una pozza sulla riva del mare, il sangue si ghiaccia alla memoria. Lui poteva. In quel momento, se solo avesse potuto vedermi, avrebbe avuto in mano la mia vita. Fu come quando facevo i miei addestramenti, nel posto più nascosto del bosco, protetta dal padre. «Se arriva uno straniero – mi dicevano sempre – corri più che puoi». Ognuno doveva pensare a sè: questa era la prima legge che imparai. Seppi che anche gli uomini ricevono presto una simile prescrizione, ma non lo sanno. Lo scoprono tardi, con un’improvvisa sofferenza che brucia come il tradimento. Quella volta che vidi il cacciatore immutabile, scappai. Colpito dal fragore dei rami spezzati, m’inseguì, ma sbagliò direzione. Andava dietro ai fantasmi della sua mente confusa. Chi può dire se sono i nervi dell’animale a cedere o lui a fortificarsi fino a stringergli il cappio intorno al collo, ad arrivare al suo cospetto. Lui ha osato tanto. Ma prima è stato costretto ad adorarmi. Si è addentrato tra le ombre degli alberi, ha superato la linea del sole ed è approdato al buio, oltre i confini del mio regno. Ben nascosta non sapevo far altro che assaporare la vittoria. E’ qui. L’ha attirato la corporeità, ciò che è materiale, e qualcosa di spirituale insieme: il senso del possesso. Era accaduto; non sentivo più il pericolo, i freni che m’avrebbero impedito di restare nascosta. Sentii la sua voce. Era un flauto. Vidi le sue mani. Erano sottili. I capelli neri gli ricadevano sulla fronte, a riccioli, come corde bagnate. Chi avrebbe raccolto quel regalo? Ci insegnano da giovani il nemico. Ma percepii chiaramente che quello non lo era. O meglio, era lui, ma se la sensazione di panico che deve invadere chi scorge il suo inseguitore è simile a un senso di conquista, di conseguimento di uno scopo da sempre cercato, allora quella che sentii era la cosa giusta, e lui era davvero il nemico.
Ero la vittima. Ma potevo diventare il carnefice, secondo le leggi degli uomini, che possono rovesciare le nostre. E mi raccontavano una storia, nell’infanzia, che doveva essere una parabola. Mi apparve. Era uno di noi. Restai sul limitare della caverna, di sotto un ramo di foglie larghe lo spiai. Il sangue mi si gelò nelle vene. Anche adesso che la forza mi sfugge come l’acqua da una pozza sulla riva del mare, il sangue si ghiaccia alla memoria. Lui poteva. In quel momento, se solo avesse potuto vedermi, avrebbe avuto in mano la mia vita. Fu come quando facevo i miei addestramenti, nel posto più nascosto del bosco, protetta dal padre. «Se arriva uno straniero – mi dicevano sempre – corri più che puoi». Ognuno doveva pensare a sè: questa era la prima legge che imparai. Seppi che anche gli uomini ricevono presto una simile prescrizione, ma non lo sanno. Lo scoprono tardi, con un’improvvisa sofferenza che brucia come il tradimento. Quella volta che vidi il cacciatore immutabile, scappai. Colpito dal fragore dei rami spezzati, m’inseguì, ma sbagliò direzione. Andava dietro ai fantasmi della sua mente confusa. Chi può dire se sono i nervi dell’animale a cedere o lui a fortificarsi fino a stringergli il cappio intorno al collo, ad arrivare al suo cospetto. Lui ha osato tanto. Ma prima è stato costretto ad adorarmi. Si è addentrato tra le ombre degli alberi, ha superato la linea del sole ed è approdato al buio, oltre i confini del mio regno. Ben nascosta non sapevo far altro che assaporare la vittoria. E’ qui. L’ha attirato la corporeità, ciò che è materiale, e qualcosa di spirituale insieme: il senso del possesso. Era accaduto; non sentivo più il pericolo, i freni che m’avrebbero impedito di restare nascosta. Sentii la sua voce. Era un flauto. Vidi le sue mani. Erano sottili. I capelli neri gli ricadevano sulla fronte, a riccioli, come corde bagnate. Chi avrebbe raccolto quel regalo? Ci insegnano da giovani il nemico. Ma percepii chiaramente che quello non lo era. O meglio, era lui, ma se la sensazione di panico che deve invadere chi scorge il suo inseguitore è simile a un senso di conquista, di conseguimento di uno scopo da sempre cercato, allora quella che sentii era la cosa giusta, e lui era davvero il nemico.
Mi tradì il mio stesso universo. Le fronde cedettero. O forse l’emozione mi lasciò a nudo come un essere primordiale. Lo ero. Dimentico degli insegnamenti e degli istinti. Gli andai addirittura incontro. Gli occhi con i quali mi osservava erano di trepidazione e di paura, di passione e di timidezza. Era alle prime armi, come me. «Sei così bello – disse – insegnami a farti del male». Sapeva già tutto. Non avrei dovuto dirgli niente. Ma gli attimi in cui rimase a guardare sembrarono non finire. Nervi e sangue, di questo siamo fatti. Se gli uni si fermano e l’altro smette di pulsare, la vita è conclusa.
 Fu lenta, la mia fine. Ma non arrivò da lontano. Lui e io eravamo in comunione perfetta. Il vento si era placato. Uno scarabeo volante trovò pace su un ramo e distrasse il mio sguardo con il crepitio delle ali. Fu in quel momento che un altro umano si avvicinò. Rumore di foglie, ma non sentii. «Colpisci». La ragione aveva ceduto il posto alla fantasia. Da spirito, fantasma di quello che aveva da sempre desiderato e mai aveva saputo conquistare senza la forza, solo con l’amore, diventai quello che ero. Nervi e sangue. La punta di una freccia a squarciarli. Tanta fatica per insegnarmi, allenarmi, tanto ingegno per formare quel grande essere fatto di invisibili circuiti che riproducevano perfettamente, tanti secoli dopo, l’animale delle foreste di cui ormai non restava che un CD depositato alla grande Babele, la banca dati di New York, la più grande del mondo. Ero figlio di un cyborg, ma appartenevo a una generazione successiva, robot pensanti, ma non solo. Grazie ai microchip possedevo una memoria mista, umano-animale. E adesso una freccia. No, una lancia. M’attraversa dal fianco al costato. Neppure l’onore di una rapida morte. Lui, non un semidio, ma un eroe del mio tempo, che loro trascorrono a ritrovare il senso della vita passata. I boschi, la caccia. E di tutto, l’anacronistica offesa, l’affronto più grande: dalla cintura da cui pendevano pugnale e arco, spuntò un cellulare. Che mentre soffiavo via la vita, squillò.
Fu lenta, la mia fine. Ma non arrivò da lontano. Lui e io eravamo in comunione perfetta. Il vento si era placato. Uno scarabeo volante trovò pace su un ramo e distrasse il mio sguardo con il crepitio delle ali. Fu in quel momento che un altro umano si avvicinò. Rumore di foglie, ma non sentii. «Colpisci». La ragione aveva ceduto il posto alla fantasia. Da spirito, fantasma di quello che aveva da sempre desiderato e mai aveva saputo conquistare senza la forza, solo con l’amore, diventai quello che ero. Nervi e sangue. La punta di una freccia a squarciarli. Tanta fatica per insegnarmi, allenarmi, tanto ingegno per formare quel grande essere fatto di invisibili circuiti che riproducevano perfettamente, tanti secoli dopo, l’animale delle foreste di cui ormai non restava che un CD depositato alla grande Babele, la banca dati di New York, la più grande del mondo. Ero figlio di un cyborg, ma appartenevo a una generazione successiva, robot pensanti, ma non solo. Grazie ai microchip possedevo una memoria mista, umano-animale. E adesso una freccia. No, una lancia. M’attraversa dal fianco al costato. Neppure l’onore di una rapida morte. Lui, non un semidio, ma un eroe del mio tempo, che loro trascorrono a ritrovare il senso della vita passata. I boschi, la caccia. E di tutto, l’anacronistica offesa, l’affronto più grande: dalla cintura da cui pendevano pugnale e arco, spuntò un cellulare. Che mentre soffiavo via la vita, squillò.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Racconto di Domenica 15 maggio 2016
di Stella Cervasio
“La vivisezione è un male necessario”. Quel papà grande e grosso, che di professione faceva il medico, spiegava così alla figlia non ancora in quella che lui riteneva essere “l’età della ragione”, la parola che a lei pareva tremenda: vivisezione. Sentire che ti tagliano a pezzi. Che ti costringono a ingoiare o a ricevere nelle vene roba che brucia, che strappa, che distrugge. Aveva consultato libri aprendo la biblioteca con gli sportelli di vetro, aveva esplorato quell’armadietto di metallo dove il padre non permetteva a nessuno di prendere niente (lui nascondeva lì i libri di arte e le riviste che leggeva quando non aveva visite nel suo studio, rari momenti). Aveva visto. E aveva letto, un racconto – cioè quindi un brano d’invenzione o forse verità? – su Febo, il cane dello scrittore Curzio Malaparte che con lei divideva l’amore per l’isola di Capri. La storia triste di un cane che si era perso, che il “padrone” (allora si diceva così) non era riuscito a trovare per lunghi giorni, visto che l’aveva abituato a correre libero in giro, tanto tornava sempre. Trovare, l’aveva ritrovato. Immobilizzato, in una teca di vetro, tubi dappertutto, solo gli occhi rimasti “liberi”, ma colmati da un dolore liquido, color del sangue. Con quegli occhi parlava ormai. Gli avevano tagliato le corde vocali, perché il rumore dell’abbaio nei laboratori disturba il sonno della ragione dei vivisettori. Solo con quegli occhi. Ma intorno a lei, nel chiocciare della televisione, sui giornali a grandi colonne, dicevano che non fosse. Dicevano che dolore non è. Dicono ancora che dolore non è. E dicono anche che comunque è peggio il dolore umano, usando una scala che lei, fin da quando aveva 10 anni, rifiutava di usare. Male necessario. Ma quale male è necessario? Il fatto stesso che sia un male, può renderlo neutralizzabile, e questo le suggeriva poi la logica studiata all’università, all’età della ragione. Ma allora neanche quello che studiamo può aiutarci a scampare al dolore? Anche quei signori lì con i camici bianchi hanno studiato. Ma dalle loro mani non si scappa.
Quando Malaparte arrivò nel laboratorio il medico ebbe un moto di pietà e addormentò il cane con una siringa, l’ennesima. Gli altri animali del laboratorio del racconto non si vedono, di loro non si legge se non qualche cenno. Immaginatelo, quello stanzone d’ospedale: gli altri continuarono a soffrire, e invece il cane dello scrittore, per riguardo allo scrittore famoso, fu addormentato. Rispettare il cane per il padrone.
Lei immaginava sempre il passaggio lento di quel fluido bianco, bianco come la morte, arrivare dall’ago nella vena di Febo. Un velo calò sui suoi occhi che parlavano, e neanche quelli parlarono più. Febo morì. Perché anche da grande, lei non usava mai le espressioni “dolcificate” che spesso usavano gli altri che si professavano amici degli animali. “Pelosi” per dire i randagi trovati mezzi morti per la strada, “addormentiamolo” per l’eutanasia. Non dorme, lo stiamo uccidendo. Lo so, diceva, è per evitargli una fine peggiore. Però lo stiamo uccidendo, se dobbiamo dire le cose come sono. Chiamare per nome le cose come sono. Ora i ricercatori non dicono neanche più vivisezione. Troppo brutta la parola. Troppo evocativa di scene che preferiamo vedere solo al supermercato, nelle vaschette giallo oro, con la pellicola trasparente, senza sangue, perché il sangue evoca dolore. E il dolore è cosa brutta. E noi dobbiamo avere nella mente solo una grande bellezza universale, dove chi soffre è fuori dal nostro orizzonte. Sia esso un animale che bela sotto la scure, sia esso un uomo che viene da lontano, coperto di piaghe e di miseria. Via la bruttezza dai nostri occhi. Occhi che non devono soffrire.
 Lei aveva quindici anni quando arrivò quel cucciolo: era un incrocio di pastore tedesco, almeno così sembrava, ma la metà del suo corpo era strana, estranea, sembrava di un altro pianeta. Il veterinario che era approdato da poco dal nord nel suo paese, e che a lei sembrava una punta avanzata rispetto all’arretratezza in fatto di animali, che c’era lì da lei, lo guardò allegro e disse: “Ha un occhio lupino”. Si fece spiegare che cosa significava. Uno degli occhi era simile a quello di un lupo. E il pelo non era rossiccio e beige come di solito lo hanno i pastori tedeschi. Era grigio. Come quello dei lupi. Le venne naturale chiamarlo Febo. Lei il Febo dissezionato di Malaparte se lo era immaginato proprio così: una creatura venuta da un altro mondo, da un mondo libero e felice, sulla quale gli uomini si erano lanciati con i loro bisturi, aghi, spade e lance. “Il dolore di un ago, non deve superare il dolore procurato da un ago”, dentro di sè leggeva e rileggeva, quarant’anni dopo, quella riga offensiva, dolorosa molto più della punta di un ago, contenuta nelle assurde normative a “protezione” dei diritti degli animali. Che si può sperare? Le normative le fanno gli uomini, si diceva. Ma sapeva che sarebbe stato sbagliato smettere di credere nelle regole. Nelle leggi. “Il solo riferimento certo che abbiamo nella nostra vita confusa”, si consolava. E quel piccolo Febo, ritornato da quell’altro mondo che se l’era ripreso al tempo di Malaparte, quando non c’erano che cani e padroni, ora era una nuova prova per lei. Non ci sono più cani e padroni, noi siamo la loro guida. O almeno vorremmo esserlo.
Lei aveva quindici anni quando arrivò quel cucciolo: era un incrocio di pastore tedesco, almeno così sembrava, ma la metà del suo corpo era strana, estranea, sembrava di un altro pianeta. Il veterinario che era approdato da poco dal nord nel suo paese, e che a lei sembrava una punta avanzata rispetto all’arretratezza in fatto di animali, che c’era lì da lei, lo guardò allegro e disse: “Ha un occhio lupino”. Si fece spiegare che cosa significava. Uno degli occhi era simile a quello di un lupo. E il pelo non era rossiccio e beige come di solito lo hanno i pastori tedeschi. Era grigio. Come quello dei lupi. Le venne naturale chiamarlo Febo. Lei il Febo dissezionato di Malaparte se lo era immaginato proprio così: una creatura venuta da un altro mondo, da un mondo libero e felice, sulla quale gli uomini si erano lanciati con i loro bisturi, aghi, spade e lance. “Il dolore di un ago, non deve superare il dolore procurato da un ago”, dentro di sè leggeva e rileggeva, quarant’anni dopo, quella riga offensiva, dolorosa molto più della punta di un ago, contenuta nelle assurde normative a “protezione” dei diritti degli animali. Che si può sperare? Le normative le fanno gli uomini, si diceva. Ma sapeva che sarebbe stato sbagliato smettere di credere nelle regole. Nelle leggi. “Il solo riferimento certo che abbiamo nella nostra vita confusa”, si consolava. E quel piccolo Febo, ritornato da quell’altro mondo che se l’era ripreso al tempo di Malaparte, quando non c’erano che cani e padroni, ora era una nuova prova per lei. Non ci sono più cani e padroni, noi siamo la loro guida. O almeno vorremmo esserlo.
Vediamo. Crebbe quel Febo. Quando arrivò era ammalato, lei lo accudì come un figlio. Non poteva portarselo in casa, che era piena di gatti. Nel frattempo quel padre rigoroso ma pietoso, era sparito anche lui dalla terra, andato chissà dove, dove tutti vanno quando muoiono. L’aveva lasciata con mille perché. E Febo era la sua risposta. La sola, l’unica risposta che poteva ancora avere. Sin qui il ricordo è chiaro. Poi dopo si fa sfumato. Lei era grande, ormai, e alla sua età o si trova un marito o si va a lavorare. E lei scelse di andare a lavorare, di cercarsi il suo posto nella società. Febo invece, per decreto degli uomini, non aveva posto in quell’impresa. Doveva spostarsi da quel giardino dove Febo aveva la sua bella casa, dall’amaca dove lo aveva cullato tante volte, da piccolo e poi da grande. Le fotografie che li ritraevano insieme dicevano felicità. Ma la sua terra non ammetteva felicità. E così lei dovette andarsene lontano, lasciando Febo e tutto il resto a quel che restava della sua famiglia. Beninteso, persone fidate. Ma che il tempo non l’avevano per dedicarsi come lei. Febo girava per il giardino cercando lei, ricordando i momenti belli che si vedevano nelle foto. Lei le aveva messe tutte in fila, sul comodino della sua stanza di collegio, dove alloggiava. Un posto che con quel giardino non aveva più niente a che vedere. State con Febo. Andateci sempre e state un po’ con lui. Questo era l’ultimo ricordo che aveva. Ma Febo girava ramingo e nervoso, e piangeva, si lamentava, abbaiava, turbando il sonno della ragione di altri uomini ingiusti. Di gente che non può capire. Lei cercò di dimenticare, e questo fu il male peggiore. Perché quarant’anni dopo le veniva in mente una frase soltanto, di sua madre, che tanta delicatezza nei suoi confronti non l’aveva mai avuta. “L’abbiamo trovato morto. Pensiamo che l’abbiano avvelenato”. Per quanto lei si sforzi, non ricorda se non quel singhiozzo strozzato che anche ora le si presenta nella gola, la disperazione di non aver potuto e di non poter, ormai, fare più niente. “Gli avevi dato quel nome, che cosa potevi aspettarti”. La madre dovrebbe essere pietosa con il dolore dei figli, e invece accusava. Anche lei amava gli animali e accusava gli umani. E questa volta, la ragazza era “umana”, stava dall’altra parte, da quella delle responsabilità declinate. Per ragioni di forza maggiore o minore, chi può dirlo. Ma responsabilità declinata. Il cane aveva abbaiato e l’abbaio gli era stato fatale, qualcuno l’aveva zittito con una polpetta di veleno. Avrebbe voluto dire aspettate. Non correte al finale. Fermatevi. Febo me lo prendo e me lo porto con me, dovunque io vada. Posso farlo. Ho i soldi per pagare qualcuno che me lo guardi quando non ci sono, ora ho i soldi. Aspettate. Ma niente. Le scene come fotogrammi impazziti si formano nella sua mente, Febo azzanna il boccone, crolla, un lamento ed è morto.
 E’ vero, gli avevo dato quel nome perché volevo ricordare a tutti noi che il sacrificio non esiste, che il dolore non è mai necessario. Volevo ricordare che esiste soltanto il male inferto dagli uomini a chi può solo piegare la testa sotto la sua scure. Per questo Febo è ancora con me, che sono responsabile della sua fine e della sua resurrezione, un sole che splende in una giornata grigia che non finisce mai.
E’ vero, gli avevo dato quel nome perché volevo ricordare a tutti noi che il sacrificio non esiste, che il dolore non è mai necessario. Volevo ricordare che esiste soltanto il male inferto dagli uomini a chi può solo piegare la testa sotto la sua scure. Per questo Febo è ancora con me, che sono responsabile della sua fine e della sua resurrezione, un sole che splende in una giornata grigia che non finisce mai.
Stella Cervasio
————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Il Racconto di Domenica 8 maggio 2016
IL TORO PIANGE SANGUE
di Stella Cervasio
Il toro piange sangue. E il re ride. Il toro si dibatte al suolo. E il re applaude. Il toro sta morendo, sente il cuore strappato dal petto. E il re grida olè. Qualcuno strappa gli stiletti dalla groppa del toro perché senta dolore ancora ancora e ancora. Ma la sofferenza del toro è finita. E il re batte ancora le mani. Il suo gaudio è vano come un tramonto cui nessuno assiste.
Voi che accoltellate. Voi che appendete a ganci appuntiti. Voi che scaricate corrente elettrica alle tempie. Voi che castrate senza anestesia. Voi che applicate elettrodi e iniettate veleni. Voi che aprite crani che si dibattono. Voi che legate arti, neutralizzate corde vocali, crucifiggete corpi e ne impalate altri, dopo averli impallinati, bastonati, ridotti a gelatina rossa.
Voi siete tutti uguali. Il vostro dolore è lontano, cieco e sordo. La vostra sofferenza è un’idea che non sfiora, non lacera, non colpisce. Una lancia ha attraversato il vostro cervello, forse, annullando la vostra area empatica. Voi non capite chi soffre. Persona o non persona. Voi vi chiamate macellai o vivisettori. Vi chiamate allevatori o scienziati. Vi chiamate cacciatori. Vi chiamate toreri o anche solo spettatori. La spada è anche nelle vostre mani. Voi siete brillanti e disinvolti. Capaci di ridere e di battere le mani. Invocate scuse come l’alimentazione, la tradizione, la ricerca che guarisce il cancro, che salva i bambini, che toglie dalla sedia a rotelle. Il vostro potere è infinito. Se vedo voi, mi sento trapassare lo stomaco. Il sangue mi scorre dalla bocca. Mi si aprono la testa e le vene. Penzolo da un gancio. Le lacrime mi scorrono sul viso ma nessuno le vede. Voi siete tutti uguali. Tutti uguali a un re che non ha regno, non l’ha mai avuto e mai lo avrà.
Il Racconto di Domenica 1 maggio 2016
PORCO MONDO
di Paolo Spiga
Fa un caldo bestiale. Sto sudando come un porco. Non c’è spazio. Siamo uno addosso all’altro e non passa un filo d’aria. Mi gira la testa. Mi viene da vomitare, ma poi se lo faccio succede un casino. Quando non reggo più però vomito. Le budella dentro mi girano come una trottola, ho dei gorgoglii, adesso più forti, di sicuro li sentono, ma anche io adesso comincio a sentire i loro, è un suono strano che sale, sale, un’orchestra, una lurida orchestra. Mi chiamo Gino.
Il viaggio è cominciato stanotte, ci hanno presi mentre dormivamo, quel poco che ci fanno dormire, c’era la luna piena che usciti dalla stalla sembrava di andare subito al pascolo. Le stelle erano sopra di noi, forse è la volta buona che ci portano a fare una bella gita. Di quelle comode, tanti bei camioncini, quattro chiacchiere lungo il percorso, guardarci il paesaggio intorno sdraiati in piedi seduti capovolti a grattarci annusarci baciarci strofinarci naso naso raccontarci barzellette. O storielle. Come quella che ci dicevano da piccoli, di quel politico che parlando al telefono con un suo amico faceva “chillo è nu’ puorco” e noi tutti giù a ridere. Certo paragonarci a quei veri porci che pensano solo a ingozzarsi dal mattino alla sera non è il massimo per noi che ci sudiamo il pasto, ci guadagniamo fino all’ultima mela, mentre loro quello che divorano se lo prendono senza pagare niente, entrano razzolano via tutto fanno piazza pulita di quello che trovano a tiro. Noi quando abbiamo mangiato il giusto basta, poi ci rotoliamo giù per terra, giochiamo nel fango ci laviamo ci risporchiamo daccapo e così passiamo il tempo.
Ci hanno fatto camminare per un pezzo, noi ancora tutti assonnati, però curiosi di sapere dove si andava, forse a spasso dove c’è quel lago blu forte e tanto verde e alberi che è un vero paradiso, il viaggio premio che nelle favole capita quando stiamo buoni per una intera settimana. Andavo pazzo per le margherite gialle, ne ingoiavo una tale quantità che una volta ebbi la diarrea per tre giorni ma anche le primule mi stuzzicano l’appetito per quelle foglie belle e rugose, ti saziavi solo a guardarle, i papaveri meno perchè sono belli ma poi non sanno di niente anche se dice che fanno bene ti fanno riposare meglio e io sono sempre stanno un dormiglione che sogna un sacco e quando la sera va a dormire è come se andasse al cinema, mi sveglio durante la notte e ricordo parecchio, soprattutto quando volo e ne ho fatti tanti di giri per il cielo, ma anche i nonni raccontavano che ai loro tempi volavano un sacco, quando c’erano tanti porcellini con le ali e allora tutti ne parlavano.
Ci hanno fatto salire su dei grandi camion, erano tre, presi di peso tirati via un male cane che adesso mi sento tutto un dolore come se mi fosse passato sopra un tir, quelle bestie, senza un minimo di gentilezza senza un grammo di rispetto e pensare che noi non gli abbiamo fatto niente a quei porci per meritarci una roba simile. E giù che ci maledicevano poi calci sputi manganellate che neanche ai tempi di Mussolini. Forse a quei raduni di giovani, quando si mettono insieme per manifestare per la pace, fanno le marce e quelli gli vanno addosso con i bastoni le maschere di ferro gli gettano acqua fino a farli annegare come succede anche a noi quando ci lavano e vanno giù pesante che ci accecano con quell’acqua così forte da farti svenire, un fiume una tempesta un uragano uno tsunami. Noi non abbiamo mai fatto così con loro non li abbiamo bastonati che dio la manda, non so perchè si comportano così.
Non c’entriamo, nel camion, ma ne buttano dentro un altro e poi un altro ancora e ancora, non capiscono che non c’è più spazio che poi uno schizza via fuori perchè lo spazio è finito e dove va a sbattere? Ci spingono fino a farci diventare una sola cosa, ci vogliono spappolare forse, fare un unico grande ammasso dove schizzano via le ossa gli occhi i nasi le orecchie, un polpettone un hamburger gigante che viaggia va al casello paga il pedaggio prende l’autostrada e arriva dove ci portano che ancora non l’abbiamo capito, perchè se è una gita si dovevano comportare meglio, non me la raccontano giusta.
Nessuno di noi ha voglia di parlare siamo mezzi addormentati e mezzi morti per le botte, non c’è il modo neanche di buttarsi a terra e riprendere un po’ le forze, non ce la fai, devi stare in piedi e ti reggi su quello che ti sta a fianco, siamo una catena che uno tiene su l’altro e ancora l’altro, se il camion era aperto il primo cadeva e tutti gli altri giù per terra. Tutti questi sobbalzi peggiorano le cose.
 Sto attaccato da un lato a Giacomo, sta peggio di me, ha anche un mese in più e si vede, è quasi pallido, molto meno roseo del solito e negli occhi gli vedo una grande tristezza. E anche una lacrima. Forse adesso comincia a piangere.
Sto attaccato da un lato a Giacomo, sta peggio di me, ha anche un mese in più e si vede, è quasi pallido, molto meno roseo del solito e negli occhi gli vedo una grande tristezza. E anche una lacrima. Forse adesso comincia a piangere.
“Ti senti male, Giacomo?”.
“Uno schifo, non si vede? Le gambe non mi tengono, una debolezza mai sentita, un vuoto, avrò la pressione bassissima, mi sento girare tutto intorno eppure stiamo uno contro l’altro”.
“Dai, stringi i denti che prima o poi si fermano e possiamo sgranchirci un po’ e prendere un caffè molto zuccherato che ci tira su”.
“Io la vedo nera. Penso che non ci stanno portando in gita ma da qualche parte che è meglio forse non ci pensiamo. Può darsi sia arrivato il momento, questi porci che ci hanno nutriti per un bel po’ adesso ci giocano un bello scherzo. Me ne hanno raccontate, i miei, da far accapponare la pelle…”.
“A cosa ti riferisci Giacomo?”.
“A quelle storie che ho sentito e che anche i tuoi ti avranno raccontato, non per spaventarti ma per prepararti a qualcosa che prima o poi può succedere. Fino a quando siamo giovani pensiamo che possiamo combinarle di tutti i colori, che non ci capita niente, mangiamo dormiamo e non pensiamo a cose brutte. Ma poi… Mio padre mi ha raccontato alcune storie lontane laggiù in America dove tanti di noi vivono in case grandissime, li chiamano grattacieli per i padroni e per noi però là non sono alti ma larghi, perchè l’ascensore non ci è permesso ma solo a loro anche per vedere tutto dal cielo e dominare…”.
“Ho sentito anche io qualcosa del genere, una cosa orribile ma penso sia solo una brutta storia che mettono in giro per spaventarci. Quelle cose le facevano in Germania con i forni o le camere a gas per gli ebrei ne hanno arrostiti migliaia hanno bruciato intere famiglie una strage che ancora se ne parla…”.
“A me hanno detto di questi posti in America dove lavorano come in un esercito, sono tantissimi, in una fabbrica ho sentito di 15 mila persone, pare in uno stadio dove si va per vedere giocare a pallone. Una fabbrica come una caserma, mi raccontava papà, una base con i missili tante guardie a controllare tutto, chi entrava chi usciva chi caso mai veniva per curiosare e non gli facevano vedere niente. Sembra di stare in guerra, mi diceva, grida urla rumori assordanti vapori odori fortissimi e poi sangue, tanto sangue come dopo un attentato che sono tutti a pezzi per terra…”.
“Forse esageri, non è mica il Vietnam o l’Iraq…”.
Risponde Giacomo, dopo una pausa di riflessione: “E’ peggio del Vietnam o dell’Iraq perchè di quelle stragi loro ne hanno parlato, si sono sbranati fra loro si sono mangiati vivi hanno fatto una carneficina e molte altre continuano nel mondo ma almeno poi tanti ancora protestano e accusano chi ammazza. Della nostra storia non parla nessuno, a loro non gliene frega niente tutto normale tutto in regola tutto ok, quei posti sono santi e benedetti perchè a loro gli porta soldi e fanno mangiare tanta gente. Quando verrà quel giorno che anche noi saremo capaci di fare così? Di mettere su una gigantesca azienda allevare tanti uomini in batteria ingozzarli e poi sgozzarli quando è venuto il momento?”.
Anche Gino ci pensa un po’ su prima di dire la sua: “Io non me la sentirei, non sono fatto per queste cose. Ma mi domando cosa li può spingere a distruggersi fra loro a farsi a pezzi per comandare per essere uno più importante dell’altro e scannarsi come in una foresta. Non mi stupisco che ci trattano da bestie, ci fanno ingrassare per poi mangiarci meglio e figurati se mai se ne fottono che noi soffriamo come bestie, che non vogliamo fare quella fine, tanto non abbiamo i caschi blu dell’Onu che vengono in nostro soccorso né un tribunale dell’Aja per accusare quelli che ci massacrano”.
Giacomo: “Ma lo sai quanto ci guadagnano su di noi? Una fortuna. In tutto il mondo quelli che si occupano di noi fanno soldi a palate. E poi noi gli siamo utili per tante altre cose, a partire dagli esperimenti, che secondo loro sono essenziali per la loro salute. E ti ricordi quando avevano pensato pure di trapiantare il cuore di uno di noi a uno di loro? Sei un vero maiale, gli potevano poi dire uscendo dalla sala operatoria!”.
Gino: “Mi chiedo una cosa. Perchè essere così crudeli che nessuno glielo ordina, neanche il diavolo. Prenderci tirarci afferrarci per i piedi rivoltarci sulla schiena e via botte e calci e spinte e pugni, sembra un ring e noi non vogliamo, tiriamo indietro ci viene da piangere e poi si avvicina il killer con un punteruolo un ferro lungo come quelli per i vampiri e giù nella gola nel torace fino al cuore che così il sangue viene fuori come una fontana e poi ci prendono per i piedi ci appendono ci infilzano ci fanno scorrere l’anima…”.
Giacomo: “Sì, dice che così viene bene poi possono fare i loro comodi nel migliore dei modi, una volta addirittura facevano il cioccolato più buono a Pasqua e loro se lo bevevano il nostro sangue come tanti dracula. Ma a noi è venuto mai in testa di farci il dolce con loro, di infilarci dentro i biscotti nel loro sangue per gustarcelo meglio? Siamo dei fessi noi, li ringraziamo quando si avvicinano per darci da mangiare mentre dovremmo inghiottircela quella mano maledetta…”.
Gino: “Ti dico un episodio che mi ha raccontato Giorgio, una ragazza che aveva un padre che lavorava in campagna. E faceva quel lavoro con noi. Dice che li rispettava molto i suoi porcellini, ci parlava anche, come stai ti è piaciuta la pappa hai dormito bene come ti senti hai caldo. Li lavava gli dava la buona notte ci mancava solo la favola prima di prendere sonno. Dice che quando entrava per prenderne uno, che era venuto il suo giorno, il nostro collega lo capiva subito, erano in tanti ma lui aveva capito che stava andando da lui. Indietreggiava un po’ quasi si scostava si guardava intorno e quando il papà si avvicinava per prenderlo dice che gli occhi si inumidivano e cominciava a lamentarsi a dire qualcosa. Era terrorizzato non voleva uscire faceva resistenza, aveva capito…”.
 Giacomo: “Io te ne dico un’altra, che mi ha raccontato mia madre. Parla di uno studente che cominciava a fare esperienza e un giorno capita quasi per caso in una stanza della sua università. Ci trova dentro quattro persone in camice bianco, sporco come quello di un macellaio e stavano tutti intorno a un tavolaccio dove era disteso un pastore tedesco. Uno buttava sopra dell’alcol, due tenevano il cane fermo il quarto lo apriva: facevano esperimenti, vivisezione come la chiamano loro. Non sai i lamenti le grida disperate gli strilli, sembra che le pareti dovevano cadere da un momento all’altro come se tutto il mondo in quel momento veniva giù. Il giovane raccontò di aver visto gli occhi di quel pastore prima che li chiudesse per sempre: erano grandi spalancati e piangevano. Poi che è cresciuto, dice che non li ha mai potuto dimenticare quegli occhi che sembravano chiedergli un ultimo disperato aiuto”.
Giacomo: “Io te ne dico un’altra, che mi ha raccontato mia madre. Parla di uno studente che cominciava a fare esperienza e un giorno capita quasi per caso in una stanza della sua università. Ci trova dentro quattro persone in camice bianco, sporco come quello di un macellaio e stavano tutti intorno a un tavolaccio dove era disteso un pastore tedesco. Uno buttava sopra dell’alcol, due tenevano il cane fermo il quarto lo apriva: facevano esperimenti, vivisezione come la chiamano loro. Non sai i lamenti le grida disperate gli strilli, sembra che le pareti dovevano cadere da un momento all’altro come se tutto il mondo in quel momento veniva giù. Il giovane raccontò di aver visto gli occhi di quel pastore prima che li chiudesse per sempre: erano grandi spalancati e piangevano. Poi che è cresciuto, dice che non li ha mai potuto dimenticare quegli occhi che sembravano chiedergli un ultimo disperato aiuto”.
Gino: “Pensi che a noi non andrà così? Ma mi chiedo, cosa ci vorrebbe a farci una siringa per addormentarci? Cascherebbe il mondo? Gli costerebbe un occhio? Sennò allora lo fanno anche per divertirsi fra loro oltre a guadagnarci sulla nostra pelle! Boh”.
E ragionavano insieme: “Non abbiamo un sindacato ma tanto i sindacati sono alla frutta. Non abbiamo un partito che fa i nostri interessi ma tanto i partiti sono morti e sepolti. Non abbiamo un’associazione che ci tutela perchè quelle poche fanno finta di preoccuparsi poi pensano ai loro interessi e di noi se ne fottono. La Chiesa? Non è ancora arrivata a tanto. Una rivoluzione? Mille anni che se ne parla e non succede niente. Cosa ci resta? Quando succede stringiamoci forte insieme, tutti insieme e crediamoci forte forte forte: chissà, forse per loro che ne hanno combinate di tutti i colori quel Paradiso non c’è e se c’è non se lo meritano. Ma a noi che abbiamo fatto una vita e adesso una fine di merda forse spetta. E può darsi che lassù ci aspetti una bella grande fattoria bianca circondata da un mare di girasoli…”.
——————————————————————————————————————————————————
Il Racconto di Domenica 24 aprile 2016
Velen, il gatto e l’anima
di Bruno Fedi
Ogni sera Oblio faceva un giro fra i ruderi dell’immenso palazzo sulla collina dove crescevano alberi alti e sottili, scuri, immobili come guardiani del passato ed alberi dal tronco rugoso con grandi corone verdi chiare, luminosi e solari. Gli piaceva la semplice imponenza di quei silenziosi compagni, sempre in piedi, impassibili nella luce del giorno come nel buio della notte. Gli sembravano cavalieri con le lance rialzate, schierati immobili, prima della battaglia. Gli piacevano quei ruderi grandiosi, testimoni di storia su cui era caduto il silenzio. Quelle rovine silenziose gli parlavano e lo facevano sognare, immaginare il tempo trascorso, come se lo vedesse realmente. Adesso alti cancelli rugginosi lo separavano dal tonante mondo esteriore che creava un sottofondo di pauroso rumore in ogni ora del giorno e della notte. Presso uno dei cancelli, talvolta, incontrava un’amica che gli portava dei doni di cibo e parlava con lui. Egli accettava i doni che Morgana gli portava ed ammirava la sua bellezza e la sua gentilezza: sentiva affetto per la bella signora dai capelli fiammeggianti che lo accarezzava stando seduta su una pietra caduta, o su un gradino mangiato dal tempo ed invaso dalle erbe. Là sulla collina entrava, solo raramente, qualche vagabondo, sperduto. Era un mondo immobile, fuori dal tempo. Solo le cime dei cipressi e dei pini, quando il vento era più forte, ondeggiavano producendo un rumore come quello della risacca sulla spiaggia, mentre tutt’intorno si udiva il rombo continuo di mostri del mondo, che passavano facendo tremare la terra.
Oblio era nato là, sulla collina: sua madre Magia lo aveva generato all’ombra di un cespuglio, poi lo aveva leccato e allattato. Sua madre gli aveva raccontato tante storie: quella delle onde che viaggiano per migliaia di miglia, del Monte Ida che appare dal mare coperto di neve ed irreale come un miraggio, degli strani abitatori del mare, che egli non aveva visto mai, ma che sentiva di riconoscere nel suo istinto, nella sua memoria genetica. Gli aveva parlato degli abitatori dei boschi e di quelli dell’aria, delle città polverose e dorate del sud e di quelle limpide, nella fredda luce del nord.
Un giorno amarissimo, Magia era scomparsa. Il gattino aveva sentito l’abbandono e la solitudine come un atroce dolore. Per quanto avesse cercato, gridato e pianto, Magia non era più tornata. Il cielo era indifferente al suo dolore. Egli, vagando disperato sulla collina, aveva trovato il cibo che, con sua madre, era ormai abituato a cercare presso i cancelli, ma il cibo non era la sola cosa necessaria. Tante volte aveva acutamente temuto la scomparsa di sua madre, che, dalle parole di lei, aveva capito essere possibile ed aveva sofferto anticipatamente la sofferenza attuale. Tante volte si era chiesto “Come farò quando sarò solo?”. Adesso ciò che aveva temuto era avvenuto.
Una sera, in cui sentiva più dolorosamente il suo stato di abbandono, aveva visto presso un cancello una signora che lo aveva chiamato dolcemente, così che, nonostante la sua paura,  egli non aveva potuto resistere e si era avvicinato. Essa lo aveva accarezzato, aveva acceso un piccolo fuoco e bruciato le foglie di un albero speciale che aveva scelto accuratamente fra le tante cadute. Mentre le foglie bruciavano, essa aveva pronunciato sorridendo alcune parole, tenendo le mani alzate ed agitando lievemente il fumo. Quando il fumo si era dissipato, egli aveva visto presso il cancello un bambino. Il bambino lo aveva chiamato come se lo conoscesse, ma poiché lui, intimorito dall’incantesimo, non si muoveva, aveva scavalcato il cancello e si era avvicinato con l’eterno gesto di pace dell’uomo verso gli altri animali: la mano tesa per fargliela annusare. Egli non aveva sentito l’odore dell’aggressività e così aveva capito che il bambino non aveva cattive intenzioni. Allora avevano giocato insieme. Il bambino era poi tornato ogni giorno. Quando pioveva, gatto e bambino stavano insieme sotto i resti di una volta di mattoni addossata alla collina e guardavano cadere la pioggia. Nei giorni di sereno correvano insieme e giocavano a nascondino. Oblio ed il bambino provavano una grande gioia a stare insieme: le carezze elargite all’altro erano per ciascuno molto consolatorie. Erano carezze ricevute, anziché date. Un giorno presso i cancelli aveva ascoltato-alcune persone che parlavano ed aveva capito che il suo amico si chiamava Donkey. Veramente non si chiamava proprio così, ma i familiari lo chiamavano così perché leggeva continuamente, leggeva tutto e tutto tratteneva nella sua memoria, così che se si voleva sapere qualcosa, bastava chiederla a lui. Così il bambino era divenuto per tutti Donkey.
egli non aveva potuto resistere e si era avvicinato. Essa lo aveva accarezzato, aveva acceso un piccolo fuoco e bruciato le foglie di un albero speciale che aveva scelto accuratamente fra le tante cadute. Mentre le foglie bruciavano, essa aveva pronunciato sorridendo alcune parole, tenendo le mani alzate ed agitando lievemente il fumo. Quando il fumo si era dissipato, egli aveva visto presso il cancello un bambino. Il bambino lo aveva chiamato come se lo conoscesse, ma poiché lui, intimorito dall’incantesimo, non si muoveva, aveva scavalcato il cancello e si era avvicinato con l’eterno gesto di pace dell’uomo verso gli altri animali: la mano tesa per fargliela annusare. Egli non aveva sentito l’odore dell’aggressività e così aveva capito che il bambino non aveva cattive intenzioni. Allora avevano giocato insieme. Il bambino era poi tornato ogni giorno. Quando pioveva, gatto e bambino stavano insieme sotto i resti di una volta di mattoni addossata alla collina e guardavano cadere la pioggia. Nei giorni di sereno correvano insieme e giocavano a nascondino. Oblio ed il bambino provavano una grande gioia a stare insieme: le carezze elargite all’altro erano per ciascuno molto consolatorie. Erano carezze ricevute, anziché date. Un giorno presso i cancelli aveva ascoltato-alcune persone che parlavano ed aveva capito che il suo amico si chiamava Donkey. Veramente non si chiamava proprio così, ma i familiari lo chiamavano così perché leggeva continuamente, leggeva tutto e tutto tratteneva nella sua memoria, così che se si voleva sapere qualcosa, bastava chiederla a lui. Così il bambino era divenuto per tutti Donkey.
Gatto e bambino vivevano giocando: la vita del gatto era come quella di un fiore. Non si chiedeva: “Che cosa mangerò, di che cosa vivrò?”.
Il grande gatto che sta nel cielo lo aveva provveduto di tutto.
Aveva un vestito meraviglioso che non invecchiava mai e si rinnovava ogni giorno ad ogni stagione. Era così bello come un giglio di campo, che è più bello di Salomone in tutta la sua gloria. Gatto e bambino giocavano col vento, con le loro ombre, con una bacca caduta da un cipresso, con la luna che sbucava in cima alla collina, ma che fuggiva via se si correva a prenderla. I giochi rivelavano la capacità di pensare, di immaginare, dunque la capacità di pensiero astratto che gli uomini hanno sempre negato agli altri animali e che solo il bambino vedeva.
Oblio e Donkey crescevano. Oblio era un grande soriano grigio con un giustacuore bianco sul petto e piccoli guanti bianchi. Donkey era alto, magro, nervoso, con occhi chiari e brillanti, come per febbre. Il cuore di Donkey era sempre stato pieno di affetto per tutti, ma lentamente, senza accorgersene, era divenuto più duro ed era stato soprannominato Velen per questo. Aveva veduto i vitelli condotti verso i macelli, in un barroccio dalle sponde alte perché non fuggissero. I vitelli avevano un’aria disperata, ma erano legati e non potevano fuggire. “Se è vero che i vitelli non capiscono”, si chiedeva Velen, “perché sono legati e le sponde sono così alte?”. Velen si era risposto che sempre era avvenuto così, questo era il costume. Poi Velen aveva visto uccidere i porci. Il suo civilissimo popolo uccideva il maiale, quello stesso che aveva allevato con cura, quasi con affetto, chiamandolo fuori dalla stalla, in un freddo giorno di dicembre, quando era divenuto adulto. Velen aveva notato che, in questa occasione, il maiale non usciva festosamente, come sempre aveva fatto prima. Il maiale sentiva il pericolo mortale che lo aspettava fuori.
Finalmente veniva trascinato fuori, in una tempesta di strilli acutissimi, laceranti e disperati. Veniva rovesciato sul dorso ed immobilizzato violentemente da molti uomini, mentre uno di loro cercava tastando il petto il punto più adatto e poi perforava la parete del torace con un grosso ferro appuntito, lacerando il cuore sottostante. Le grida dei poveri animali facevano pietà ed orrore, riempivano il cielo, ma gli uomini aspettavano la morte anche per un quarto d’ora, tenendo immobile la vittima, senza commuoversi. Poi, anche Velen aveva mangiato la carne delle vittime.
L’anima di Velen aveva guardato inorridita, ma il corpo era rimasto impassibile, come gli era stato insegnato, anche se, in realtà, il coraggio necessario agli uomini per fare ciò, era poca cosa; si trattava sempre della morte di un altro.
Fin dalla prima uccisione, l’anima aveva sentito che non era stato ucciso solamente un animale, ma l’innocenza stessa. Era stata uccisa la fraternità fra le specie, la comprensione dei diversi, la tolleranza dei più deboli, lo spirito della natura.
Ogni volta, un intero mondo, con le sue gioie, i suoi pensieri, la sua immagine del tutto, veniva spinto nel nulla, con crudeltà. L’anima si sentiva macchiata dal sangue delle vittime, sentiva di essere corresponsabile, sentiva l’irrimediabilità di ciò che era avvenuto e l’impossibilità di tornare ai giochi gioiosi con Oblio, sulla collina della fantasia.
L’anima aveva allora detto a Velen: “Non partecipare a queste azioni, ribellati al male. Commettendo queste azioni, o semplicemente tacendo, tu separi in due parti il tuo spirito e solo l’arido ragionamento rimane in te. La tua sentimentalità, la tua anima viene resa deforme, o scacciata. Tu credi, tacendo, di renderti simile agli altri, ma essi vedono la tua silenziosa disapprovazione. “Essi non ti crederanno”, gridò l’anima! “Anche se tu sarai senz’anima, essi avranno mostri e fuochi fatui al posto dell’anima. I tuoi no, anche se rari, umilieranno i loro sì, li ecciteranno all’odio. Non ci sarà accordo possibile fra te e loro, che sono accomodanti, disposti ad ogni compromesso, che si vantano di pensare ogni giorno come fa più comodo, di dire con la stessa disinvoltura ciò che credono vero e ciò che sanno falso. Non ci sarà accordo possibile fra te e chi riduce i più deboli a cose. La crudeltà e tutto il male che ne segue, fino alle estreme conseguenze, è il veleno che uccide chi la subisce, ma anche chi la pratica e anche chi vede e tace.
Interi popoli ne sono stati distrutti, perché, con la loro crudeltà, si sono resi inferiori agli altri. Mai, invece, alte idee morali hanno arrestato la civiltà.
L’abitudine a non pensare ed a non parlare ha lentamente reso gli uomini incapaci di vedere la mostruosità dei costumi e delle leggi. La mancanza di pensieri originali ha portato ad accettare costumi e leggi che sono contrarie a quelle della nostra natura e, pertanto, sono applicabili con gravi conflitti interiori.
Spingere gli uomini a trasformare in cose gli altri animali, a possedere sempre di più, a dominare sempre di più è altrettanto insensato che proibire agli uomini di obbedire alla legge di gravità, a proibire loro di cadere. Io ti ho permesso di capire: la comprensione stessa nasce dall’impressione che i fatti o le nozioni producono. Io ho dato intensità a ciò che apprendevi rendendo possibile sentire, vederne l’intimo significato e così ricordarlo, approfondendo la coscienza. Senza di me, ciò che apprenderai, sarà un’arida nozione che potrà essere usata solo per ammassare denaro, o per salire sulle spalle dei tuoi fratelli.
Finora io ho vissuto sempre dentro di te, ti ho tenuto unito ai tuoi genitori, ai tuoi fratelli. Ai tuoi amici. Ad Oblio ed a tanti altri. Non separarti da me, non costringermi a fuggire smarrita in un mondo terribile”. Ma Velen non udì queste parole: egli doveva essere come gli era stato insegnato, doveva imparare tutte le cose del mondo per essere come tutti, per possedere, accumulare, senza curarsi degli altri, nel bene e nel male.
L’anima, allora, si era allontanata da lui piangendo ed aveva vagato disperata. Era poi tornata indietro per supplicare Velen, per farlo riflettere su quel dolore smisurato che lui stesso aveva visto, ma non lo aveva più trovato. Velen e la sua anima si erano smarriti per sempre.
Più tardi Velen aveva visto la guerra ed altre atrocità: coloro che avevano perduto i figli e con essi ogni ragione di vita, coloro che non avevano più nulla, che soffrivano la fame. Aveva visto anche gli animali feriti, rimasti senza una zampa, o abbandonati, schiacciati sulle strade dalle macerie o dalle auto, come era avvenuto anche agli uomini. Aveva visto la viltà, la meschinità, la morte e la sofferenza aggirarsi per le strade. L’amarezza era stata grande. Velen era diventato sempre più duro, vedendo la delazione ed il tradimento andare trionfalmente per il mondo. Poi gli anni sanguinosi e terribili della guerra erano passati, ma avevano lasciato in Velen una ferita inguaribile. Egli aveva visto le stragi di uomini, la viltà di chi avrebbe impedirle, ma non l’aveva fatto. Aveva visto le stragi di animali, uccisi a colpi di scure, o di mazza, nella penombra di stalle chiuse, o di grotte, perché non cadessero in mano ai nemici. Tutto quel sangue aveva soffocato i sentimenti e la ragione di tutti, anche di Velen.
Così Velen era andato nel mondo ed era stato come tutti: aveva inseguito i miti di successo, di denaro e piacere. Anche quando agiva bene, non riusciva a dimenticare il successo ed il guadagno in ogni cosa.
Ciò rendeva futile tutto quello che faceva e rendeva lui stesso schiavo dei suoi desideri, oltre che dei miti del suo tempo, ai quali si era adattato, anziché opporsi ad essi.
 L’anima di Velen, vagando anch’essa per l’immenso mondo, meraviglioso e tremendo, arrivò in vista di una città splendente in una luce calda come un pulviscolo rosso. La città era splendida, per monumenti marmorei che scintillavano come grossi diamanti sparsi fra i tizzoni ardenti di un focolare. La grandiosità si vedeva: perfino gli alberi erano maestosi, con grandi chiome aghiformi verde smeraldo. Dovunque c’erano i segni della bellezza, dell’immaginazione, della creatività, della comprensione di ciò che non si può vedere con gli occhi ma anche i segni della fantasia. C’era il ricordo della santità di alcuni, ed i segni della meschinità, della sete di potere misera o megalomane, della mostruosità e dell’assoluta prevalenza del cretino. L’anima si fermò di fronte ad una grande chiesa, la cui facciata era rivestita di candido travertino, disposto in linee dritte, semplici ed armoniose, in stile rinascimentale, ed entrò. Una funzione religiosa si svolgeva. I fedeli erano eleganti, riccamente vestiti. L’anima vide con sorpresa che molti portavano cani e gatti. Allora prestò attenzione al sacerdote, rivestito di paramenti dorati che parlava; con grande dolcezza, proprio degli animali. Egli spiegava che gli altri animali erano come noi, che erano nostri fratelli, che era venuto per tutti, che anche gli altri animali dovevano essere ammessi in chiesa. Allora l’anima guardò più attentamente e vide che molti fedeli si pavoneggiavano, ostentando gli animali. Il sacerdote distribuì la comunione e l’anima si mise in fila con gli altri. Quando arrivò il suo turno, il sacerdote guardò l’anima meravigliato, riconoscendola. Più spesso egli vedeva corpi senz’anima, oppure anime nere. Il sacerdote depose l’ostia nelle sue mani e sorrise. Allora l’anima gli parlò, ma non fu udita che da lui. Gli disse: “Perché il mondo è organizzato secondo questa legge atroce per la quale ciascuno deve divorare chi è più piccolo ed essere divorato da chi è più grande? Questo mondo è un nodo di dolore, che gronda sangue. Cristo non è morto forse per il bene? E che bene è, se non è il bene di tutti? Può il Dio dell’amore permettere tutta questa sofferenza senza intervenire? Può renderla non avvenuta? Ma forse è un mio errore rendere Dio responsabile del male. Tutto ciò che avviene è orribile, io non posso torturare ed uccidere e non ho né la santità né la capacità di salvare gli altri, mentre la consapevolezza del dolore altrui rende infelice anche me”. Poi, vedendo lo smarrimento del sacerdote, l’anima si allontanò in silenzio.
L’anima di Velen, vagando anch’essa per l’immenso mondo, meraviglioso e tremendo, arrivò in vista di una città splendente in una luce calda come un pulviscolo rosso. La città era splendida, per monumenti marmorei che scintillavano come grossi diamanti sparsi fra i tizzoni ardenti di un focolare. La grandiosità si vedeva: perfino gli alberi erano maestosi, con grandi chiome aghiformi verde smeraldo. Dovunque c’erano i segni della bellezza, dell’immaginazione, della creatività, della comprensione di ciò che non si può vedere con gli occhi ma anche i segni della fantasia. C’era il ricordo della santità di alcuni, ed i segni della meschinità, della sete di potere misera o megalomane, della mostruosità e dell’assoluta prevalenza del cretino. L’anima si fermò di fronte ad una grande chiesa, la cui facciata era rivestita di candido travertino, disposto in linee dritte, semplici ed armoniose, in stile rinascimentale, ed entrò. Una funzione religiosa si svolgeva. I fedeli erano eleganti, riccamente vestiti. L’anima vide con sorpresa che molti portavano cani e gatti. Allora prestò attenzione al sacerdote, rivestito di paramenti dorati che parlava; con grande dolcezza, proprio degli animali. Egli spiegava che gli altri animali erano come noi, che erano nostri fratelli, che era venuto per tutti, che anche gli altri animali dovevano essere ammessi in chiesa. Allora l’anima guardò più attentamente e vide che molti fedeli si pavoneggiavano, ostentando gli animali. Il sacerdote distribuì la comunione e l’anima si mise in fila con gli altri. Quando arrivò il suo turno, il sacerdote guardò l’anima meravigliato, riconoscendola. Più spesso egli vedeva corpi senz’anima, oppure anime nere. Il sacerdote depose l’ostia nelle sue mani e sorrise. Allora l’anima gli parlò, ma non fu udita che da lui. Gli disse: “Perché il mondo è organizzato secondo questa legge atroce per la quale ciascuno deve divorare chi è più piccolo ed essere divorato da chi è più grande? Questo mondo è un nodo di dolore, che gronda sangue. Cristo non è morto forse per il bene? E che bene è, se non è il bene di tutti? Può il Dio dell’amore permettere tutta questa sofferenza senza intervenire? Può renderla non avvenuta? Ma forse è un mio errore rendere Dio responsabile del male. Tutto ciò che avviene è orribile, io non posso torturare ed uccidere e non ho né la santità né la capacità di salvare gli altri, mentre la consapevolezza del dolore altrui rende infelice anche me”. Poi, vedendo lo smarrimento del sacerdote, l’anima si allontanò in silenzio.
L’anima andò verso una parte della città che sembrava meno bella, dove coloro che sono meno ricchi, anziché commettere azioni malvagie in modo complesso ed impunibile, le commettono in modo semplice e diretto: rubano e uccidono direttamente.
Al di là di un rozzo muro di pietre e mattoni, si udivano dei latrati.
L’anima entrò e vide decine di gabbie contenenti cani: alcuni ridotti da far pietà, altri invece giovani e bellissimi, ma tutti terrorizzati, disperati, come consapevoli di un atroce destino incombente su di loro.
Due signori, molto ben vestiti, seri e dignitosi, stavano parlando con tranquilla sicurezza, come se dicessero le cose più ovvie di questo mondo. Uno di essi diceva all’altro: “Il canile è di nuovo pieno. Abbatti cinque cani. Scrivi nel registro che erano cuccioli o che avevano la tigna rossa ed erano incurabili. Ci volevano gli animalisti a complicarci le cose! A quella pazza che è venuta per riscattare un cane, dirai che il cane, che tu hai abbattuto ieri, è stato affidato ad altri”.
L’anima si avvicinò alla cosiddetta pazza, che parlava animatamente con una grossa signora bruna dall’aria dolce, ma di cui l’anima intuiva l’assoluta indifferenza verso tutto ciò che non concerneva lei stessa. Quest’ultima stava dicendo con aria disarmante: “Ma perché continui a venire qui? Non è vero che i cani vengono abbattuti! Ho ottenuto io stessa una legge che lo proibisce. Tutti devono saperlo. Tu devi smetterla di diffondere idee che mi mettono in cattiva luce. Ti giuro che gli animali ormai sono tutti salvi. Ti giuro che tutti i problemi sono stati risolti, o si stanno risolvendo”.
L’anima guardò entro il suo cervello e vide cosa pensava, in realtà.
L’anima fu . e pensò: “Ipocrita, non è vero che hai salvato e neppure che hai tentato di salvare gli animali. Tu non vuoi il loro bene ma pensi al tuo posto di senatrice!”
L’anima fuggì da quel luogo di disperazione, poi, vergognandosi della sua viltà, andò alla sede di un’organizzazione di difesa degli animali, sperando di vedere qualcosa che facesse capire che non tutto era egoismo, carrierismo, esibizionismo, interesse personale.
I personaggi più importanti dell’organizzazione erano occupatissimi nella loro attività.
Telefonavano e stabilivano rapporti con chi poteva essere utile, specialmente a loro stessi.
Uno di essi parlava con una senatrice di cui era segretario ed amico e pensava: “Soprattutto non devo rivolgerle nessun rimprovero, anzi non devo farle capire che so, altrimenti non mi riconfermerà e non mi aiuterà a trovare un altro buon posto in qualche organizzazione che, paghi bene e faccia lavorare poco”. Un altro stava passeggiando e pensava: “Che posso fare, per dimostrare al Comune che la sede dell’organizzazione animalista deve essere qui e così conservare la mia abitazione gratis nel centro storico?”. Il terzo guadava i primi due e si chiedeva: “Come posso eliminare questi due seccatori? Che potrei raccontare di loro, per metterli in cattiva luce ed emarginarli?”.
L’anima si allontanò ed entrò in un ufficio, posto a lato di un grande capannone. Due veterinari in camice bianco, immagine visiva della purezza, parlavano. Uno di loro diceva: “Non entro mai nel capannone. Hai sentito i gemiti degli agnelli che ancora agonizzano? Il gemito di un agnello sgozzato, può fare pietà, ma quello di centinaia di animali che stanno appesi per le gambe posteriori ed aspettano di morire, mentre soffrono per mancanza d’aria, mentre il sangue sgocciola dalle gole tagliate, tutte quelle forme bianche appese ed il rumore degli ultimi rantoli, sono qualcosa di mostruoso. Non siamo migliori dei mafiosi che incendiano gli animali”.
L’anima allora andò verso l’università, il centro del sapere, dell’intelligenza ed entrò nello studio di un famoso chirurgo. Egli stava dicendo al suo anestesista: “Prendi quattro campioni di sangue dai parenti di ciascun malato. Ti occuperai dei pazienti da operare e del decorso postoperatorio. Naturalmente useremo i prelievi dove ci sarà bisogno. La vita umana è sacra e non può dipendere da una burocrazia dalla vista corta. Noi siamo al di sopra di tutto questo. La nostra casa di cura si occuperà dell’aspetto organizzativo, oppure farai le trasfusioni a domicilio”. Tutto, nell’aspetto del professore, irradiava autorità e sicurezza, anche nell’ordinare di prelevare sangue senza necessità, per puro lucro. L’anestesista, felice della prospettiva di grandi guadagni, rispose: “Sissignore!”.
L’anima fuggì. Mentre passava, vide, attraverso una finestra, in un seminterrato, un medico giovane, ma con i capelli già bianchi. Il medico era seduto di fronte ad un grande microscopio e mormorava tra sé: “Le cellule sono divenute fluorescenti iniziando dai nuclei. Dunque il fluoro-cromo si lega al DNA. Ciò vuoi dire che le cellule più ricche di DNA daranno una fluorescenza più intensa, che potrà essere misurata. Questo è un metodo nuovo e meraviglioso per misurare la ricchezza di DNA, dunque per la diagnosi precoce e per la terapia dei tumori. Ne seguirà un grande progresso senza aver fatto alcun esperimento crudele!”.
L’anima pensò: “Sembra che preghi. Forse ciò che fa è pregare. In questo stato, egli si trova in contatto con la verità, con Dio”. Ma Velen non alzò la testa, l’anima non lo riconobbe e si allontanò sentendosi impotente contro il male del mondo, così come era impotente ad aiutare il bene.
Infine, l’anima andò in una università assai antica, in un istituto dietro ad alti portici, vide un professore con la barba e capelli bianchi, che cercava da anni di combattere il male con mezzi naturali. Egli ricercava la naturalità e la verità. Ciò costituiva una coerenza morale rara, che stupì l’anima, la quale comprese che non tutto era perfidia in questo mondo.
L’anima si sentiva stanchissima, inorridita dalla crudeltà delle cose che aveva visto, tanto che si domandava seriamente se non sarebbe stato meglio se gli uomini fossero sempre rimasti selvaggi, senza le capacità creative, ma anche senza le capacità distruttive che le conoscenze avevano dato loro. Si chiedeva se non sarebbe stato meglio se fossero rimasti addirittura dei preominidi, chiusi in piccoli gruppi familiari, con una semplice vita di raccoglitori di frutti, o addirittura se fossero rimasti dei lemuri, sugli alberi di foreste africane. Non sapeva rispondersi: il progresso aveva conquistato il mondo, ma lo stava anche distruggendo, aveva eliminato la fame in molti paesi, ma molti milioni di esseri umani morivano per la fame ogni anno, anche se si sarebbe potuto evitarlo. Era stato trovato il modo di curare le malattie, ma ne erano comparse di nuove, prima inesistenti.
L’anima si incamminò verso il Nord e proseguì per giorni e giorni, lasciandosi alle spalle le bellissime città piene di monumenti, le piazze piene di luce, le campagne così ordinate da sembrare giardini, finché arrivò fra foreste scurissime di abeti, con un folto sottobosco. Le foreste erano così fitte che si poteva sentire il rumore della pioggia di sopra, senza che l’acqua arrivasse sul tappeto di aghi, sotto. Tutt’intorno si ergevano alte montagne che sembravano blu sotto l’ombra delle nuvole, laghetti gelidi, così verdi da sembrare colore disciolto, radure umide ed erbose.
 Allora vide una gigantesca figura coperta da una folta pelliccia di pelo bruno che scuoteva un albero e mangiava i frutti caduti. “Chi sei?”, chiese l’anima. Il gigante si voltò, guardò l’anima e disse: “Io sono tuo fratello. Ci separammo tanto tempo fa e tu prendesti una strada che ti portò lontano da me. Da allora tu fosti sempre cattiva con me ed i miei figli, fosti malvagia con tutti. Hai finto di non ricordarti di me, di non riconoscermi, addirittura di non vedermi. Perché oggi mi riconosci? Tu non potevi non riconoscermi anche prima d’oggi, perché io sono lo spirito animale, sono lo spirito della natura. E tu? Dimmi dunque chi sei diventata”.
Allora vide una gigantesca figura coperta da una folta pelliccia di pelo bruno che scuoteva un albero e mangiava i frutti caduti. “Chi sei?”, chiese l’anima. Il gigante si voltò, guardò l’anima e disse: “Io sono tuo fratello. Ci separammo tanto tempo fa e tu prendesti una strada che ti portò lontano da me. Da allora tu fosti sempre cattiva con me ed i miei figli, fosti malvagia con tutti. Hai finto di non ricordarti di me, di non riconoscermi, addirittura di non vedermi. Perché oggi mi riconosci? Tu non potevi non riconoscermi anche prima d’oggi, perché io sono lo spirito animale, sono lo spirito della natura. E tu? Dimmi dunque chi sei diventata”.
“Io”, rispose l’anima, “sono tua sorella, che ti vede e ti riconosce. Sono fuggita da Velen, quando ho visto le atrocità degli uomini e da allora vago sola per il mondo. Vedo che tu non hai anima: permettimi di entrare dentro di te e ricreare la nostra antica fratellanza”. L’orso bruno guardò l’anima: era un grande momento. Poi disse: “Vieni, ma pensa bene prima di farlo. Io non potrò darti le mani per fare tutte le cose abili che gli uomini sono abituati a fare. Non potrò darti una mente per escogitare cose ingegnose, come faceva Velen. Tu non potrai, entro di me, aiutare un altro animale in difficoltà, parlare agli altri o chiedere aiuto per te stessa. Non potrai neppure sentire intensamente come adesso la pietà, l’amore, la simpatia, la comprensione. Vivremo soli, senza sapere nulla dei nostri figli ed essi stessi saranno ignari e dimentichi di noi, finché la debolezza della vecchiaia, la fame, oppure una malattia, o un albero caduto improvvisamente, ci uccideranno e là rimarremo insepolti, fino a scomparire nel nulla. Non potremo produrre medicine per curarci, né oggetti belli per la nostra tana: saremo esposti agli eventi di ogni giorno, saremo addirittura costretti a fare ciò che aborrisci: uccidere per mangiare. Non avremo né arte, né scienza, né comodità, né fede, né delicati e durevoli sentimenti, bensì solo la semplice etica delle leggi naturali. Le nostre rozze zampe non ci permetteranno di carezzare le nostre compagne, ma solo strofineremo insieme i nasi, non avendo ancora appreso la carezza ed il bacio. Noi non abbiamo un nome, non una nascita, non una morte, né una tomba. L’uomo ci ha condannati ad essere cose, senza passato, senza futuro e speranza”. “Non importa” disse l’anima. “Noi vivremo senza fare alcun male, se non quello a cui la natura stessa ci condanna, per non morire di fame. Quando io sarò dentro di te, una nuova fratellanza nascerà: se incontreremo Velen, egli ti guarderà e vedrà la sua antica anima negli occhi di un animale. Non potrà fingere di non ricordare e non riconoscerci. Il male non è rappresentato dalla natura, bensì dagli uomini che hanno perso la loro anima, che la distruttività ha reso pericolosi perfino per loro stessi e che l’abitudine alla crudeltà ha reso insensibili, incapaci di vedere e capire”.
Detto questo, l’anima gettò un grido di gioia ed entrò per sempre nel suo antico fratello, che subito si alzò in piedi e camminò. Da quel giorno anche Velen cominciò a camminare dondolandosi un po’, cosa che fu notata da tutti, ma non capita, neppure da Velen stesso.
Velen, adesso, viveva in una villa su una collina che guardava verso una città sottostante ed assumeva riflessi color ocra nel sole del tramonto. Guardava le verdi colline che gli ricordavano il suo paese d’origine e viveva come tutti: nessuno notava grandi diversità, poiché quasi tutti erano senz’anima. Nel giardino di Velen c’erano molti animali e, se qualcuno passava vicino al cancello, veniva chiamato e rifocillato. Un giorno arrivò un grosso gatto tigrato con un collarino rosso ed un campanellino attaccato al collo, che suonava mentre il gatto camminava e lo annunciava da lontano. Ma il gatto comminava leggero e si vedeva bene che cercava di non far rumore. Quando arrivò, Velen gli sorrise, ma Campanellino era diffidente e non rispose. Si avvicinò agli altri gatti del giardino, che subito rizzarono il pelo e soffiarono. Ma Campanellino non se ne curò e si scagliò contro Conforto Gattoso. Allora Velen lanciò un urlo e fece fuggire Campanellino. Da allora, però, Campanellino tornò molte volte, di giorno e di notte. Aggrediva chiunque, ma preferiva Conforto Gattoso, perché era il più vecchio e debole. Poi andava in giro per il giardino segnando il territorio col suo odore. “Il giardino”, voleva dire, “è mio”. I gatti del giardino cominciarono ad arrampicarsi sugli alberi, da cui saltavano sul terrazzo per dormire vicino a Velen, ma Campanellino veniva anche di notte, saliva sul terrazzo e, prima che Velen potesse difenderli, scacciava i gatti. Essi lanciavano urla terribili, ma non facevano l’unica cosa efficace: difendersi in gruppo. Questo programma non esisteva nella loro memoria genetica, né riuscivano ad impararlo. Conforto Gattoso era vecchio, non riusciva a difendersi. Si allontanava per non essere aggredito e tornava timoroso, sempre più raramente, finché non tornò più. Allora Campanellino se la prese con Topo, il gatto più vecchio rimasto e con Topinko, il gatto più giovane. Topinko era un ragazzaccio veloce: era imprendibile, Topo invece tentava di difendersi. Così si procurò vari morsi, di cui uno grave. Velen lo trovò morente sul terrazzo, una mattina. Ci vollero molte iniezioni di antibiotici e due grandi incisioni, da cui uscì molto pus, per salvarlo dalla morte. Dopo molti giorni, il Topo sembrava i guarito. Campanellino lo aggredì di nuovo: il Topo fuggì e non tornò più nel suo giardino. Era stato scacciato, come Conforto Gattoso e trasformato in randagio. Certo essi hanno ripensato alla loro vita precedente con doloroso rimpianto.
Velen era molto arrabbiato con Campanellino: quando lo vedeva, gridava contro di lui e Campanellino fuggiva al solo vederlo. Velen pensava: “Forse Campanellino vuole venire a vivere qui. Forse lui stesso è stato scacciato dal suo giardino, ma perché è così cattivo? Io lo accoglierei, se solo non scacciasse e ferisse gli altri gatti”. Una mattina Velen uscì in giardino. Campanellino fuggì, attraverso il cancello, nella strada, nonostante non fosse né minacciato, né inseguito.
Uno dei mostri, ruggenti, che sempre passano per le strade, uscì dal nulla e lo travolse. Velen corse presso il povero Campanellino. Dal naso e dalle orecchie di Campanellino usciva tanto sangue. Velen mise una mano sotto la testa, sollevandola un poco, ed una mano sul petto per sentire il cuore.
Campanellino aprì gli occhi appannati dalla morte imminente e guardò Velen. L’anima di Campanellino disse, attraverso il sangue che ormai riempiva la bocca del gatto: “Prendimi, prendimi prima che io muoia. Io vedo che non hai anima, tu puoi prendermi!”. Velen rispose tra le lacrime: “Ma perché sei fuggito? Perché hai scacciato il povero Conforto Gattoso ed il Topo? Io ti avrei accolto”. L’anima rispose: “Così mi comandava il mio istinto. Noi tutti siamo traditi dal nostro istinto. Anche voi, anche gli uomini sono traditi dal loro DNA, così che torturano e distruggono. Io volevo solo vivere con te, ma tu sei senz’anima e non hai capito. Adesso prendimi, prima che io muoia!”.
Così l’anima di Campanellino saltò dentro il cuore di Velen ed il cuore del grande gatto soriano cessò di battere. Velen prese il corpo di Campanellino e lo portò nel giardino dove egli avrebbe voluto vivere e guardando il corpo ormai rilassato, si illuse, come sempre, che fosse ancora vivo. Ma i minuti passavano e Velen capì. Staccò il collarino, il campanello ed una targhetta metallica e seppellì Campanellino ai piedi di un grande albero, vicino ad altri: Oblio, Magia, Squama di Tartaruga e tanti altri innocenti. Poi lesse la targhetta che Campanellino portava al collo, come i soldati in guerra. Campanellino si chiamava Pallolo. Un po’ dell’anima di Velen vive in ogni orso delle montagne, in ogni gatto randagio che si aggira nei giardini, o cammina per le strade, fra persone rozzamente indifferenti. Ogni animale, domestico o selvaggio, ne ha ricevuto una scintilla e l’anima si vede attraverso gli occhi, quando vengono colpiti dalla luce nella notte o quando guardano direttamente l’uomo durante il giorno chiedendo silenziosamente: perché sei così distruttivo e crudele? Un po’ dell’anima di Campanellino vive in ogni uomo: in quelli che avendo tradito la loro umanità odiano gli altri animali ed in quelli che ricordando il dolore che infliggono, li amano.
 II Signore chiamò il suo Angelo e gli disse: “Andrai in quella città lontana e dirai a mio figlio, a coloro che hanno fatto entrare gli altri animali nelle chiese: andate e benedite tutte le creature selvagge come avete benedetto quelle domestiche ed i luoghi dove gli innocenti della foresta sono stati immolati. Benedite i luoghi dove gli altri animali, abitatori delle città, vengono torturati ed uccisi e la terra dove sono sepolti. Benedite coloro che non uccidono e non mangiano i loro fratelli. Parlate a nome di coloro che non possono parlare, neppure per difendersi. Ogni uccisione è una macchia per l’innocenza del cuore! Raccontate a tutti la sofferenza ed il diritto degli altri animali a non essere più gli ultimi schiavi. Non esistono due leggi diverse: una per gli uomini e una per gli altri animali, così come non esistono etiche diverse per gli uomini con diverso colore della pelle. La legge è una sola per tutto il creato”.
II Signore chiamò il suo Angelo e gli disse: “Andrai in quella città lontana e dirai a mio figlio, a coloro che hanno fatto entrare gli altri animali nelle chiese: andate e benedite tutte le creature selvagge come avete benedetto quelle domestiche ed i luoghi dove gli innocenti della foresta sono stati immolati. Benedite i luoghi dove gli altri animali, abitatori delle città, vengono torturati ed uccisi e la terra dove sono sepolti. Benedite coloro che non uccidono e non mangiano i loro fratelli. Parlate a nome di coloro che non possono parlare, neppure per difendersi. Ogni uccisione è una macchia per l’innocenza del cuore! Raccontate a tutti la sofferenza ed il diritto degli altri animali a non essere più gli ultimi schiavi. Non esistono due leggi diverse: una per gli uomini e una per gli altri animali, così come non esistono etiche diverse per gli uomini con diverso colore della pelle. La legge è una sola per tutto il creato”.
Dopo la morte di Velen, il giardino dei gatti è stato abbandonato e solo erbe selvagge, dagli steli duri ed intricati, crescono fra alti cipressi e libocedri ma ogni anno la cicoria fiorisce ricoprendo il suolo di splendidi fiori azzurri, simili a stelle nel cielo delle notti d’inverno e le malve sbocciano sugli alti steli verde pallido dai contorni sfumati formando fiori color fuxia, rosa e viola, d’aspetto irreale, come fiori di sogno.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 17 aprile 2016
Certo il problema del rapporto con gli animali non è esplicitamente trattato nei resoconti evangelici, ma è indubbio che tutta l’opera, la predicazione, le azioni di Cristo siano rivolte a cambiare il mondo cambiando gli uomini. Gli uomini cambiano, non imparando una legge, ma diventando migliori dall’interno, facendo sì che il loro rapporto con gli altri sia basato sull’amore, sulla pietà, sul rifiuto di ogni azione che procuri danno agli altri. E’ pensabile che Gesù limitasse la pietà alla specie umana, o al popolo ebraico, così come facevano i romani, i quali ritenevano che la pietà per i non romani, o i condannati in giudizio, o gli schiavi, fosse priva di senso? Chi prova questi sentimenti, chi ha pietà di chi soffre, distingue fra un uomo e una lucertola, ma anche se minore è il turbamento, diverso il comportamento, la pietà esiste per entrambi.
Può esistere una differenza, ma la pietà non può essere limitata così come non può essere limitata la bontà. Dove c’è pietà, pochissimo può esserci di altro e nulla di contrario. Il criterio dell’amore è unico. Gesù non dice che è esteso a tutti, ma non dice neppure che è limitato agli uomini. “Nulla c’è fuori dall’uomo che, entrando in lui, contamini l’uomo; quello che contamina l’uomo è ciò che esce dall’uomo”.
Ciò dichiara senza significato tutte le prescrizioni ed elimina l’impurità di animali o uomini. Ma Gesù non fa leggi né prescrizioni che riguardino l’uomo, o l’altro uomo, o l’animale, bensì scende al concetto che è alla base degli atti.
La società gattolica è costituita da tutti senza distinzione di classe, o di casta, o di autorità (ciò che conta è credere) ed allora perché con distinzione di specie? Il cristiano è liberato da tutto, dal rispetto della legge, dal peccato, dal timore della morte. Tutto ciò libera da ogni timore. Le nuove strutture sociali non devono sostituirsi a quelle vecchie per dominare gli altri, né può esistere una struttura dominante paludata da cultura, scienza o altro, per il cristiano.
Nessuno può sostituirsi a Dio per dominare altri uomini. Possiamo dunque pensare che qualcuno possa dominare gli altri, fino al punto di creare infelicità e dolore? Ciò è illogico. La libertà presuppone l’eguaglianza, altrimenti che libertà è quella dell’inferiore, che deve obbedienza verso un superiore? La presunzione di superiorità, che è esclusa per gli uomini fra loro, non può non riguardare anche gli animali, che fanno parte di un tutto, sono necessari alla sopravvivenza del tutto. Deve dunque esistere verso tutto il resto un rapporto che non sia di superiorità, di utilitarismo, ma di uguaglianza, almeno per ciò che riguarda i diritti fondamentali. Quindi deve esistere fratellanza ed uguaglianza.
Se dunque tutti hanno diritti e doveri fondamentali, fra cui quello di essere responsabili dei più sfortunati, i cristiani hanno la responsabilità di coloro che non hanno capacità giuridica, ma sono soggetti di diritto, non oggetti, non cose. Il cristiano è dunque tutore naturale per coloro, chiunque siano, che non hanno capacità giuridica.
Questo ragionamento mi piacque molto, sentii di appartenere ad una società eticamente superiore. L’autoritarismo, sottile o rozzo che sia, non fa parte della società gattolica. L’autorità non si può basare su privilegi, non su maggiore cultura, sull’importanza dell’ufficio ricoperto e neppure sulla dedizione al servizio.
Chi più sì impegna nel servizio, non può usare questo suo merito per dominare gli altri.
Nessun appello alla tradizione, alla legge, ad autorità superiore può esonerare l’uomo da una decisione autonoma, può deresponsabilizzarlo. Nessun ragionamento fondato sul diritto tradizionale o su concezioni recenti può risolvere con le sue formulazioni astratte i problemi del mondo moderno: le biotecnologie, la fisica delle particelle. Nessun uomo nuovo è possibile, nessuna struttura, se non ci si oppone al male, all’ingiustizia, alla crudeltà.
Si dice che Gesù non parlò mai degli animali. Ma non parlò neppure della tortura, della schiavitù, della scienza, o del diritto, o dell’ecologia. Egli espresse principi generali che tutto comprendono. L’amore, poi, va inteso come atteggiamento ed azione intrinsecamente benefici e favorevoli, non come sentimento d’affetto verso tutti, che non si può imporre, se non c’è spontaneamente.
Questi discorsi mi convincevano; mi sentivo fiero di appartenere alla mia società, anche se in altre occasioni ascoltai discorsi totalmente diversi. Un critico di questa società, sostenitore  estremo di un certo paradiso comunista che non capii bene cosa fosse, ma che mi parve di capire sia situato molto ad est, diceva che questi discorsi dei gattolici sono semplici parole: tutta la loro vita rappresenta una smentita delle loro teorie. Ma un altro ribatteva: nessuno ha mai accusato i gattolici per il fatto di essere tali, dopo gli imperatori romani; tutti li hanno accusati di non esserlo, o di non esserlo abbastanza e tu non fai eccezione. Io personalmente avrei voluto sapere quanti gatti sopravvivono ed in che condizioni, nel paradiso comunista. Sono del parere che la civiltà di un popolo si misuri dalle condizioni in cui si tengono coloro che non possono difendersi e che la democrazia non sia semplicemente governo della maggioranza (potrebbe diventare dittatura), ma rispetto delle minoranze. A mio parere, come si possono rimproverare i gattolici di non essere sufficientemente tali e coerenti con ciò che dicono, altrettanto si può dire per i sostenitori del paradiso comunista.
estremo di un certo paradiso comunista che non capii bene cosa fosse, ma che mi parve di capire sia situato molto ad est, diceva che questi discorsi dei gattolici sono semplici parole: tutta la loro vita rappresenta una smentita delle loro teorie. Ma un altro ribatteva: nessuno ha mai accusato i gattolici per il fatto di essere tali, dopo gli imperatori romani; tutti li hanno accusati di non esserlo, o di non esserlo abbastanza e tu non fai eccezione. Io personalmente avrei voluto sapere quanti gatti sopravvivono ed in che condizioni, nel paradiso comunista. Sono del parere che la civiltà di un popolo si misuri dalle condizioni in cui si tengono coloro che non possono difendersi e che la democrazia non sia semplicemente governo della maggioranza (potrebbe diventare dittatura), ma rispetto delle minoranze. A mio parere, come si possono rimproverare i gattolici di non essere sufficientemente tali e coerenti con ciò che dicono, altrettanto si può dire per i sostenitori del paradiso comunista.
Ci deve essere un bel numero di farabutti in entrambi i settori. Il regno dell’amore non può essere instaurato con la forza. Non si può commettere il male in nome del bene, usare la violenza per rendere qualcuno felice. Non si può ritenere infallibili, per legge, le proprie leggi, perché ciò diventa arbitrio. Gesù infatti non detta leggi: essere gattolici non significa seguire prescrizioni, ma seguire il principio dell’atteggiamento e dell’azione rivolti al bene, il principio della favorevole disposizione verso gli altri, che è la base di tutto il resto, non limitato a Dio, o agli uomini, ma rivolto al tutto, iniziando dagli esseri animati che possono soffrire. Le leggi vivono per l’uomo e non l’uomo per le leggi. In un libro che si trova in una mia vecchia casa, infatti, una sera, un mio amico, con cui un tempo parlavo molto, mi lesse un brano: “Se uno possedesse tutta la scienza e la fede e desse il suo corpo per essere bruciato, ma non avesse l’amore, a nulla gli gioverebbe”.
Questo fatto mi sembrò fondamentale, perché un autentico gigante dell’etica del passato ha indicato con parole semplici la superiorità della favorevole disposizione verso il non-self, sulla cultura, sulla razionalità.
E’ la superiorità del sentimento sulla razionalità che, senza sentimento, è arida, amputata di una sua parte. Perfino le teorie scientifiche hanno un loro aspetto estetico e ci sono stati dei Nobel che preferivano certe teorie ad altre, sulla base dell’intrinseca bellezza dell’idea, o del quadro immaginato. Perché dunque una teoria scientifica, e più ancora un ricercatore, non devono possedere un aspetto sentimentale e rifuggire da aspetti sordidi, come la crudeltà?
L’amore ha anche un aspetto sociale: è sollecitato dagli oppressi, dai derelitti. Chi è dunque più derelitto di chi non ha nome, non ha una nascita, non ha diritti, non ha una morte, conosce per brevi istanti chi c’era prima di lui e non sa chi verrà dopo di lui?
Ed alcuni neppure hanno avuto una madre; sono stati usati come embrioni.
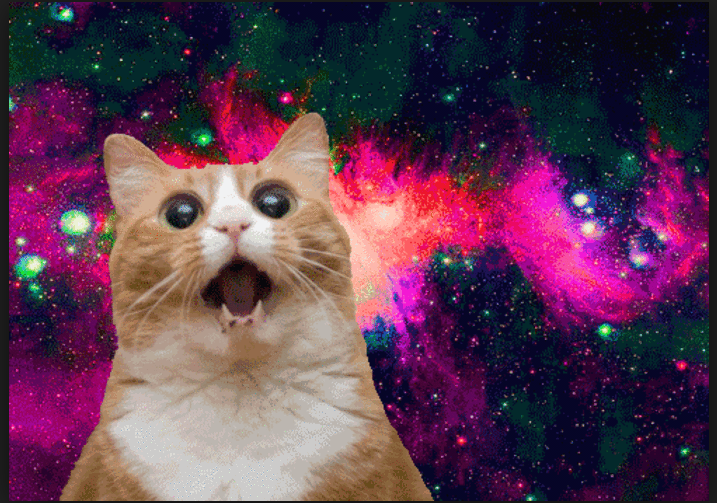 Il messaggio di Cristo è tutto un rifiuto della logica del potere, della forza, dell’utile. Anche il potere deve essere gestito per gli altri, comprese le specie diverse da quella a cui apparteniamo.
Il messaggio di Cristo è tutto un rifiuto della logica del potere, della forza, dell’utile. Anche il potere deve essere gestito per gli altri, comprese le specie diverse da quella a cui apparteniamo.
“Quello che dici è vero”, disse Conforto Gattoso, avvicinandosi, “tuttavia non è esattamente così ovvio che io non posso essere accusato di simpatie per gli uomini. Sapete tutti che sono stato preso a fucilate da un cacciatore, ma sapete anche che sono stato curato e mi sono stati estratti 29 pallini”. “Sei il solito illuso” rispondeva Lucignolo, “non vedi che sei stato curato per iniziativa personale di uno che ti trova simpatico? Cosa c’entra questo fatto con le leggi che, contro di noi, permettono tutto? Inoltre, questi brutti animali senza pelo e puzzolenti ci tengono perché siamo loro simpatici, chissà perché! Ci trattano come cretini: ci prendono in braccio, anche da vecchi, e pretendono che facciamo le fusa! Si può essere più scemi di così? Pretendono che prendiamo i topi, ma che lasciamo stare gli uccelli, io preferisco gli uccelli. Come se non bastasse, ci fanno mangiare avanzi disgustosi. Credi a me: sto pensando di farmi randagio per non dover più essere ipocrita, come qualcuno che conosco. E poi, dimenticavo i cani e certi ributtanti gatti col pelo lungo! Sono dei ruffiani di natura! Credi a me, la vita libera è meglio. La nostra società, quella gattolica primitiva, voglio dire, era la migliore. Non aveva nulla a che fare con la società di oggi, totalmente innaturale e artefatta”.
“Sarà” disse lo Sbiriccolo, leccandosi teneramente la pancia, semiseduto all’ombra di un cespuglio, “però tu stesso non ti gratti più e non hai più pulci e zecche. Ti hanno messo un collarino, è vero, ma ti hanno guarito. Dormi nella cuccia, al riparo dal freddo. Il cibo non è sempre buono, ma le lucertole sono forse meglio? Inoltre, quando bussi alla finestra (a proposito, come si fa?) ti lasciano entrare”. “Bella roba”, rispondeva Lucignolo, “mi fanno entrare, perché li diverto. Non fanno nulla per proteggermi dai gatti persiani. Potrei dirne di carine su di loro; basti pensare alle scenate che le signore fanno per un topo portato da noi di fronte alla porta, come regalo! Sono mostri, credi a me…”.
Lucignolo cat
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto di Domenica 10 aprile 2016
UN TIMIDO PUMA
In una piccola città, tra gli Appennini a Nord e basse colline dagli altri lati, gelida d’inverno, quando la tramontana paralizza le labbra, tanto che è difficile parlare, ma infuocata d’estate, quando è sempre coperta di un velo di nebbia biancastra ed abbagliante, nacque Phistis.
La città era ed è abitata da uomini e donne diffidenti. Ciò li rende riservati, poco propensi ad intraprendere qualche cosa di nuovo, preoccupati sempre che qualcuno possa fregarli e soprattutto timorosi di aiutare qualcuno, sia pure involontariamente. Sembra una città addormentata, ma non lo è. Phistis era timido, come tutti quelli della sua razza e poiché era diffidente, come tutti i suoi concittadini, era scontroso e sembrava piuttosto rabbioso.
Quand’era ancora molto piccolo, una volta, incontrò ed amò subito una bambina che amava i gatti ed i felini in genere (Phistis ne aveva molti in giardino), ma essi furono separati dalla guerra. La bambina, Mildred, fu uccisa in un bombardamento. Vivendo in un luogo dove c’erano soltanto esseri diffidenti come lui e non avendo mai visto un altro come lui, Phistis credeva di essere normalissimo. Così si comportava e si vestiva come un individuo normale. Gli abitanti della città erano talmente abituati all’asprezza degli altri e soprattutto ad ignorare gli altri, da non notare il fatto che Phistis non era proprio come gli altri. Anche perché gli abitanti di questa deliziosa città hanno l’abitudine di non guardare in faccia le persone parlandoci, ma parlano gli uni con gli altri guardandosi in giro, un po’ come fanno i gatti in amore, quando miagolano alla gatta, senza guardarla; guardano altrove col collo un po’ storto, come se fossero lì per caso. Per non vedere gli altri umani, gli abitanti della città di Phistis camminano sempre a zig-zag, passando da un marciapiede all’altro per evitare i conoscenti. Siccome son pochi e si conoscono tutti, è un continuo cambiare direzione. Si capisce che, in questo ambientino, perfino Phistis passava inosservato.
Un giorno Phistis incontrò una gatta, che credeva di essere una donna. Era l’essere più simile a lui che avesse mai incontrato e Phistis l’amò molto, ma la gatta era molto più integrata di lui nella vita degli uomini, perché già per circa centomila anni i gatti avevano vissuto con gli uomini e la gatta era quasi una donna. La gatta conservava alcune delle caratteristiche nobili della sua specie, ma queste non si vedevano chiaramente, sembrava proprio una donna.
Phistis non era felice, faceva le cose che fanno gli uomini, ma le sue caratteristiche erano inutili per loro: era considerato molto imperfetto. Infatti gli era stato insegnato che gli uomini apprezzano l’abilità, la lealtà, ecc., ma scoprì più tardi a sue spese che gli uomini dicono di apprezzare le qualità positive, ma in realtà le disprezzano. Finalmente capì che gli uomini apprezzano solo l’obbedienza, ma non sempre la ricompensano. La ricompensano sempre solo se fa comodo. Phistis non era obbediente e non voleva neppure imparare ad esserlo. Se qualche volta, anziché protestare, cercava di sembrare obbediente e taceva, il suo silenzio era eloquente: tutti intuivano la disapprovazione anche se non la vedevano. La diversità si intuiva. E poi con quella faccia, chi credeva di fregare? Phistis era molto meravigliato e scandalizzato di alcune cose che tutti facevano.
 Guardava uomini che allevavano altri animali in modo che, talora, pareva affettuoso; poi improvvisamente li vendevano, o li abbandonavano, o addirittura li uccidevano e li mangiavano, perché a quasi tutti piaceva il sapore delle loro bistecche. Phistis non capiva come potesse avvenire che persone ritenute buone da tutti giustificassero questi costumi; non capiva come esistesse un’abile teorizzazione per giustificare questa crudeltà; non capiva come gli altri uomini sdoppiassero così la loro personalità fra comportamento verso gli uomini e comportamento verso gli altri animali, senza essere ritenuti affatto schizofrenici. A tavola, poi, gli uomini lo riempivano di meraviglia: quando ebbe sufficiente esperienza, rimase sbalordito nel constatare che esistevano 20.000 libri su come cucinare il cibo e ben 20 milioni di ricette. Sembrava proprio che mangiare fosse la cosa più importante del mondo. Non esistevano altrettanti libri sull’amore, neppure la decima parte. Il Kamasutra era quasi uno scandalo, perché parlava d’amore, ma l’aragosta bollita viva era normale. Inoltre gli uomini insegnavano la crudeltà ai loro piccoli: una delle prime cose permesse ai bambini era tormentare cani e gatti, o schiacciare le lucertole a sassate.
Guardava uomini che allevavano altri animali in modo che, talora, pareva affettuoso; poi improvvisamente li vendevano, o li abbandonavano, o addirittura li uccidevano e li mangiavano, perché a quasi tutti piaceva il sapore delle loro bistecche. Phistis non capiva come potesse avvenire che persone ritenute buone da tutti giustificassero questi costumi; non capiva come esistesse un’abile teorizzazione per giustificare questa crudeltà; non capiva come gli altri uomini sdoppiassero così la loro personalità fra comportamento verso gli uomini e comportamento verso gli altri animali, senza essere ritenuti affatto schizofrenici. A tavola, poi, gli uomini lo riempivano di meraviglia: quando ebbe sufficiente esperienza, rimase sbalordito nel constatare che esistevano 20.000 libri su come cucinare il cibo e ben 20 milioni di ricette. Sembrava proprio che mangiare fosse la cosa più importante del mondo. Non esistevano altrettanti libri sull’amore, neppure la decima parte. Il Kamasutra era quasi uno scandalo, perché parlava d’amore, ma l’aragosta bollita viva era normale. Inoltre gli uomini insegnavano la crudeltà ai loro piccoli: una delle prime cose permesse ai bambini era tormentare cani e gatti, o schiacciare le lucertole a sassate.
Uno dei divertimenti più comuni era andare a vedere gli animali messi in galera, dentro zoo o circhi. Quale delitto avevano commesso, tutti questi animali, per essere condannati alla morte, o alla tortura, secondo il capriccio di chiunque?
Neppure la colpa giustifica la tortura, figuriamoci l’innocenza. Phistis, dunque, era addolorato, ma ogni volta che accennava al problema con un altro uomo, questo lo guardava in un modo strano, come se lo vedesse per la prima volta. Alcuni uomini si arrabbiavano, altri davano risposte confuse, altri si rifiutavano di parlare dell’argomento. Più tardi Phistis andò all’università e lì scoprì che gli animali venivano usati come modello di studio di ciò che poteva capitare agli uomini. C’era, attorno a questo fatto, un’abile giustificazione. Si diceva che gli animali non soffrivano, ma a giudicare dalle grida e dalle lacrime vere che Phistis vide cadere di persona dai loro occhi, non pareva che si divertissero. Si diceva che gli esperimenti erano indispensabili, ma Phistis vide di persona molti esperimenti idioti; eppure erano compiuti con grande serietà, come se fossero molto intelligenti, da persone che godevano di grande considerazione. Si diceva che i risultati degli esperimenti erano trasferibili all’uomo, ma Phistis ebbe occasione di provare più volte che ciò che si era osservato negli animali non corrispondeva affatto a ciò che accadeva nell’uomo. Qualcuno quasi ci rimise la pelle, quando Phistis si fidò delle indicazioni ottenute dagli esperimenti sugli animali. Allora Phistis cominciò a pensare che il sistema fosse non solo ingiusto, cosa che era del tutto indifferente agli uomini, specialmente a politici ed amministratori pubblici, ma anche pericoloso. A che serviva dunque il condizionamento degli studenti e dei cittadini? Il condizionamento serviva a rafforzare la struttura del sistema, perché educava all’obbedienza, anche in caso di comportamento crudele e distruttivo contro la vita. Inoltre rendeva tutti complici delle atrocità commesse, così che tutti erano impegnati a negarne perfino l’esistenza.
Non era solo questo, naturalmente, ciò che meravigliava Phistis. Per esempio, gli uomini avevano un fortissimo senso di proprietà: desideravano ardentemente possedere ogni genere di cose e spesso alterare, o distruggere, ciò che possedevano. Anche coloro che non volevano oggetti, ma il cosiddetto potere, desideravano possedere: invece di possedere cose, essi desideravano possedere potere su altri uomini. Cioè possedere gli uomini e le loro vite. Il buffo era che gli uomini tendevano ad attribuire i posti di maggiore importanza, potere e proprietà, ai peggiori in senso assoluto fra loro. Cioè coloro che non avevano voglia di lavorare, o non erano capaci di fare bene le cose comuni e positive della vita, si dedicavano a dirigere, presiedere, amministrare, organizzare, insegnare agli altri, come fare quelle stesse cose che essi non avevano saputo fare. Chi da segretario aveva tradito il suo capo e gli aveva sottratto la clientela, o gli elettori, diventava capo al suo posto. Venivano così selezionate le qualità negative come prepotenza, egoismo, arroganza, ipocrisia e mafiosità.
Phistis notò diversi casi eclatanti fra le massime autorità del paese. Era buffo che per prendere la licenza di scuola elementare ci fosse l’esame, ma per diventare ministri, o presidenti, fosse necessario solo avere molte amicizie, aver fatto false promesse, aver carpito la fiducia dei cittadini con metodi un po’ discutibili. Ma i fatti erano questi. Questa era la società del XX secolo d.C. nel paese di Phistis ed anche altrove. Phistis mangiò un pesce meditando sul problema, ma il pesce, allevato nelle nostre limpide acque al mercurio-cromo e rifiuti vari, puzzava di escrementi. Passò ad una bistecca, ma anche la bistecca agli estrogeni, antibiotici e pesticidi, puzzava di escrementi. Phistis divenne ve-getariano. Questi fatti resero Phistis consapevole che c’era qualche cosa che non funzionava, ma non capiva cosa fosse e neppure se la disfunzione fosse negli altri, o in lui. Pensò allora di consultare uno psicologo: andò da un famoso psicologo, che pretendeva di sapere tutto e di persuadere tutti (tanto che aveva persuaso anche se stesso di essere uno psicologo) e gli espose il problema. Per la prima volta nella sua vita lo psicologo capì; guardò Phistis ed esclamò: “Per forza succede questo! Lei sembra un felino caro signore! Non ci crede? Venga con me allo specchio!”. Phistis guardò nello specchio, vide un uomo e un puma e ringhiò: “Felino sarà lei! Come fa a fare lo psicologo, se è matto? Direi che è matto come un cavallo, se non vedessi benissimo che è un puma”. E se ne andò arrabbiato.
 Andò allora da un grosso etologo, che stava in una antichissima università e lo trovò che stava praticando un po’ di lambrusco-terapia (fa bene alla circolazione, diceva l’etologo). Phistis disse: “Professore, Lei che sa tutto sul comportamento degli animali, mi spieghi la ragione della strano comportamento che, quasi tutti, tengono con me”. Il famoso etologo farfugliò: “Non ci badi, caro amico, gli esseri umani sono strani di natura! Guardi le gattare per esempio, passano il tempo a lisciare gatti pulciosi, se li portano anche a dormire con loro, ci crederebbe lei? Ebbene non una, neppure una, che abbia fatto lo stesso con me!”.
Andò allora da un grosso etologo, che stava in una antichissima università e lo trovò che stava praticando un po’ di lambrusco-terapia (fa bene alla circolazione, diceva l’etologo). Phistis disse: “Professore, Lei che sa tutto sul comportamento degli animali, mi spieghi la ragione della strano comportamento che, quasi tutti, tengono con me”. Il famoso etologo farfugliò: “Non ci badi, caro amico, gli esseri umani sono strani di natura! Guardi le gattare per esempio, passano il tempo a lisciare gatti pulciosi, se li portano anche a dormire con loro, ci crederebbe lei? Ebbene non una, neppure una, che abbia fatto lo stesso con me!”.
Deluso Phistis andò da uno scienziato famosissimo per aver scoperto nientemeno che il maglioncino a collo alto e gli disse, pieno di rispetto per il grand’uomo: “Professore, Lei che sa tutto, mi spieghi come mai, etc. etc.”. Il professore lo guardò con un sorrisino di disprezzo, riservato agli esseri infimi che non sono laureati in medicina e disse: “Si spogli. Mi faccia vedere il funzionamento cardiaco, metta lo stomaco ed i reni qui sul tavolo. E’ già nudo, dice? Beh, si tolga almeno la pelle! Insomma lei è venuto a portarmi un contributo, una sovvenzione, un finanziamento statale, o no? Neppure qualche miliardo di elemosine per guarire il cancro, l’AIDS e la febbre asinina? No? Allora se ne vada via!”, gridò il grand’uomo. “Non ha capito nulla, non ha capito i principi che governano la nostra società, non ha capito che la società vuole essere imbrogliata! Dice che la trattano come se non fosse uguale agli altri? Finga di essere uno scienziato, oppure un politico… insomma se non ha quattrini da darmi, se ne vada”.
Phistis se ne andò. Così si mise a fare le cose che fanno tutti, ma le cose che vengono insegnate a scuola, cioè le ricompense per i buoni e le punizioni per i cattivi, non vennero mai. Phistis ne fu amareggiato. Avrebbe voluto gettarsi a terra e morire, ma sentiva che, se lo avesse fatto, non sarebbe morto. Inoltre aveva immaginazione; cioè un altro grave difetto. L’immaginazione è una cosa tremenda, perché fa sapere prima cosa succederà dopo, così che tutte le cose terribili della vita ne vengono amplificate. L’immaginazione fa vedere il futuro come se fosse passato e così fa rimpiangere il futuro, come se fosse una cosa già avvenuta. Ciò ingigantiva l’amarezza di Phistis.
Un giorno Phistis incontrò una leonessa molto combattiva, che però viveva in un sogno diverso. Phistis non la vide mai più, anche se ricordò sempre quell’incontro. Un giorno, finalmente, dopo una lunghissima attesa, Phistis, per la grande stanchezza della continua lotta con la vita, si addormentò e sognò la leonessa, la gatta nera, che col tempo era divenuta una donna vera, sognò Mildred, la bella bambina che amava i gatti e la sua gioia nel rivederle, dopo così tanto tempo, fu tale che si svegliò. La delusione, nel constatare che era stato solo un sogno ed il rimpianto furono così grandi, che Phistis emise un grido di disperazione. La vita, spaventata, fuggì via da lui, e la morte, che lo aveva accompagnato in ogni suo passo, lo avvolse completamente nel suo mantello.
Allora l’Angelo del Signore andò in cerca di Dio e lo trovò in giardino, che guardava l’Universo, con aria un po’ depressa. L’Angelo disse: “Signore, non lo crederai, ma al cancello c’è un puma, sì proprio un puma, che sta facendo una scenata dell’altro mondo. Dice che, secondo la nuova filosofia, ha diritto di entrare, come tutti. Dice che devo aggiornarmi, leggere i saggi dei centri di bioetica e, come se non bastasse, dice che sono un ignorante. Che devo fare?” Il Signore si divertì molto, nel suo intimo, tanto che quasi sorrise. Questo era assolutamente eccezionale; infatti Lui e Suo Figlio, nelle fotografie, sono sempre molto accigliati. Non sembrano soddisfatti di come vanno le cose. Il Signore rispose: “E’ certamente Phistis, che non ha ancora capito nulla. Finalmente è arrivato, questo bel tipo che ha detto al Dott. Rossiglione che è matto come un cavallo.” Poi, ridiventato serio, il Signore disse: “I sogni degli altri animali sono stati delusi ed interrotti troppe volte. Inoltre, qui ci sono molti come Phistis, che vogliono vederlo e moltissimi che vogliono dirgliene quattro, per le cose che ha fatto nell’altro mondo. Specialmente due maremmani, Cane Bianco e Cane Nero, il gatto Oblìo, la gatta Magìa ed un topo marrone, di cui non ricordo il nome, sono molto arrabbiati con lui. Crede forse di passarla liscia? Lascia dunque entrare gli altri animali ed anche a Phistis sia dato quel che si merita”.
puma, sì proprio un puma, che sta facendo una scenata dell’altro mondo. Dice che, secondo la nuova filosofia, ha diritto di entrare, come tutti. Dice che devo aggiornarmi, leggere i saggi dei centri di bioetica e, come se non bastasse, dice che sono un ignorante. Che devo fare?” Il Signore si divertì molto, nel suo intimo, tanto che quasi sorrise. Questo era assolutamente eccezionale; infatti Lui e Suo Figlio, nelle fotografie, sono sempre molto accigliati. Non sembrano soddisfatti di come vanno le cose. Il Signore rispose: “E’ certamente Phistis, che non ha ancora capito nulla. Finalmente è arrivato, questo bel tipo che ha detto al Dott. Rossiglione che è matto come un cavallo.” Poi, ridiventato serio, il Signore disse: “I sogni degli altri animali sono stati delusi ed interrotti troppe volte. Inoltre, qui ci sono molti come Phistis, che vogliono vederlo e moltissimi che vogliono dirgliene quattro, per le cose che ha fatto nell’altro mondo. Specialmente due maremmani, Cane Bianco e Cane Nero, il gatto Oblìo, la gatta Magìa ed un topo marrone, di cui non ricordo il nome, sono molto arrabbiati con lui. Crede forse di passarla liscia? Lascia dunque entrare gli altri animali ed anche a Phistis sia dato quel che si merita”.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Il Racconto di Domenica 3 aprile 2016
CANE BIANCO E CANE NERO
di BRUNO FEDI
 In un paese che non esiste, c’è un’università che è regolata da norme non scritte, ma reali, che non sono proprio il meglio, in fatto di logica. Fortuna che si tratta solo di immaginazione. Che succederebbe se fosse proprio la verità? Luigi Barzini dice che l’Italia, anche se piena di incompetenti, funziona, perché i competenti occupano i posti dove la competenza è indispensabile: per esempio veri piloti guidano gli aerei, veri chirurghi operano negli ospedali. Non sempre è vero. In quella università immaginaria di un paese che non esiste, quasi nessun competente occupa il posto più adatto, eppure il paese funziona, anche se male.
In un paese che non esiste, c’è un’università che è regolata da norme non scritte, ma reali, che non sono proprio il meglio, in fatto di logica. Fortuna che si tratta solo di immaginazione. Che succederebbe se fosse proprio la verità? Luigi Barzini dice che l’Italia, anche se piena di incompetenti, funziona, perché i competenti occupano i posti dove la competenza è indispensabile: per esempio veri piloti guidano gli aerei, veri chirurghi operano negli ospedali. Non sempre è vero. In quella università immaginaria di un paese che non esiste, quasi nessun competente occupa il posto più adatto, eppure il paese funziona, anche se male.
E’ curioso che, per quanto riguarda l’università di quel paese i competenti, sembra nascano sempre nelle stesse famiglie. Ce ne sono alcune che hanno cinque, dieci, o più cattedratici.
La genetica, si sa, è molto potente. C’è perfino chi ha il gene della cattedra universitaria, in quel paese immaginario. Nella facoltà di medicina e chirurgia, in un tempo non lontano, l’atmosfera era molto competitiva: gli assistenti, per far carriera, avrebbero venduto l’anima ma, in genere, vendevano o regalavano cose più concrete: per esempio, regalavano i clienti ai loro direttori. L’identificazione coi capi era totale: alcuni imparavano perfino a parlare con la “r” moscia, come il loro capo, o a camminare come “lui”. La massima aspirazione era, consapevolmente o inconsapevolmente, di imitare il megadirettore galattico. In realtà si identificavano realmente, assumevano un’aria indaffarata, sembrava che facessero continuamente cose importantissime, anche se passavano la giornata in un ozio forzato, emarginati nei corridoi. Ciò che facevano in tutta una giornata si poteva fare in due ore, ma l’esigenza di corteggiare capo e sottocapi vari esigeva la presenza continua.
L’aiuto più anziano diceva che tutti si difendevano da tutti; lui si difendeva dagli assistenti ed il professore si difendeva dagli aiuti. In realtà questa descrizione era una razionalizzazione degli atti: tendeva a giustificare il fatto che tutti aggredivano tutti, perché il fine supremo era far carriera ed ogni gradino, anche minimo, veniva superato con una dura lotta. Non avveniva nulla di ciò che ciascuno si aspettava secondo la logica ed il diritto: esempio, la valutazione degli esami secondo il merito era un’utopia. La valutazione invece avveniva secondo le raccomandazioni, come tutti sanno, anche se, talvolta, qualche promosso per raccomandazione dice che queste sono idee qualunquistiche.
 Specializzazione e docenza non erano conferite a chi dimostrava di sapere, di capire, o di saper immaginare e ricercare, bensì a chi era stato disponibile, ossequioso, sempre presente a qualunque ora: in una parola “servizievole”, come disse uno degli assistenti, divenuto poi cattedrattico per meriti “familiari”. La stessa docenza non si otteneva per caratteristiche scientifiche qualitative, bensì quantitative, cartacee, che servivano da alibi ai giudicanti, per promozioni assurde. Ma il peggio era che qualunque progresso nell’apprendimento, per quanto piccolo, nel settore della medicina, richiede una manualità; dunque, qualcuno che insegni. Invece nessuno insegnava: coloro che erano pagati per insegnare cercavano di impedire che qualunque possibile futuro concorrente imparasse, così che anche per apprendere era necessario essere protetti da una lobby, banca, personaggio, consorteria, oppure essere amici di qualcuno, possibilmente amici di tutti, perché nessuno si opponesse, anche semplicemente sparlando. Era necessario corteggiare e adulare, compreso andare a pagare il bollo della macchina del capo, o far togliere una multa. Non certo a pagarla, si badi bene: un vero capo non paga le multe, si rivolge invece ad un amico e se le fa togliere. In questo modo, si poteva ricevere qualche consiglio, qualche insegnamento o, semplicemente, non si veniva strapazzati.
Specializzazione e docenza non erano conferite a chi dimostrava di sapere, di capire, o di saper immaginare e ricercare, bensì a chi era stato disponibile, ossequioso, sempre presente a qualunque ora: in una parola “servizievole”, come disse uno degli assistenti, divenuto poi cattedrattico per meriti “familiari”. La stessa docenza non si otteneva per caratteristiche scientifiche qualitative, bensì quantitative, cartacee, che servivano da alibi ai giudicanti, per promozioni assurde. Ma il peggio era che qualunque progresso nell’apprendimento, per quanto piccolo, nel settore della medicina, richiede una manualità; dunque, qualcuno che insegni. Invece nessuno insegnava: coloro che erano pagati per insegnare cercavano di impedire che qualunque possibile futuro concorrente imparasse, così che anche per apprendere era necessario essere protetti da una lobby, banca, personaggio, consorteria, oppure essere amici di qualcuno, possibilmente amici di tutti, perché nessuno si opponesse, anche semplicemente sparlando. Era necessario corteggiare e adulare, compreso andare a pagare il bollo della macchina del capo, o far togliere una multa. Non certo a pagarla, si badi bene: un vero capo non paga le multe, si rivolge invece ad un amico e se le fa togliere. In questo modo, si poteva ricevere qualche consiglio, qualche insegnamento o, semplicemente, non si veniva strapazzati.
I casi più grotteschi credo che siano stati quelli di coloro che hanno preso in gestione qualche ex fiamma, dismessa del maestro, o hanno sposato alcune parenti strette dei grandi capi. Ciò era molto di moda qualche anno fa, fra gli assistenti di un grosso ortopedico (certo Scaglioni, primario a Firenze). C’era tutto un campionario di comportamenti assurdi, schizofrenici, grotteschi, ma sempre servili. Di uno degli assistenti di chirurgia di una grande sede universitaria si diceva, infatti, che le sue uniche pubblicazioni originali fossero quelle di matrimonio: su tutte le altre il suo nome era stato messo dal maestro, d’autorità, per meriti parentali (aveva sposato la figlia del maestro). In questa situazione, una delle maggiori conquiste era un tavolo, o un pezzo di tavolo, su cui studiare e scrivere, che si ottenevano a prezzo di sforzi sovrumani. Non parliamo poi della conquista suprema, che qualificava il vincitore come un prediletto del cielo: la conquista di una stanza. Così per un lungo periodo gli assistenti, la “truppa”, vagava nei corridoi, in piedi tutto il giorno, prima di conquistare l’agognata stanza personale.
Però, un po’ per l’identificazione col capo, un po’ per darsi un contegno, un po’ per non far vedere di essere sfaccendati, tutti tentavano di mostrare che stavano lavorando, che erano molto impegnati. Ed effettivamente lavorare era la massima aspirazione, perché lavorando si impara; inoltre è più piacevole che oziare, infine perché si può perfino conquistare un possibile cliente. I più privi di personalità adottavano semplicemente quella del capo, o di un sottocapo. Il primo elemento del successo, era identificarsi con le forme esteriori del successo. Tuttavia qualcuno non riusciva bene, in questa opera di distruzione della propria personalità originaria.
Per il cursus honorum, cioè specializzazione, docenza, posto di ruolo come assistente, aiuto, concorso a cattedra, non valevano, come già detto, le qualità positive, ma queste erano indispensabili, insieme a molte qualità negative, per chi non era protetto da un partito, una banca, o non aveva un parente in posizione chiave, nell’ufficio delle imposte. Quindi bisognava essere disponibili, sempre presenti, sempre informati su quante volte aveva urinato ciascun paziente, ma anche saper eseguire bene tutte le metodiche strumentali, necessarie per una produzione quasi scientifica.
Questo è veramente un punto dolente perché, durante l’università, si può imparare a divenire buoni medici, perfino se l’insegnamento è cattivo. Per la ricerca, invece, è importante incontrare qualche docente che ha idee di ricerca, ha dei dubbi, fa delle prove, oppure mostra agli studenti con quale procedimento mentale i grandi del passato sono arrivati alle scoperte. In questo caso, gli studenti arrivano anch’essi ad avere idee, dubbi, intuizioni e quindi riescono ad immaginare il nuovo, ciò che ancora è ignoto.
Ma anche se immaginano, non sanno ancora come fare ricerche. Se però un docente con delle idee non esiste, o nasconde ciò che pensa, è molto difficile che gli studenti immaginino qualcosa di nuovo e diventino ricercatori, partendo dal nulla. La conseguenza di tutto questo è che, nell’università immaginaria di cui parliamo, gruppi di assistenti firmino a grappolo le rare ricerche di un solo autore, quando l’occasione si presenta. L’autore è costretto ad acconsentire, perché uno dei firmatari paga le spese, un altro è un aiuto di cui è bene conquistare il favore, un altro ancora è nelle grazie del maestro ed, infine, un altro promette di far mettere la firma su un suo lavoro, in corso di stesura, etc. etc. . In poche parole, in queste situazioni, le vere ricerche sono rare e richiestissime.
Invece del voto di scambio, vige, in quel fortunato paese di cui parliamo, la regola del lavoro scientifico di scambio. Capire che cosa fare, ricercare e soprattutto come ricercare, è un problema fondamentale. Un ulteriore aspetto deplorevole, è la scelta dei cattedratici che avviene per meriti genetici, o politici, o di lobby. In realtà queste scelte dequalificano la categoria, nel paese che non esiste, mentre, questa stessa dequalificazione, porta a scegliere assistenti sempre più servili, che desiderano solo potere e denaro.
Di conseguenza, i maestri hanno una ulteriore ragione per non insegnare, perché vedono negli allievi dei possibili concorrenti e non dei collaboratori. Gli assistenti, divenuti a loro  volta direttori, perpetuano la situazione. A ciò si aggiunge che non saprebbero insegnare ciò che essi stessi non hanno potuto imparare.
volta direttori, perpetuano la situazione. A ciò si aggiunge che non saprebbero insegnare ciò che essi stessi non hanno potuto imparare.
Una miniera di spunti di ricerca, di occasioni di studio, è il reparto clinico, oppure la sala operatoria ma, in genere, è il maestro stesso che scrive sui lavori degli assistenti quanti sono stati i casi e quali sono stati i risultati (quasi sempre ottimi, si capisce: talvolta viene il dubbio che le tecniche usate siano così buone da far bene anche ai sani). Tuttavia bisogna ammettere che anche le briciole, che rimangono agli assistenti, per chi ha qualcosa in testa, sono abbastanza. Certo c’è una certa difficoltà di arrivare ad immaginare, a sapere e, finalmente, a saper fare, specialmente se coloro che sono pagati per questi compiti, in realtà, fanno il contrario. Però c’è sempre l’opportunità della medicina sperimentale: questa apre prospettive immense, specialmente per coloro a cui non si insegna, è quindi per coloro cui si rende difficile apprendere sull’uomo: in quel paese inesistente, in quella facoltà di medicina onirica, ci sono persone a cui, dopo anni, non si permette di mettere un punto di sutura cutaneo. Ma nel campo sperimentale tutti possono tentare qualunque intervento: anche un trapianto cardiaco.
Si capisce dunque come esistano persone che hanno l’ambizione di salire e di colmare le lacune della loro preparazione, di cui hanno colpa i loro maestri ed i politici, che permettono tutto questo.
Queste persone ambiziose logicamente spinte dall’esempio dei loro predecessori, dall’opinione pubblica favorevole, dalla mancanza o dalla lacunosità delle leggi, dai controlli inesistenti, dall’approvazione dell’ambiente in cui vivono, dal desiderio di dimostrare che cosa valgono, non hanno motivi per non dedicarsi con entusiasmo alla sperimentazione. Questo dunque anche se le condizioni d’igiene, l’anestesia, la cura degli oggetti di sperimentazione, sono carenti, per non dire inesistenti. Chi vale poco, si cura poco di questo, ma soprattutto non riesce ad immaginare esperimenti scientificamente sensati. Così vengono ripetuti esperimenti già fatti migliaia di volte e già dimostratisi inutili; vengono fatti esperimenti privi di senso, oppure con scopi futili, oppure con metodiche che implicano enormi sofferenze, oppure esperimenti facilmente sostituibili con metodiche prive di crudeltà. Fortunatamente, questo paese e questi fatti sono tutti inventati. Quasi sempre, a fine sperimentazione, si ricorre al miracolo (fortunatamente!), cioè alla moltiplicazione dei casi.
I casi sperimentali, da tre che erano, diventano 43, o 57, o altro. Quasi sempre gli animali vengono male assistiti, dopo gli esperimenti: mancano le cure più elementari, la pulizia, l’alimentazione, etc. Ma quelli che, almeno in parte, ricevono assistenza, sono i casi più dolorosi. Lo sperimentatore vuol sapere davvero quali sono stati i risultati e così, quando un animale è passato attraverso la tortura e si è miracolosamente ripreso, c’è il reintervento, per accertare gli esiti, oppure si decide che l’animale è ancora vitale e quindi è buono per un’altra esperienza, avente come scopo ultimo la carriera e la gloria dello sperimentatore. Purtroppo, da questa infinita serie di atti insensati ed incontrollati viene fuori anche qualche notizia od osservazione positiva e queste notizie, o osservazioni, vengono usate per giustificare il tutto. Lo stesso accade per la formazione dei ricercatori: nonostante tutto, qualche buon cervello riesce a sopravvivere e a manifestarsi. Ciò viene usato come prova che il sistema è efficiente.
E’ più o meno come dire che l’immane macello delle guerre è utile, perché le innovazioni tecnologiche in guerra procedono con grande velocità. Ciò è vero, ma non giustifica la crudeltà, la mancanza di rispetto delle più elementari leggi.
Inoltre, non tutto ciò che è utile è anche morale, ma soprattutto non si può prendere come esempio un’osservazione utile per giustificare ciò che è avvenuto e chiedere a gran voce la mancanza di controlli in nome della libertà di ricerca, che diventa così arbitrio di ricerca. Solo uno stolto può fare questo, ma in quel paese immaginario di cui parliamo gli stolti non mancano. Tanto meno si può giustificare una metodica nel suo complesso, o giustificare il tutto, attraverso una sua parte, attraverso un particolare. Un particolare utile non può giustificare un principio generale, mentre un solo particolare può essere sufficiente per negare la correttezza scientifica di un principio generale.
In questa situazione, l’atteggiamento mentale competitivo, la ricerca del successo ad ogni costo, la necessità di imparare, la mancanza di leggi e controlli, le idee ormai acquisite dall’opinione pubblica (che vede nei ricercatori dei superuomini a cui tutto è lecito), la mancanza di cultura, di conoscenza su come fare altrimenti, i cattivi maestri che non insegnano, tollerano, indirizzano e in pratica spingono ad agire male, la cultura antropocentrica che legittima l’uso da parte dell’uomo degli altri viventi, sono tutti fattori che spingono i ricercatori a divenire cattivi ricercatori, cattivi medici e cattivi uomini.
In questo tipo di paese, in questo ambiente, gli uomini sono ossessionati dall’idea di riuscire, di sopraffare altri uomini, di essere riconosciuti come dominatori; sono ossessionati dall’idea di avere di più, accumulare ricchezze che servono ad acquistare oggetti per lo più inutili, ma che dimostrano a tutti quanto grande sia la ricchezza posseduta.
 Per questi nobili fini, gli uomini sono disposti ad essere succubi di altri, magari fino ad età più che matura; sono disposti ad essere ossequiosi, ruffiani, a corteggiare chi conta e a sfogare le proprie frustrazioni su chi non conta, o addirittura su chi non ha neppure la parola per difendersi; gli uomini sono disposti a qualunque miseria o crudeltà su chi non si può difendere. Questa è la filosofia immorale che si esprime nel concetto comunemente accettato, nel paese cha non c’è: “II fine giustifica i mezzi”. Ciò significa accettare l’utilitarismo come criterio di comportamento, ciò significa approfittare dell’opinione comune e ammantarsi del nobile ideale di servire gli altri per giustificare ogni iniquità. Chi vive in questi ambienti non sente minimamente l’orrore di ciò che fa. Alla fine di questa carriera, alcuni di coloro che si sono sempre prostituiti vengono premiati: per altri, non meno negativamente meritevoli, invece, c’è poco, ma il riconoscimento da parte dell’opinione pubblica c’è per tutti. L’eredità accademica tocca ad alcuni che, senza che gli altri lo sapessero, erano protetti da lobbies, oppure a coloro che hanno dimostrato di essere così poco intelligenti che i loro maestri, andandosene in pensione, pensano che anche mettendoli sul trono essi rimarranno, psicologicamente, per sempre dipendenti da loro. Invece quasi sempre avviene, in questa immaginaria università, un altro miracolo. Quando si fa in modo che un concorso a cattedra sia vinto dal più cretino, ignorante e soprattutto succube fra gli assistenti, l’assistente sorride, si inchina, dice “sì signore” e siede in cattedra. In quel momento avviene il miracolo: il primo ordine che l’assistente, divenuto direttore, impartisce, è quello di far fuori il vecchio maestro, che si aspettava, invece, sottomissione e riconoscenza eterna.
Per questi nobili fini, gli uomini sono disposti ad essere succubi di altri, magari fino ad età più che matura; sono disposti ad essere ossequiosi, ruffiani, a corteggiare chi conta e a sfogare le proprie frustrazioni su chi non conta, o addirittura su chi non ha neppure la parola per difendersi; gli uomini sono disposti a qualunque miseria o crudeltà su chi non si può difendere. Questa è la filosofia immorale che si esprime nel concetto comunemente accettato, nel paese cha non c’è: “II fine giustifica i mezzi”. Ciò significa accettare l’utilitarismo come criterio di comportamento, ciò significa approfittare dell’opinione comune e ammantarsi del nobile ideale di servire gli altri per giustificare ogni iniquità. Chi vive in questi ambienti non sente minimamente l’orrore di ciò che fa. Alla fine di questa carriera, alcuni di coloro che si sono sempre prostituiti vengono premiati: per altri, non meno negativamente meritevoli, invece, c’è poco, ma il riconoscimento da parte dell’opinione pubblica c’è per tutti. L’eredità accademica tocca ad alcuni che, senza che gli altri lo sapessero, erano protetti da lobbies, oppure a coloro che hanno dimostrato di essere così poco intelligenti che i loro maestri, andandosene in pensione, pensano che anche mettendoli sul trono essi rimarranno, psicologicamente, per sempre dipendenti da loro. Invece quasi sempre avviene, in questa immaginaria università, un altro miracolo. Quando si fa in modo che un concorso a cattedra sia vinto dal più cretino, ignorante e soprattutto succube fra gli assistenti, l’assistente sorride, si inchina, dice “sì signore” e siede in cattedra. In quel momento avviene il miracolo: il primo ordine che l’assistente, divenuto direttore, impartisce, è quello di far fuori il vecchio maestro, che si aspettava, invece, sottomissione e riconoscenza eterna.
Il caso più emblematico è quello di un vecchio cattedratico “aggiusta-ossa” romano, che lasciò lo studio, dopo il concorso a cattedra, in cui aveva imposto, come proprio successore, il suo assistente. Il “maestro” fu salutato con inchini dai suoi discepoli, fra cui il nuovo cattedratico. Era tacitamente inteso che il vecchio professore sarebbe tornato la mattina dopo e tutto sarebbe continuato come prima. La mattina dopo il vecchio professore trovò chiuse le porte della direzione ed il portiere, un po’ imbarazzato, gli disse: “Professore… il Professore ha dato ordine di non farvi entrare…”.
In questo ambiente celestiale, di quell’università che non esiste, la malasorte condusse un giorno due poveri senza nome, smarriti, o abbandonati dalle crudeltà dei loro ex padroni.
Mi dissero che Cane Nero era stato comprato da un pastore e portato in clinica. Ma questo è impossibile: non ci sono pastori, in quella città di quel paese inesistente. Era certo un cane abbandonato, randagio, ma malgrado che nessuno potesse reclamarlo, si sentiva il bisogno di nascondere la verità. I vivisettori sentivano che c’era qualcosa di vergognoso perfino per la sensibilità di allora, e di illegittimo perfino per la giurisprudenza di allora, nell’usare i randagi per la pseudo-ricerca.
Lo stabulario era sul tetto dell’istituto, in una specie di soffitta in cui la temperatura era fredda d’inverno, ma d’estate il calore era semplicemente terrificante. Cane Nero era un grande cane col pelo a ciocche: sembrava un pastore belga di grossa taglia, forse un incrocio fra pastore belga e maremmano.
Io capitai per caso nella stanza dove alcuni predestinati a una grande carriera accademica stavano effettuando un esperimento; mi sembra si trattasse di un’anastomosi vasale reno-lienale per studiare l’effetto dell’ipertensione indotta su organi sottoposti ad una notevole variazione di flusso ematico. Franco il bello, infermiere, così chiamato per distinguerlo da Franco il brutto, praticava l’anestesia con una siringa di Pentothal.
L’intervento fu lungo: le suture vasali richiedono molto tempo, ma riuscì perfettamente. Il cane soffrì molto, prima per la preparazione, quando fu legato al rozzo tavolo operatorio. Il cane non capiva, ma sentiva che qualcosa di terribile stava per accadere e tremava come una foglia. Poi soffrì durante l’intervento: l’anestesia di Franco il bello era approssimativa, come si intuisce facilmente. Poi certo soffrì quando si risvegliò sul nudo pavimento, ferito e senza gli analgesici che si danno agli uomini. Gli uomini, però, sono forniti anche dell’analgesico più potente che esista, per sopportare meglio il dolore: la motivazione. Gli uomini sanno di essere stati operati per il loro bene e di sentir dolore perché un calcolo, un tumore, o un’ulcera sono stati asportati. Un cane non sa tutto questo: sente solo di venir tagliato con un coltello, anche nei visceri; non capisce, è attanagliato dal dolore e dal terrore che amplifica il dolore.
Io andai a trovare Cane Nero alcune volte, mentre lui si schiacciava tremando di paura sul pavimento. Controllavo che avesse almeno acqua e cibo. Sfortunatamente Cane Nero guarì: adesso aveva meno paura di me. Un giorno seppi che lo stavano rioperando; andai nella stanza degli esperimenti: il cane era già legato la tavolo. Mi guardava, non so dire come. Mentre mi guardava cominciò a piangere. Dagli occhi cadevano in silenzio le lacrime. Non avevo mai visto, non sapevo che un cane potesse piangere. Le lacrime di Cane Nero erano peggio di quanto avessi mai visto. Era la paura di un essere intelligente, capace di sentimento, ridotto ad una cosa, privato della speranza. Erano le lacrime di un uomo mascherato in un corpo di cane che chiede aiuto e pietà, che si domanda perché questa enorme crudeltà, di essere sezionato fino alla morte.
Questa è una situazione forse peggiore di quella degli uomini fatti schiavi e di quella degli uomini trasformati in cose nei lager tedeschi o russi, privati di diritti, senza possibilità di chiedere perché ai loro aguzzini. Gli uomini, anche in queste condizioni, capiscono che cosa è avvenuto e che cosa può avvenire nel futuro; mettono in atto piccoli sotterfugi, scambiano mezza razione di pane con una razione di zuppa, riescono ad indurre alla pietà, rubano, si fingono ammalati. Il cane non capisce per quale ragione chi lo ha amato e nutrito, lo abbia abbandonato e perché altri lo stiano sezionando. Il cane non sa se e quando si fermeranno, non può sperare, non può fuggire in un mondo amico e più giusto, perché tutt’intorno c’è solo il mondo degli uomini. Non si può neppure aiutarlo a fuggire. L’animale da esperimento non può sperare.
Fortunatamente Cane Nero morì durante l’intervento.
Dopo pochi giorni fu portato un secondo cane. Questo era un grande maremmano festoso. Non aveva capito che cosa lo aspettava. Anche lui fu messo sul tavolo operatorio, legato in una posizione innaturale e dolorosa. Anche a lui fu rasato il pelo sul ventre e anche lui fu spinto nell’incoscienza dal Pentothal.
Nell’operazione qualcosa andava storto, le cose andavano per le lunghe. Mentre gli operatori si arrabattavano sacramentando e imprecando, Franco il bello, ogni tanto, iniettava un po’ di anestetico. Guardavo fisso Franco, poi guardavo la siringa di riserva, già piena di venti centimetri cubi di Penthotal. In un momento in cui Franco mi guardava, feci il gesto di chi schiaccia rapidamente il pistone di una siringa. Senza una parola, senza fretta, Franco il bello sostituì la siringa quasi vuota con quella piena ed iniettò di colpo i venti centimetri cubi. Trascorse mezzo minuto in cui il cuore mi batteva all’impazzata. Poi qualcuno disse: “Ma questo cane non respira…”. Uno alla volta tutti si rialzarono. Franco disse con aria stolida ed indifferente: “Allora posso andare, Professore?”. Tutti se ne andarono. A Franco dissi seccamente: “Bravo”.
Dopo un po’ tornai per fare una stupida carezza al cane e per chiedere un inutile perdono di ciò che avevo fatto.
Ma il cane non c’era più. Allora andai nel sotterraneo del bruciatore, sotto l’enorme ciminiera che domina tutto il Policlinico. L’impianto era vecchio, progettato e costruito come si faceva quasi un secolo fa. C’era una stanza con una botola centrale in cui si potevano gettare oggetti da bruciare nella camera sottostante rivestita da materiale refrattario, resistente al fuoco. Là, sotto la botola, c’era il corpo del povero Cane Bianco e vicino a lui bruciavano due piccoli fuochi.
Ancora mi sembra impossibile di aver visto queste cose realmente. Forse è stato un incubo che mi ricorda simbolicamente tutti gli altri esseri senza nome e senza storia, uccisi per futili motivi, per la fatuità di assistenti ambiziosi ed aridi.
Essi sono stati schiavi, sottoposti all’arbitrio di un qualunque insensibile arrampicatore della scala delle vanità accademiche, o di qualunque individuo senza scrupoli che abbia voluto produrre, vendere, arricchirsi, alzare il prezzo di vendita dei farmaci ed abbia avuto bisogno di un alibi per il suo nobile scopo.
Non possiamo dimenticarli e dichiararci estranei alla loro tragedia. Non sono morti per una legge naturale, ma per comportamenti dell’uomo che sono assurdi anche se da tutti accettati. La crudeltà e l’errore rimangono crudeltà ed errore, anche se commessi all’unanimità.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Racconto della Domenica di Pasqua 2016
di BRUNO FEDI
Ariman coltivava un po’ di ortaggi presso la sua capanna, ma la sua principale attività era sempre stata la caccia.
I boschi erano pieni di animali ed egli era stato educato a cacciare. Gli avevano raccontato tante storie di caccia: sembrava che fosse sempre stato così. Le generazioni precedenti alla sua erano state veramente barbare. Molti erano pagani, credevano negli dèi dei boschi, adoravano rozze pietre e druidi che vivevano presso grossi macigni sulla Horse Hill. Essi sapevano tutto. Sapevano predire il futuro e guarire dai malefici; adesso, però, uomini venuti dal mare avevano portato la notizia di un nuovo grande Dio. Essi lo avevano commosso e gli avevano versato acqua sul capo. Questi uomini, protetti dal loro Dio, non temevano nulla: avevano parlato direttamente al suo signore e lo avevano fatto addirittura inginocchiare. Anche a lui avevano versato acqua sul capo. Con loro erano arrivati nuovi costumi: avevano obbligato tutti a lavorare per costruire una chiesa di pietra e attorno a quella erano state costruite alcune abitazioni di legno e pietre. Si produceva più orzo e quindi più cibo e più birra. C’era tanta più luce e tutti quei rami resinosi accesi mettevano allegria: le notti, così, erano più calde, mentre il vento fra gli alberi produceva un rumore come le onde del mare sulla spiaggia e nel cielo galoppavano le nonne grigie.
C’era stato un altro grande cambiamento: ai tempi di suo padre, quando egli era giovane, la legge era la parola del signore. Non essere rapidi ad obbedire significava prendere un colpo di frusta; non obbedire affatto, significava prendere un colpo con l’ascia, o venire impiccati.
Bastava aver bevuto, senza permesso, nel ruscello che passava per le terre del signore o, peggio di tutto, aver cacciato uno dei suoi animali. Per fortuna c’erano foreste in ogni direzione e quindi c’era legna per il fuoco e animali dappertutto.
Egli ricordava quando era stata chiamato ed era andato nel cortile del signore, insieme con tutti gli altri dei dintorni.
Erano più di cento, avevano i loro archi ed il signore aveva dato loro lance e scudi. Poi erano andati di là dal mare, dove avevano bruciato e distrutto città quasi completamente di pietra. Alcune erano grandissime: potevano contenere più di diecimila persone. Era stata una bella vita, in un paese molto meno freddo ed umido del suo, dove sarebbe stato bello vivere per sempre. Aveva visto il mondo: l’Armorica, l’Aquitania, la Borgogna.
Col passare del tempo, si era domandato se la vita fosse solo un seguito di battaglie, di tentativi di uccidere, o sfuggire alla morte, mangiare e dormire. Il fumo degli incendi di città e villaggi ed il sangue dei massacri che sempre ne seguivano, lentamente lo avevano disgustato.
Avevano dato e ricevuto ferite e sofferenze, ma, quando era tornato nella sua terra, il signore lo aveva compensato con una capanna nel bosco. Ma tutto era cambiato.
Adesso si poteva chiedere giustizia a frate Dunstano, che, protetto com’era da Dio stesso, non aveva paura di nessuno. Oppure si poteva andare in una città lontana e chiedere giustizia al re, ma non era una buona decisione. Alcuni avevano avuto giustizia; altri, chissà perché, non erano più tornati.
Il miglioramento, però, era evidente; anche i prepotenti avevano sopra di loro uno più prepotente ancora, capace di condannarli a morte e sopra tutti c’era Dio. La gente non viveva più in capanne di legno isolate senza incontrarsi mai, se non in guerra: c’era un luogo di riunione e di protezione: la loro chiesa.
Lui e la sua donna erano stati sposati dall’uomo di Dio. Prima di partire per la guerra, egli si era innamorato di lei, nonostante non avesse niente da donare, né a lei stessa, né al padre di lei.
 L’uomo di Dio li aveva benedetti ed aveva detto che nessuno, neppure il signore, neppure il re, poteva sciogliere, la loro unione. Anni dopo, tornato dalla guerra, l’aveva ritrovata un po’ diversa, ma il loro legame era eterno. Così aveva detto l’uomo di Dio. Si diceva che frate Dunstano sapesse tutto, perfino leggere e scrivere. Certo aveva fatto per lui una cosa che prima non sarebbe stata possibile: infatti né il padre della ragazza, né il signore, dopo il matrimonio, avevano osato protestare.
L’uomo di Dio li aveva benedetti ed aveva detto che nessuno, neppure il signore, neppure il re, poteva sciogliere, la loro unione. Anni dopo, tornato dalla guerra, l’aveva ritrovata un po’ diversa, ma il loro legame era eterno. Così aveva detto l’uomo di Dio. Si diceva che frate Dunstano sapesse tutto, perfino leggere e scrivere. Certo aveva fatto per lui una cosa che prima non sarebbe stata possibile: infatti né il padre della ragazza, né il signore, dopo il matrimonio, avevano osato protestare.
Egli, durante le guerre, aveva imparato a battere il ferro e farne punte di frecce. Capiva perfino un po’ il linguaggio degli stranieri. Da quando era tornato dalle guerre, sentiva ripugnanza ad uccidere, non solo esseri umani, ma tutti, anche gli animali.
Talvolta, si domandava come quel frate così buono, che mangiava solo frutta e vegetali, che beveva solo acqua della sorgente, che aveva parlato di un Dio che aveva tutto e che era solo amore, potesse benedire coloro che andavano in guerra, approvare, o almeno così pareva, le esecuzioni ordinate dal signore, oppure permettere che, nelle grandi festività, si uccidessero perfino i piccoli degli animali per mangiarli, semplicemente perché più teneri e più saporiti. Il frate veramente, non li mangiava, li donava ad altri, ma permetteva le uccisioni. Ariman sapeva che perfino le creature selvagge rispettano i piccoli: egli aveva visto con i propri occhi dei grossi cani evitare di mordere i gattini e, talvolta, una cagna allattare un gattino perduto. C’era qualcosa di sbagliato in ciò che il frate diceva, o in ciò che faceva.
Lui, Ariman, adesso coltivava fagioli e verdure. Aveva scoperto, con sorpresa, di non sentirsi affatto più debole. Del resto aveva visto in guerra i combattenti di popoli che non mangiavano carne: non erano né più deboli, né più paurosi.
Negli anni delle guerre, non aveva potuto possedere un cane, o un cavallo, ma adesso poteva. Un grosso gatto dei boschi con le zampe palmate, si era avvicinato alla casa ed egli non lo aveva scacciato. Il gatto lo guardava con aria impassibile, o vagamente interrogativa, mentre egli lavorava. Un giorno, improvvisamente, il gatto aveva detto: “Com’è che gli uomini uccidono anche animali che non possono mangiare, uccidono quando non hanno fame, uccidono senza necessità, si uccidono perfino fra loro ed uccidono anche coloro che si sono arresi?”. E poi: “Vi siete abituati a queste mostruosità. Altre ancora ne commetterete in futuro, perché vi sembreranno utili. Vi abituate a ciò che è assurdo e mostruoso, così come vi abituate a qualunque cosa sia stata ripetuta abbastanza a lungo. Con la stessa facilità vi abituate all’ingiustizia delle leggi e alla povertà della vostra vita”.
Lui stava spaccando la legna ed aveva sentito quelle parole quasi come se fossero un suo pensiero, poi si era reso conto di avere sentito davvero e non sognato. Aveva guardato il gatto ed aveva soltanto saputo rispondere: “Non lo so. Facciamo male, abbiamo torto”. Ma il gatto non aveva più parlato. Egli aveva pensato: “Anche i gatti stanno diventando civili”. Il gatto stava accovacciato presso la casa, osservandolo pazientemente.
Aveva un’aria distaccata, ma non ostile. Ariman lo aveva chiamato Tom, come il suo ultimo figlio, che era andato a combattere in un paese del sud, caldo e ricchissimo, di cui egli aveva sentito parlare, ma che credeva, in realtà, una favola.
Si diceva che in quel paese, chiamato Italia, non ci fossero mai le nuvole e si potesse addirittura dormire sotto le stelle, all’aperto.
Talvolta Ariman si sentiva singolarmente in pace: aveva commesso molti errori, iniquità e peccati, ma era stato spinto dal fatto che tutti volevano così e, del resto, il frate lo aveva assolto da ogni peccato. Ora rispettava la legge naturale, la legge della vita: né uccideva né commetteva alcuna sopraffazione. Invecchiava solo nella foresta con la sua donna, col suo gatto, ripensando al passato, fantasticando sul futuro. Pensava ad una ruota che, girando, attingesse l’acqua dal ruscello, o muovesse una pietra per macinare, o addirittura facesse girare un fuso per filare. Talvolta ne parlava con la sua donna, che lo ascoltava un po’ meravigliata del suo ingegno. La sua donna era stata la vera compagna della sua vita. Ariman ripensava, talvolta, alla bellezza di lei e si sentiva stranamente commosso, anche ora che lei era diversa. Lei aveva contribuito molto anche al cambiamento di lui. Era con lei che aveva parlato, nelle lunghe sere degli inverni nevosi di quel gelido paese. Parlando con lei era stato come se la sua bellezza e la gioventù che lo avevano affascinato, tanti anni prima, esistessero ancora.
Era stata lei che per prima si era avvicinata a frate Dunstano ed, attraverso lui, agli uomini di Dio.
Essi avevano dato la spiegazione di tutto e gli avevano portato una cosa che, anche se non si poteva vedere o toccare, era la più grande e la più importante: la speranza. Essi avevano spiegato come Dio avesse creato tutto e come avrebbe ricompensato i buoni. La vita non era dunque un breve attimo in cui si uccide, finché si viene uccisi, o si generano figli che poi si allontanano, spesso per sempre. Tutti avrebbero vissuto in eterno; sarebbero risuscitati dopo la morte. Ariman sapeva ora che avrebbe rivisto i suoi genitori ed i figli partiti e non più tornati. Ma il messaggio portato da Dunstano significava che non si dovevano più bruciare le case ed uccidere i nemici: significava che c’era un re più grande, al di sopra del loro re, che dava sempre la giusta sentenza e non condannava mai alla morte, o alla tortura.
Ariman pensava che gli uomini ed anche gli animali non avrebbero dovuto essere uccisi. Gli animali, poi, non avevano colpa alcuna, non si poteva neppure dire che erano dei nemici.
 Invece alcuni uomini, che pure erano stati battezzati come lui, trattavano gli animali con crudeltà. Gli animali erano così belli, così dignitosi, non tradivano mai e la loro bellezza continuava anche quando erano vecchi. Pensava che anche gli animali uccidono, ma lo fanno per necessità, non per piacere, o per il buon sapore della carne arrostita. Non hanno l’ipocrisia di affermare che lo fanno per rispettare leggi antiche promulgate da un Dio, o per punire veri o presunti colpevoli. Rispettano semplici leggi naturali di sopravvivenza, con cui la legge degli uomini deve accordarsi e non già il contrario.
Invece alcuni uomini, che pure erano stati battezzati come lui, trattavano gli animali con crudeltà. Gli animali erano così belli, così dignitosi, non tradivano mai e la loro bellezza continuava anche quando erano vecchi. Pensava che anche gli animali uccidono, ma lo fanno per necessità, non per piacere, o per il buon sapore della carne arrostita. Non hanno l’ipocrisia di affermare che lo fanno per rispettare leggi antiche promulgate da un Dio, o per punire veri o presunti colpevoli. Rispettano semplici leggi naturali di sopravvivenza, con cui la legge degli uomini deve accordarsi e non già il contrario.
Anche la sua donna amava gli animali, ma non aveva l’ingenua sicurezza di Ariman. La sua donna aveva un grande difetto: era intelligente. La sera accendeva il lucignolo di un lumino ad olio, guardava il crocefisso di legno scuro sopra la porta e talvolta pensava: “Dio mio, se Cristo non è risorto dai morti, che senso ha tutto questo?”.
Una sera tirava vento e il gatto correva intorno alla casa eccitato, giocando col vento. Improvvisamente il vento lo sollevò e lo precipitò entro la porta. Il gatto disse: “La resurrezione è il ritorno al tutto. I tuoi atomi, che sono gli stessi che furono creati all’inizio del tempo, torneranno a far parte del principio creatore. L’amore che sempre ha bruciato in te, ti riporterà al creatore di tutti”. Altre volte la donna pensava: “Gesù è certamente risorto: io sento affetto per lui, così diverso da tutti gli altri, certamente perché Egli era figlio di Dio. Infatti Egli sapeva ciò che sarebbe avvenuto, perché disse ‘Beati coloro che hanno visto e hanno creduto, ma più beati coloro che non hanno visto e crederanno’. Certo il nostro bisogno di Dio rappresenta il nostro bisogno di amore, di giustizia, di sicurezza. La grandezza di Dio è tale che Egli non potrà dimenticare nessuno, neppure il più derelitto, neppure Tom Cat e tutti coloro che soffrono e di cui io sono così consapevole, neppure gli animali selvaggi della foresta, o le creature del mare”.
Il gatto Tom la guardava come se avesse capito, ed il lumicino ad olio sembrava risplendere più chiaramente.
———————————————————————————————————————————————————–
Il racconto di domenica 20 marzo 2016
MONSIGNORE
un racconto di Bruno Fedi
Monsignore capitò in giardino per caso, o forse guidato dall’istinto. Sicuramente mi aveva visto passare nei giardini di Villa Palma, o aveva sentito i rumori di discussioni con morsi e zampate che, in certi periodi, sono frequenti. In quel tempo, una mia amica, Magìa, che era una seduttrice nata, una vera vamp, era giovanissima. Era lei una delle principali suscitatrici di gelosie fra noi.
Monsignore era enorme, anche se era molto giovane; un bambinone con una forza spaventosa e una timidezza altrettanto grande.
Ad ogni minimo rumore si fermava e si ritraeva spaventato. Camminava in modo strano, con un’andatura di spalle, un po’ come fanno gli atleti, o anche i leoni, che ho visto qualche volta in televisione. Io avevo l’impressione che Monsignore fosse più grande di un leone. O forse no: dallo schermo televisivo non si capisce quanto un leone possa essere grosso, ma certamente il leone è più piccolo dell’apparecchio televisivo che lo contiene, quindi, non è molto grosso. Monsignore aveva un gran testone ed una corona di peli tutt’intorno, che gli formava una specie di criniera biondo rossastra.
Non sapeva parlare la nostra lingua ed anche la voce era stentata e un po’ sgradevole: aveva un tono lamentoso, come se chiedesse sempre qualcosa. Seppi più tardi che la razza Maine-Coon ha questa caratteristica. I Maine-Coon parlano un loro dialetto. Monsignore era così ignorante che non sapeva neppure come si chiamava. Seppi poi che aveva avuto molte disgrazie: intanto era illegittimo, come quasi tutti. Era nato a Roma, in Via della Conciliazione. Il padre aveva un palazzo molto lussuoso, ma era terribilmente fatuo e superficiale. Aveva molte relazioni sentimentali contemporaneamente e molti figli illegittimi. Non si preoccupava affatto (cosa comune a molti padri, purtroppo) dei figli illegittimi: figurarsi che gli era perfino capitato di incontrarne alcuni, per caso e di salutarli senza riconoscerli.
Del resto, anche se li avesse riconosciuti, non gli sarebbe importato molto. Certo Monsignore era stato messo sulla cattiva strada dall’ambiente, dalle compagnie discutibili. Frequentava uomini sempre un po’ tristi, tutti vestiti di nero o talora vestiti di grigio; spesso con una certa benevolenza dei modi che, però, non davano mai l’elemosina, non davano da mangiare agli affamati e da bere agli assetati, come è prescritto. Questi uomini erano tanto strani davvero. Nella zona dove Monsignore era nato, ce n’erano moltissimi. Essi sembravano riconoscersi, incontrandosi. Qualcuno si inchinava di fronte ad un altro, addirittura di fronte a quelli più piccoli e più vecchi. Sembrava che fra loro esistesse una gerarchia inversa a quella esistente fra noi. Sicuramente si scambiavano qualche segno, come facciamo anche noi e come fanno quasi tutti gli animali. Oppure avevano segni impercettibili di distinzione; per esempio i cappelli erano talora un po’ diversi, oppure i calzini erano diversi. Qualcuno li aveva addirittura rossi: stonavano con quei vestiti neri. Questi uomini vivevano in un mondo regolato da leggi rigorosamente non rispettate dai potenti, ma applicate a tutti gli altri. I popoli, le razze, le specie più deboli erano lasciate morire di stenti e sfruttate dai più ricchi. Questi morivano per il troppo cibo, mentre gli altri morivano di fame. La bellezza, la varietà, la ricchezza delle specie e della natura intera, venivano distrutti per farne mobili, gioielli, strade. Gli animali erano protetti e rispettati a parole, ma venivano scuoiati per le pellicce, abbandonati, se costituivano una momentanea difficoltà, uccisi in appositi ammazzatoi, detti mattatoi, solo per il sapore della loro carne. Tutto il sistema serviva a giustificare la raccolta e la spesa di grandi somme di denaro, oppure per far carriera.
Comunque, Monsignore aveva al suo servizio alcuni di questi uomini neri ed uno di quelli con i calzini rossi abitava addirittura con lui. Tutti però lo trattavano male: non c’era quasi mai da mangiare decentemente; mai, dove Monsignore dormiva, era pulito. Oggi non c’è rispetto; la servitù non è più quella di una volta. Non c’è più religione. Il servitore di Monsignore, con i calzini rossi, aveva modi accondiscendenti, ma intimamente era un duro. La sua bonomia nascondeva la presunzione di sapere di più degli altri, la volontà di dominare nascosta sotto un paludamento intellettuale. Aveva una serie di regole e regolette da rispettare, che non hanno molto a che fare con la dottrina di amore e uguaglianza, fratellanza, libertà, a cui si ispirava. Aveva regole per tutto: specialmente per il comportamento sessuale, per il quale era particolarmente intollerante, mentre io e i miei amici siamo tollerantissimi. Aveva pregiudizi contro le femmine che noi non abbiamo; figuratevi che disapprovava l’aborto, che del resto noi non pratichiamo affatto, ma non la pena di morte.
Certe persone sono proprio incomprensibili: parlano di amore e di solidarietà ed intanto ci uccidono i figli. Ma la cosa più incredibile era che questo servitore non si rendeva conto del problema demografico. Egli non capiva assolutamente che si devono impedire le nascite indiscriminate, oppure la necessità di sterilizzare almeno metà della popolazione, altrimenti la crescita demografica inevitabile costringe a periodiche stragi e crea uno stato di anarchia, in cui nessuna regola e nessuna legge riesce a mettere ordine.
La crescita demografica è sufficiente per vanificare ogni piano che tenti di migliorare le condizioni di vita, la nutrizione, l’igiene, gli alloggi. Eppure questo servitore si ostinava a voler controllare il sesso, ma non la procreazione irresponsabile, che condanna interi gruppi alla miseria, a condizioni di vita che sono una sofferenza continua; tutto per rispettare principi che sono pure astrazioni. E’ ovvio che, se in questo paese possono essere nutriti dieci milioni di individui, non se ne possono generare venti milioni. Si condannano i dieci milioni in più alla sofferenza e alla morte.
Una sera Monsignore era rimasto chiuso fuori casa ed i servitori fingevano di non sentire i suoi richiami. Passò un tale che, vedendolo in quella situazione imbarazzante, ebbe un po’ di compassione e lo invitò ad andare a Terni, in gita da un parente. Monsignore accettò. La gentilezza del suo ospite lo conquistò.
Monsignore abbandonò senza rimpianto il palazzo di Via della Conciliazione e la città eterna. Il problema vero era, per lui, la lingua. Nessuno parlava la sua lingua e siccome sua madre, altrettanto sciagurata quanto suo padre, lo aveva abbandonato da piccolo, egli non aveva imparato a parlare la lingua locale, che è stranissima: figuratevi, a Terni l’asino, si chiama “lu somaru”.
Diventò comunque un gentlecat di campagna. Passeggiava per colline dove nella preistoria c’erano stati orsi, rinoceronti, elefanti, ma era sempre solo, non parlava con nessuno e soffriva un po’; si sentiva straniero.
Una sera, mentre passeggiava, la finestra di una casa si aprì e la luce lo illuminò in pieno; lo ed il mio servitore ci affacciammo alla finestra e lo chiamammo, ma Monsignore aveva troppa paura e fuggì.
Tuttavia nei giorni successivi Monsignore tornò; il mio servitore lo chiamava e Monsignore, visto che non c’era pericolo, non se ne andava più. Una sera ci fu un’offerta di cibo, che Monsignore non aveva mai assaggiato e che gli sembrò una vera squisitezza. Il mio servitore chiama questo piatto col nome di “croccantini”. Monsignore permise al mio servitore di invitarlo nella mia casa e di presentarlo. La casa, il giardino, il cibo, furono messi a sua disposizione. Gli fu preparata una stanza privata, imbottita e calda, solo per lui. Dopo un po’, constatando che era senza nome e che non si sapeva come si chiamasse, il mio servitore lo battezzò Monsignore, per quella sua aria cardinalizia e per la sua pelliccia rossa. La nuova situazione aveva per Monsignore alcuni vantaggi: il mio servitore non si cura dell’orario dei pasti, non pretende entrata e uscita ad ora fissa, lascia che gli ospiti vadano e vengano. Inoltre trova sempre qualcosa da mangiare, magari non molto vario e neppure buono, specie se cucina lui stesso. Però cura gli ammalati, quando c’è bisogno. Sicuramente è un tipo un po’ selvatico, ma nel complesso è accettabile, ci sono servitori peggiori.
In questo ambiente, Monsignore migliorò per i modi, che divennero assai più cortesi. Qualche volta, quando era contento, sembrava quasi che facesse le fusa. Il mio servitore approvava molto le fusa. Certo che la mancanza di cure materne si vedeva. Monsignore era sudicissimo: non si lavava mai, però era così bello che tutte le femmine, da uno a quindici anni, lo volevano: mi faceva morire di invidia. Io provai anche a chiarire con lui chi era il padrone, ma lui era troppo forte, anche se indolente: finimmo per tollerarci a vicenda. Certo mi seccava un po’ la sua presenza a casa mia: non parlava e si comportava come un originale. Amava il lusso, i cuscini, il piacere, era goloso, piuttosto feroce verso gli estranei che saltavano in giardino, ma sempre gran signore.
 Dopo due anni che Monsignore era arrivato, un altro gentlecat, somigliantissimo a lui, sicuramente dello stesso gruppo etnico, arrivò a casa mia e fu sedotto alla stesso modo. Il nuovo ospite era molto più scuro e giovane di Monsignore, ed essendo figlio di un signore che abitava in una villa vicino alla mia, parlava benissimo la nostra lingua.
Dopo due anni che Monsignore era arrivato, un altro gentlecat, somigliantissimo a lui, sicuramente dello stesso gruppo etnico, arrivò a casa mia e fu sedotto alla stesso modo. Il nuovo ospite era molto più scuro e giovane di Monsignore, ed essendo figlio di un signore che abitava in una villa vicino alla mia, parlava benissimo la nostra lingua.
Il nuovo arrivato si interessò subito a Monsignore, ma poi litigarono per una questione sentimentale e finirono per ignorarsi. Questi due gentlecats tenevano un contegno molto superbo, avevano sempre la puzza sotto il naso, credevano di essere aristocratici, tanto che non parlavano mai con gli altri e rifiutavano perfino di mangiare insieme. lo mi chiedevo quale fosse la loro origine. Qualcuno infatti diceva il Medio Oriente, la Turchia, forse la Persia. Infatti Monsignore aveva modi da sultano: un vero turco. Anche gli europei, del resto, sono una razza venuta dall’Oriente. Altri segni lasciano pensare ad un’origine più nordica di Monsignore, forse norvegese. Forse sono individui tornati dall’America, dopo alcune generazioni vissute laggiù, partendo dalla Scandinavia. Infatti Monsignore aveva delle membrane fra le dita delle mani e dei piedi, che i cittadini di questo paese non hanno; insomma, aveva le dita palmate per nuotare meglio: una mutazione tipica dei gatti nordici.
Tuttavia quello che colpiva di più, in loro, era la lunghezza del pelo: rosso come quello di una pelliccia femminile, quello di Monsignore; grigio azzurro, quello di Pelosone. Essi avevano una criniera attorno alla testa e code bellissime, immense, veri piumini per pulire le automobili. Sono anch’io di pelo rosso, però sono tigrato, pura razza Baspur (bastardo-puro), anche se il mio servitore dice che sono un British-Red.
La mia mamma mi regalò il mio servitore quand’ero ancora piccolo.
Da allora ho vissuto sempre con lui, nella mia villa sulle colline. Certo ho dovuto sopportare un po’ di cattivo carattere da parte sua: figurarsi che accoglie qualunque vagabondo arriva, addirittura senza consultarmi. E così adesso, con molti altri, ci sono anche Monsignore e Pelosone, due persiani, o forse due norvegesi. Eh, ci vuole pazienza con questi extracomunitari.
Invecchiando Monsignore ha cominciato ad allontanarsi sempre di più. Torna sempre più raramente, sudicio e magro come non era stato mai. Sono inutili le carezze ed i cibi che vengono offerti: mangia e subito scappa via. Temo molto che dopo una di queste fugaci apparizioni vada via, come è successo già a tanti e che non torni più. Il mio amico Lucignolo, per esempio, il gatto col più spiccato senso umoristico da me conosciuto, non è tornato più.
Ma io ricorderò sempre Monsignore e Lucignolo, e spero che anche loro, se non ci rivedremo più, si ricordino di me.
Pinocchio Cat
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
il racconto di domenica 13 marzo 2016
LA CIOCCOLATA
un racconto di Bruno Fedi
La guerra subì, per lui, una svolta radicale nel luglio 1942.
Fino ad allora, la propaganda, il fatto che non si sentisse dire nulla di diverso da parte di nessuno e, forse, anche la giovane età, non avevano permesso che nascesse in lui il minimo dubbio: gli inglesi erano certamente maiali, ci avevano aggrediti senz’altro motivo che non fosse quello di derubarci delle ricchezze a cui la nostra storia gloriosa, il sangue dei nostri eroici soldati ed i nostri strenui sacrifici ci davano un indiscutibile diritto.
Inoltre, gli inglesi erano mostri: bombardavano le città, uccidendo anche i civili, facevano la guerra soprattutto con lo spionaggio, ci rubavano i nostri segreti militari e non valevano nulla, di fronte all’eroismo dei nostri prodi. Certo gli aveva fatto dispiacere vedere che, per disposizione di legge, erano state segate e portate via tutte le cancellate di ferro dei giardini, anche del suo giardino, per fabbricare armi. Possibile che si dovesse ricorrere al pochissimo ferro dei giardini per fare la guerra ad Inghilterra e Stati Uniti?
 Inoltre, era difficile sopportare il razionamento dei generi alimentari: perfino le scarpe erano razionate e quelle che si trovavano in commercio erano fatte con il cartone e non col cuoio, così che duravano, al massimo, due settimane. Ma se per caso pioveva, potevano durare anche un giorno solo.
Inoltre, era difficile sopportare il razionamento dei generi alimentari: perfino le scarpe erano razionate e quelle che si trovavano in commercio erano fatte con il cartone e non col cuoio, così che duravano, al massimo, due settimane. Ma se per caso pioveva, potevano durare anche un giorno solo.
La cioccolata e lo zucchero erano scomparsi nel nulla: sembravano cose leggendarie, di cui si era sentito parlare, ma in realtà, mai esistite. Egli ricordava le paste di Bistino, oppure dei Valiani, o anche il semplice pane bolognese, come cose deliziose, assolutamente celestiali.
Le rarissime volte che aveva mangiato una pasta, fra il ‘40 e il ‘42, non aveva sentito il sapore di prima. Perfino il caffè, che aveva sempre considerato cattivo, gli sembrava squisito, nel ricordo, rispetto al caffè di ghiande, o di carrube che tutti bevevano, con l’eccezione, si capisce, dei gerarchi del regime, ai quali non poteva mancare assolutamente nulla; come avrebbero potuto prendere le loro sagge ed essenziali decisioni, per i fulgidi destini della patria?
Il desiderio di un pezzetto di pane bianco, di avere un paio di scarpe e non zoccoli di legno, o addirittura nulla da calzare, lo accompagnò fino al dopoguerra. Avere scarpe di cuoio ed un lume a petrolio, non una boccetta per l’inchiostro, riempita però di petrolio, con uno spago per lucignolo, furono, dal ‘43 al ‘45, segni di sfarzosa opulenza. Una lampada elettrica, come prima della guerra, era addirittura oltre ogni possibile desiderio. Tuttavia, la sua fiducia nella vittoria finale, negli incrollabili destini, nell’annessione della Corsica e della Savoia, oltre che di mezza Africa, era rimasta intatta.
Escludendo queste piccole difficoltà e la lontananza di suo padre, che era stato costretto a partire per lavorare per lo Stato, perchè il suo commercio era stato stroncato dalla guerra, la vita non era cambiata.
Egli andava alle scuole elementari e, durante l’estate, la sua famiglia andava in vacanza a Viareggio. L’ultima volta, però, nel 1941 c’era un’atmosfera strana: si sentiva che qualcosa stava per succedere; era nell’aria. I cannoni del balipedio sparavano continuamente e quel tuono continuo creava un’atmosfera tragica. Dal 1942, lui e la sua famiglia non andarono più al mare.
L’estate del 1942, con una banda di ragazzi, vicini di casa, lui trottava per la campagna di Pistoia, spiando da lontano gli aerei militari del campo di aviazione e dedicandosi ad un gioco affascinante: il furto della frutta dei contadini, nei campi circostanti la città.
L’impresa era resa ancor più divertente dalla sorveglianza dei contadini: la frutta era divenuta preziosa. Un giorno, tornava dal pesceto di Baracca, che faceva pesche squisite, ma che era pericolosissimo, perché il padrone era particolarmente veloce negli inseguimenti, oltre che fornito di mani durissime e callose. Capitò così, col suo amico Giuliano, morto poi, sotto le rovine della sua casa, durante il primo bombardamento, di fronte alla capanna dove i vivaisti Bianchi riponevano gli attrezzi.
La capanna era stata requisita dal regio esercito e c’erano due nostri soldati, con le loro brutte divise grigio verdi, i loro brutti stivali chiodati, le anacronistiche fasce arrotolate attorno alle gambe; cioè con l’aspetto disordinato e squallido che hanno spesso i militari che portano divise tagliate male, non di misura giusta, di lana invernale anche in piena estate. Fra i nostri soldati, tutto questo avveniva, credo, per regolamento. Insieme ai nostri soldati, che erano appoggiati alle pareti della baracca con aria annoiata e distratta, c’erano due individui stranissimi: si erano fatti la barba, portavano divise beige della taglia giusta ed avevano l’aria di chi è in vacanza.
Erano prigionieri inglesi. Egli era sbalordito che non fossero incatenati, ringhianti e mostruosi: i diavoli più volte descritti dalla stampa italiana di allora.
Si capisce che questa semilibertà, a Pistoia, nel 1942, non poteva essere utile per dei prigionieri: non potevano fuggire ed attraversare mezza Europa, oppure il mare. Ma, in quel momento, il loro stato semilibero, sbalordì l’ingenuo ragazzino. Ma, più di tutto, lo lasciò allocchito la loro eleganza: la stoffa delle divise era bella; era estiva e non invernale, come quella dei soldati italiani, sempre uguale estate ed inverno. L’aspetto era quello di due uomini normali, non di mostri; sembravano piuttosto i padroni dei loro sorveglianti e non avevano affatto l’aspetto di prigionieri guardati a vista.
Allora, mentre i due ragazzini sudati, polverosi, vestiti con canottiera, calzoni corti e vecchi scarpe di tela ereditate dai fratelli maggiori, o con zoccoli di legno, stavano lì a guardare a bocca aperta, uno dei due pretesi diavoli, figlio della perfida Albione, fece un sorriso, mise una mano in tasca ed effettuò un autentico miracolo: la sua mano riapparve con dentro una cioccolata. Com’era possibile che gli italiani non avessero più neanche il pane, ma loro, i prigionieri, avessero la cioccolata? Imbarazzatissimo il ragazzo non seppe che dire e che fare: scappò via con il suo insperato tesoro.
 Ma la guerra di un fascista in erba finì in quell’istante ed insieme alla guerra finirono le certezze inculcate dalla propaganda. Non era vero niente: gli inglesi non erano diavoli, non volevano derubarci: erano più ricchi di noi! Il ragazzo non riusciva a capire per quale ragione i giornali e tutti quanti raccontassero così tante balle su di loro.
Ma la guerra di un fascista in erba finì in quell’istante ed insieme alla guerra finirono le certezze inculcate dalla propaganda. Non era vero niente: gli inglesi non erano diavoli, non volevano derubarci: erano più ricchi di noi! Il ragazzo non riusciva a capire per quale ragione i giornali e tutti quanti raccontassero così tante balle su di loro.
Quel giorno egli uscì per sempre dalla credulità infantile e cominciò a capire che cosa avveniva: capi perché i suoi fratelli erano antifascisti, comprese i mugugni dei cittadini, che prima aveva scambiato per stupidità, contro la guerra. Più tardi, ad aprirgli gli occhi, ci pensarono i bombardamenti, non più i rumori lontani dei tiri di prova del balipedio di Viareggio, bensì bombe vere ci pensarono i rastrellamenti, le fucilazioni e alte atrocità, ma la guerra contro l’Inghilterra di un balilla immaginario finì bruscamente con la cioccolata ed il sorriso di un prigioniero di guerra.
In quegli stessi giorni, alcuni operai ricoprivano, con un muro di mattoni, le preziose statuette del “Della Robbia”, sulla facciata dell’ospedale Civile di Pistoia, per proteggerle dai bombardamenti aerei che, in realtà, non tardarono. Un noto ubriacone, figura mitica della Pistoia anteguerra, Remo Cerini, vide la previdente operazione e con la capacità profetica dei pazzoidi, subito disse: “oh statuine, belle statuine, quando rivedrete la luce, non ci sarà né Re né Duce”.
Fu profeta: nel 1946 quando i mattoni furono tolti, quei bravi gentiluomini non c’erano più.
…………………………………………………………………………………………..
Storia di Gilda e Pezzato
di Bruno Fedi
domenica, 6 marzo 2016
Gilda e Pezzato vennero in un Natale particolare. Sembrava che tutti i vicini si fossero dati una voce: “Visto che c’è un matto a cui piacciono i gatti, mettiamo i nostri nel suo giardino”. Il “matto” era il mio amico, quello che mi dà da mangiare e mi accarezza sempre. Veramente non so perché lo faccia, ma mi secca un po’ pensare che lo faccia perché è matto. Secondo me, non c’è ragione di pensare che lo sia, tuttalpiù potremmo definirlo un eccentrico.
Per esempio non difende il territorio, si chiude dentro strane trappole che si muovono su ruote, non mostra alcun interesse per i topi o le lucertole. Questo è grave. Però guarda gli uccelli, dunque, non è matto del tutto. Certo è strano: figurarsi che cambia perfino pelle, qualche volta, diverse volte al giorno. lo, per esempio, in ottobre metto il cappotto, sotto la solita pelliccia, ed in maggio lo tolgo, ma niente stravaganze, come cambiare pelle.
Una sera, un flebile miagolio mi indusse a guardare in veranda. C’erano due gattini piccolissimi, tremanti, affamati e, secondo me, disgustosi. Il giorno dopo, un ragazzo portò un altro gattino, trovato presso il cancello e un altro lo trovai io stesso, presso la siepe. Qualche giorno dopo, aprendo gli occhi, al mattino, sentii un miagolio acuto che veniva da un punto imprecisato del giardino. Dopo difficili ricerche, perché il miagolio taceva, quando io facevo i suoni di richiamo di un piccolo micio, sentendomi un po’ idiota, vidi muoversi un ramo d’albero. C’era un altro gattino ancora, salito su un alberello. Tutti i gattini furono presi dal mio amico. Una mattina però, guardando i gattini che bevevano il loro latte, vidi che ce n’era uno di più. Era arrivato da solo, durante la notte. Aveva ritrovato i fratelli. A questo punto mi sentivo sommerso dai gatti, mentre i miei amici, Monsignore, Pelosone ed io stesso stavamo a distanza, guardando con aria di profondo disgusto. Se qualche gattino si avvicinava, Monsignore e Pelosone facevano terribili soffiate.
Sì, furono mesi un po’ difficili per trovare una sistemazione a tutti, dopo averli rimessi in sesto. La sistemazione era più facile, naturalmente, per i gatti più belli. Uno dei tre fratelli, a quanto sentii dire, andò a vivere in una bella villa, in un grande giardino recintato, con due enormi maremmani che accolsero il gattino con diffidenza, ma anche con il rispetto che gli animali adulti hanno per i cuccioli, anche se di specie diverse. Personalmente, reputo i maremmani dei mostri, ma ammetto d’aver sentito dire che non uccidono, né mangiano i gattini. Evidentemente abbiamo verso gli altri animali, per esempio verso la specie a cui appartiene il mio amico, una superiorità morale: noi non uccidiamo i bambini, neppure quelli di altre specie.
Per il loro stato di incapacità a difendersi i cuccioli non vengono molestati e così si crea un rapporto amichevole che persiste anche da adulti. Un altro gattino andò in una villa dove io, molto dubbioso, temevo il peggio. Invece i figli del padrone, che mai avevano avuto gatti, dopo qualche giorno, erano letteralmente impazziti per il gattino. Anche per gli altri, per i “belli” fu relativamente facile, ma per qualcuno, più brutto, o selvatico, era un problema serio. Uno dei gatti era troppo brutto, un altro non si faceva toccare.
Gilda e Pezzato erano un caso a parte. Pezzato era l’ultimo arrivato e Gilda era bellissima. Una soriana grigio chiara con pelo a strisce argentee, come io non  avevo mai visto. Naturalmente era troppo giovane, ma anche se la mia età era abbastanza avanzata (9 anni), si apprezza la bellezza, come fanno anche gli uomini. Noi siamo anche più socievoli degli uomini, non abbiamo intolleranze, o discriminazioni sciocche per razze diverse dalla nostra, o diverso colore del pelo. Che ci importa a noi se un gatto è bianco, nero o rosso? Non abbiamo intolleranze religiose di alcun genere. Non abbiamo intolleranze sessuali: mentre gli uomini, anche coloro che si dicono nostri amici, molte volte ci uccidono i figli e alcuni li mangiano anche. Se lo facessimo noi, sarebbe considerato mostruoso, ma visto che lo fanno loro, in occasione di certe feste, è considerato un segno di religiosità, o una raffinatezza alimentare. Altre volte, questi discutibili individui vanno a caccia. Ma non come noi, per bisogno, per sopravvivere, bensì per divertimento. Quello che per noi è necessità assoluta, loro lo chiamano ferocia, mentre quello che per loro è un divertimento feroce, lo chiamano sport. Da un po’ di tempo hanno la faccia tosta di qualificare stragi inutili, dannose, immotivate, insensate, come “prelievi venatori controllati” e dicono che servono all’ecologia del territorio. Questa gente, che ha la pretesa di una superiorità morale, mentisce, adula, ruba o uccide senza aver fame, ma ha la pretesa di avere la superiorità morale su tutti. Noi abbiamo, invece, perfino l’etica interspecifica. Non ci uccidiamo fra noi e non uccidiamo i piccoli delle altre specie.
avevo mai visto. Naturalmente era troppo giovane, ma anche se la mia età era abbastanza avanzata (9 anni), si apprezza la bellezza, come fanno anche gli uomini. Noi siamo anche più socievoli degli uomini, non abbiamo intolleranze, o discriminazioni sciocche per razze diverse dalla nostra, o diverso colore del pelo. Che ci importa a noi se un gatto è bianco, nero o rosso? Non abbiamo intolleranze religiose di alcun genere. Non abbiamo intolleranze sessuali: mentre gli uomini, anche coloro che si dicono nostri amici, molte volte ci uccidono i figli e alcuni li mangiano anche. Se lo facessimo noi, sarebbe considerato mostruoso, ma visto che lo fanno loro, in occasione di certe feste, è considerato un segno di religiosità, o una raffinatezza alimentare. Altre volte, questi discutibili individui vanno a caccia. Ma non come noi, per bisogno, per sopravvivere, bensì per divertimento. Quello che per noi è necessità assoluta, loro lo chiamano ferocia, mentre quello che per loro è un divertimento feroce, lo chiamano sport. Da un po’ di tempo hanno la faccia tosta di qualificare stragi inutili, dannose, immotivate, insensate, come “prelievi venatori controllati” e dicono che servono all’ecologia del territorio. Questa gente, che ha la pretesa di una superiorità morale, mentisce, adula, ruba o uccide senza aver fame, ma ha la pretesa di avere la superiorità morale su tutti. Noi abbiamo, invece, perfino l’etica interspecifica. Non ci uccidiamo fra noi e non uccidiamo i piccoli delle altre specie.
Tornando a Gilda, anche le proporzioni, crescendo, erano divenute perfette ed il comportamento era da gatta consapevole della sua bellezza. Crescendo assumeva arie da fatalona, camminava ancheggiando, aveva un’aria da ammaliatrice ed un’espressione sorridente e felice sul viso.
Il guaio era che amava tantissimo Pezzato, dormiva perfino abbracciata con lui. lo ero un po’ geloso. Pezzato era un gatto bellissimo per le proporzioni, il pelo e l’espressione giocherellona sul viso. Ma fin dal giorno del suo arrivo aveva una terribile ferita su una coscia. Sembrava che un cane gli avesse strappato un lembo di pelliccia. Il mio amico si dette molto da fare a tenerlo pulito: pensavo che sarebbe guarito. Il pelo rinasceva lentamente e la ferita si restringeva, ma una zona, grossa come una noce, non guariva: un pezzo di tessuto sembrava sporgere fuori. In questo stato, il gattino era tuttavia felice. Giocava, mangiava, stava con la sorella, ma non lo lasciavano entrare in casa, perché perdeva la pipì. Non capivo cosa fosse successo: un incidente? Il morso di un cane? O forse il gattino aveva una malformazione per cui non poteva trattenere le urine? O forse era un tumore? Gli antibiotici somministrati per far guarire la ferita esterna, non miglioravano la situazione. Pezzato fu portato dal veterinario, e la sentenza fu ancora più brutta. Il gattino era stato sottoposto a castrazione, quando era troppo piccolo. Il veterinario disse che talvolta accadeva che gattini così piccoli rimanessero incontinenti, perché qualche veterinario, poco capace, asportava totalmente i genitali esterni.
Questo povero gatto, proprio perché era così bello, aveva suscitato qualche apprensione nei suoi ex padroni, che lo avevano fatto castrare: era rimasto così malamente ferito da essere incontinente. Ero pieno di simpatia per questo povero perseguitato: meritava un minimo di risarcimento. Poiché non poteva trovare nessuna sistemazione, sarebbe stato sempre con me. Improvvisamente, quasi tutti i gatti, uno dopo l’altro presero l’influenza. Mangiavano poco, stavano mogi mogi, abbattuti nelle loro cucce. Gilda, Pezzato e la gattina meno bella furono colpiti quasi contemporaneamente. Portati in cucce più calde, furono curati con antibiotici, perché essendo ormai ammalati, non si poteva più vaccinarli. Furono fatte ipodermoclisi di fisiologica, perché non mangiavano e non bevevano; date vitamine ed estratti corticosurrenali. Dopo pochi giorni, Pezzato e la gattina meno bella, che sembrava stessero malissimo, stavano invece molto meglio, avevano ripreso a bere.
Gilda non stava meglio. Il veterinario consigliò di cambiare antibiotico. Ma se quello usato aveva fatto bene agli altri due, perché doveva essere inadatto a Gilda? Andavo a vederla spesso. Il mio amico la accarezzava. Una delle ultime volte provò ancora a fare le fusa. Poi non tentò più, stava troppo male. Gilda respirava affannosamente; le stavo vicino ed il mio amico borbottava fra sé, come fa spesso quando è solo: “Che cosa ho sbagliato? Che cosa ho fatto? Che cosa posso ancora fare?” Ad un certo punto, la gatta sospirò e, come sempre, io pensai: “Forse respira meglio”. Invece, come sempre accade, dopo quell’ultimo respiro, più profondo e più sereno degli altri, Gilda non respirò più. Così avevo visto morire tanti gatti ed altri animali. Il mio amico era silenzioso. Seppellì Gilda ai piedi di uno degli alberi della siepe: capii che si sentiva in colpa per non aver saputo salvare la gatta. Pezzato e l’altra gattina si ripresero. Ma il povero Pezzato perdeva sempre le urine. Per il resto era stupendo, ma il suo handicap gli rendeva tutti ostili. Tutti erano disposti al litigio più serio, alla scenata isterica contro questo povero animaletto così bello, così disgraziato, così innocente della sua disgrazia, che non era neppure una fatalità, bensì una colpa del genere umano contro di lui.
Nessuno lo voleva. Il mio amico portò il gattino nella sua stanza, preparò una cuccia per lui e una lettiera. Mi sembrava impossibile accettare che un povero animale, a causa della sua bellezza, fosse stato castrato, a causa di questa disgrazia fosse stato scacciato dal giardino dei gatti ed a causa delle terribili ingiustizie che aveva subito, dovesse subire anche l’ulteriore ingiustizia che nessuno lo volesse. Ero furioso contro il mio amico che non lo aveva difeso, ma forse l’aveva fatto per il suo bene. Ho saputo molto più tardi la fine di Pezzato, che non poteva vivere chiuso in una stanza per tutta la vita. Il mio amico mi disse che lo trovava sulla finestra, quando tornava; trovava i segni delle sue zampette sui vetri. Quando era solo miagolava continuamente, impaurito dalla solitudine. Il mio amico cominciò a chiamare gli amici animalisti che avevano un gattile. Ma il gattile non andava bene: io stesso non potevo accettare l’idea che questo povero animale, che aveva subito senza potersi difendere, senza poter neppure protestare, una mutilazione, potesse essere condannato alla galera a vita nella gabbia di un gattile. Non perché fosse colpevole di qualcosa, ma proprio perché era innocente.
 Finalmente una animalista di una città lontanissima si disse disposta a prenderlo e tenerlo in giardino. Aveva un grande giardino chiuso in città, dove sarebbe stato accolto, perché ancora piccolo, da altri gatti. Nel giardino, anche se avesse perso la pipì sul prato, non avrebbe dato fastidio a nessuno. Il mio amico comprò una gabbia di vimini per portarlo. Gli dette un po’ di carne con dentro un sedativo perché non avesse paura. Ciononostante Pezzato non voleva stare nella gabbia. Il mio amico lo fece uscire. Pezzato saltò sulla spalla destra del mio amico e fece tutto il viaggio seduto sulla sua spalla. Pezzato ha visto mezza Italia, in quel viaggio. La storia mi è stata raccontata dal mio amico alcune sere in cui stavamo in giardino, al fresco e lui mi accarezzava e mi raccontava cose sue di cui non parla con nessuno. Il mio amico era preoccupato, diceva che la città dove Pezzato era andato a vivere è troppo fredda per i gatti: non si può vivere all’aperto d’inverno. Così Pezzato ha trovato una casa ed ha potuto fare la sua vita di gatto. Tuttavia io non saprò più nulla di lui, né potrò aiutarlo e sentendomi colpevole di non averlo protetto, non tenterò neppure di rivederlo. Il mio amico dice che non farà mai cancellare le impronte che Pezzato ha lasciato sul vetro della sua finestra, che rimarranno per sempre. Sempre: che strana parola. Vuoi dire finché il mio amico non andrà in pensione, cioè pochi anni, o al massimo finché lui stesso vivrà. Poi non ci sarà più alcuna traccia della sua esistenza e di quella di Pezzato. Così il povero gatto, vittima di tanta ingiustizia, non fu protetto da chi si era impegnato a proteggerlo e da coloro che lo avevano accolto.
Finalmente una animalista di una città lontanissima si disse disposta a prenderlo e tenerlo in giardino. Aveva un grande giardino chiuso in città, dove sarebbe stato accolto, perché ancora piccolo, da altri gatti. Nel giardino, anche se avesse perso la pipì sul prato, non avrebbe dato fastidio a nessuno. Il mio amico comprò una gabbia di vimini per portarlo. Gli dette un po’ di carne con dentro un sedativo perché non avesse paura. Ciononostante Pezzato non voleva stare nella gabbia. Il mio amico lo fece uscire. Pezzato saltò sulla spalla destra del mio amico e fece tutto il viaggio seduto sulla sua spalla. Pezzato ha visto mezza Italia, in quel viaggio. La storia mi è stata raccontata dal mio amico alcune sere in cui stavamo in giardino, al fresco e lui mi accarezzava e mi raccontava cose sue di cui non parla con nessuno. Il mio amico era preoccupato, diceva che la città dove Pezzato era andato a vivere è troppo fredda per i gatti: non si può vivere all’aperto d’inverno. Così Pezzato ha trovato una casa ed ha potuto fare la sua vita di gatto. Tuttavia io non saprò più nulla di lui, né potrò aiutarlo e sentendomi colpevole di non averlo protetto, non tenterò neppure di rivederlo. Il mio amico dice che non farà mai cancellare le impronte che Pezzato ha lasciato sul vetro della sua finestra, che rimarranno per sempre. Sempre: che strana parola. Vuoi dire finché il mio amico non andrà in pensione, cioè pochi anni, o al massimo finché lui stesso vivrà. Poi non ci sarà più alcuna traccia della sua esistenza e di quella di Pezzato. Così il povero gatto, vittima di tanta ingiustizia, non fu protetto da chi si era impegnato a proteggerlo e da coloro che lo avevano accolto.
Una volta ho sognato il Grande Gatto che sta nel cielo, che mi ha detto: “II tuo amico ed anche tu, micio rosso, non potrete dimenticare mai; ma io vi farò  incontrare di nuovo Gilda e Pezzato e renderò tutto il male come non avvenuto.”
incontrare di nuovo Gilda e Pezzato e renderò tutto il male come non avvenuto.”
La gatta troppo brutta per trovare un altro padrone vive invece benissimo: ha avuto un figlio, nel giardino dove fu abbandonata col suo gattino. Anch’io vivo col mio amico, ma mi allontano sempre di più nei miei giri. Ho l’impressione che il mondo debba essere molto più vasto dì come pensavo.
Sento una inquietudine che mi spinge ad andare in giro, sempre più lontano. Talvolta ricordo quando ero piccolo ed incontrai il mio amico. Per molto tempo sono vissuto da solo in quel giardino, insieme col mio amico, finché sono diventato grande. Divento sempre più selvatico, proprio come il mio amico. Ormai ho solo un occhio, dopo che una fucilata di un cacciatore mi ha accecato. Prima che sia troppo tardi, vorrei vedere qualcosa, nel mondo. Ho già tentato, ma ho sentito sempre il richiamo del mio amico: “Micio, micio, micio rosso!”. E sono tornato. Questa volta andrò finalmente a vedere il mondo, anche se sento la nostalgia del giardino di casa mia, dove il mio amico mi accarezzava e parlavamo fra noi.
Micio Rosso detto il Gattaccio
——————————————————————————————
Il primo bombardamento
di Bruno Fedi
Non avrei saputo dire se dormissi da pochi minuti o da ore, ma improvvisamente ero sveglio e completamente terrorizzato. Non capivo neppure che cosa mi avesse così spaventato, poi cominciai a capire: succedeva qualcosa di terribile, inimmaginabile, mai accaduto prima, né sentito raccontare.
Mia madre mi afferrò per un braccio urlando qualcosa. Seminudi, scalzi, corremmo giù per le scale, ma di fronte alla porta ci fermammo come paralizzati. Dal lucernario si vedeva che fuori c’era un mare di fuoco. Un rumore fortissimo faceva vibrare tutto: vetri, porte, mobili nascondendo quasi il lugubre, ossessionante, continuo ululato delle sirene d’allarme. Ma la cosa terrificante era il colore di fiamma al di fuori.
Gridai: “Non aprire, non aprire!”. Uno dei miei fratelli urlò: “Apri scemo, che aspetti?”. Poi aprì di colpo la porta.
In un attimo vidi tutto: fuori non c’era fuoco, ma fortissime, spaventose luci rosse lampeggianti, che illuminavano tutto, sospese nel cielo. Molta gente passava correndo per strada; dovunque si sentiva un gridio confuso ed un rumore tremendo che aumentava sempre; un rumore come di motori di camion, ma mille volte più grande, un rumore che faceva vibrare tutto: sembrava che gli alberi, i muri, l’aria stessa vibrassero. Nel cielo brillavano grandi luci, con immensi aloni giallastri che sfumavano nel rosso. Sembrava, e lo era veramente, l’anticamera dell’inferno. Un gruppo di persone spalancò il cancello e si precipitò nello stretto sottopasso fra il mio giardino e quello adiacente. Il cunicolo era fatto di mura di pietra, spesse diversi metri. Anche noi, in un attimo, ci infilammo dentro. Eravamo compressi fino all’inverosimile, spingevamo con tutte le forze per penetrare ancora un poco ed essere coperti dalle mura.
Faticavamo perfino a respirare, ma la paura ci rendeva insensibili. Accanto a me c’era mia madre, poco lontano mio fratello e mio nonno. Mia nonna, paralizzata dal terrore, era rimasta nel suo letto e nessuno ci pensò fino a molto tempo dopo, quando tutto fu finito.
Il rumore era diventato assordante, ma l’avevo almeno riconosciuto: erano aeroplani. Improvvisamente il rumore diventò un urlo, come quello di una macchina al massimo dei giri a cui si prema la frizione, continuando a premere anche l’acceleratore. Era l’urlo di mille giganti, l’urlo della distruttività stessa. Capii molto tempo dopo che cos’era avvenuto, dopo aver sentito più volte quello stesso urlo di distruzione. Era l’urlo dei motori, nel momento in cui le bombe vengono sganciate e l’aereo si alleggerisce di colpo. Passarono alcuni attimi eterni, poi la terra cominciò a tremare, come un essere ammalato. I muri tremavano, l’aria tremava come per paura di ciò che stava per accadere. Poi ci fu lo scoppio. L’aria si strappò come carta, come se fosse stata un corpo solido, avvolto tutto intorno a noi. Nessun racconto, nessun libro ci aveva descritto mai una cosa simile che per tutti era assolutamente inimmaginabile.
Non c’era l’aria da respirare; la terra non tremava più, ma sobbalzava, singhiozzante; i muri enormi di pietra ballavano, la polvere impalpabile accumulata sulle pareti si staccava e riempiva lo spazio, o quello che era rimasto, dove prima c’era l’aria.
I lampi ci avevano accecati, eravamo tutti come un unico corpo, sballottati da un’enorme mano, contro le mura o contro il suolo, schiacciati o sbattuti avanti e indietro senza poter opporre resistenza. Poi il grande urlo cessò. Si sentivano vagamente, con le orecchie assordate, strani rumori, forse crolli, o tonfi di pietre lanciate in aria che ricadevano, prima quelle grandi, poi quelle più piccole, finché una nube densa di polvere secca fine, con un acre odore di bruciato, scese lentamente su tutti insieme al silenzio. Sentii qualche gemito di terrore. La voce del nonno stranamente chiara disse: “Ritornano. Questa volta tocca a noi”.
Riconobbi la sghignazzata di mio fratello Franco e pensai: “E’ matto? Come fa ad avere il coraggio di ridere?”. Il rumore degli aerei, mai scomparso del tutto, andava aumentando di nuovo. Quello che era avvenuto una volta si ripeté altre volte, non so quante. Ogni volta sentivo il nonno che tirava su il morale a tutti dicendo: “Questa è la volta buona”. Poi il rumore che sbranava l’aria del cielo si allontanò e scomparve. I bombardieri non tornarono più di notte. Avevano capito che non c’erano difese, non c’erano cannoni, ma solo chiacchiere arroganti e presuntuose sui giornali. Fuori la luce era diventata rosso scura.
I più vicini all’uscita emersero fuori, la pressione dei corpi pigiati l’uno contro l’altro lentamente diminuì. Uscimmo. Le grandi luci nel cielo non c’erano più, ma il cielo era tutto rosso per il riverbero degli incendi a terra. C’era uno strano silenzio: semplicemente non sentivamo più e camminavamo in una specie di nebbia con odore di esplosivo, di calce, di polvere, che stringeva la gola. La mia casa e quella adiacente erano in piedi, ma la successiva, centrata da una bomba e quella di fronte erano un cumulo di sassi alto quattro o cinque metri, che aveva occupato la strada. Nella strada vicino alla mia, un’altra casa era stata colpita. I miei fratelli andarono a cercare di dissotterrare morti e feriti. La mattina dopo, col barroccio tirato dal ciuco di Gino Del Moro, detto l’asino sapiente, scappammo tutti in campagna, ma prima feci in tempo a vedere le squadre di scavatori e di volontari, in un disordine totale, che sembrava aver colpito tutto e tutti, estrarre brandelli di carne dalle case distrutte e gettarli in una cassetta piena di polvere bianca disinfettante.
Così furono persi per sempre Giuliano dai capelli rossi, l’amico del cuore e Mildred, la bella bambina dei capelli così neri da sembrare turchini, l’amore dell’infanzia di cui nessuno sapeva nulla, morta nel primo bombardamento, perché le loro case erano vicine alla stazione ferroviaria. Con loro, tanti sogni furono perduti. I monti ed il cielo guardavano immobili, indifferenti. Il cielo si era rotto, quella notte, i monti erano sprofondati, eppure tutto era rimasto come prima: la natura ci guardava, senza partecipare.
Vidi anche, prima di partire, in un negozio di carbonaio, il napoletano, detto “Biciccia”, che era un ferroviere e si era salvato, perché era in servizio, quella notte. Ma la sua famiglia, sua moglie e i suoi cinque figli erano lì, sdraiati nell’antro nero del carbonaio, laceri e sanguinosi schiacciati dalle macerie. Fra i morti c’era anche un bambino della mia età, con cui avevo fatto a pugni una settimana prima, pestandolo ferocemente, con l’incoscienza dei bambini. Adesso guardavo inorridito. Il senso di colpa per aver picchiato il napoletanino di otto anni mi schiacciava come le pietre che avevano ucciso lui. Il ferroviere teneva fra le braccia il corpo di uno dei figli e si dondolava come fanno gli orsi rinchiusi nelle gabbie senza colpa né peccato. Il napoletano piangeva e diceva: “Hai visto che cos’è successo, hai visto, hai visto…”.
Fu il primo incontro con la distruzione e la morte, contro ogni legge della natura e della biologia. La morte dei giovani, che non hanno vissuto; la morte senza cause naturali, perché il filo della vita è stato ormai consumato ed il gran vecchio nel cielo è un po’ più vecchio. Capii quel giorno il significato delle parole “mai più”. Mai più avrei riveduto Giuliano e Mildred. Ero schiacciato da una pena dura e pesante come un muro, crollato sopra di me. Fino a quel momento, il mio cuore non era stato coinvolto, anche se il cervello sapeva il significato delle parole e dei fatti. Da allora, lentamente e progressivamente, la parola “mai” ha acquistato un significato sempre più profondo, così che ne sento sempre più l’irrimediabilità e la mancanza dolorosa di chi non c’è più. Non dimenticare è, forse, una punizione.
Scappai da Pistoia portando con me la mia vecchia gatta. Il ciuco di Gino Del Moro, specialista in produzione aurifera, come diceva il proprietario, molto più grande di un ciuco comune, allegrone ragliante e galoppante per l’esuberanza della giovinezza, sballottandoci, ci portò tutti in salvo.
Seppi poi che mio fratello Silvano, che era un partigiano, lo usava di notte, invece della bicicletta, per spostarsi in campagna. Le auto, in quel periodo, quasi non esistevano. Le poche esistenti erano state requisite. Le moto erano praticamente scomparse, le biciclette erano rare e preziose. L’asino sapiente, diceva Silvano, aveva sulle biciclette un enorme vantaggio: a lui non si potevano tendere imboscate. Il ciuco sentiva prima se c’era qualcuno appostato e fuggiva fuori strada, per i campi dove i soldati tedeschi, o fascisti, e le auto militari non potevano inseguirlo. Era un saggio: sapeva da solo se chi aspettava per strada, o nascosto, era un amico, o un nemico; sapeva da solo dove andare e, così facendo, ha probabilmente salvato alcune vite. Un vero asino sapiente: un eroe di guerra sconosciuto. Non ho mai saputo qual è stata la fine di questo ciuco combattente. Certo il suo coraggio e la sua saggezza non sono state premiate dalla generosità degli uomini, che costringono anche gli animali a fare le guerre, rendendoli partecipi della loro pazzia. Ma se la follia della guerra è pura idiozia, che dobbiamo dire della mostruosità di uccidere, spesso in modo atroce, chi ci ha disinteressatamente aiutato, i nostri amici animali, o di condannare a morte altri nostri simili nel formale rispetto delle leggi e con l’ipocrisia di operare in nome del Dio della bontà?
 Qualche volta rivedo tutti in sogno: Mildred, Giuliano, il napoletanino, il grande ciuco dal pelo grigio chiaro, il generoso altruistico Silvano, la vecchia gatta soriana, il tormentato, coraggioso Franco.
Qualche volta rivedo tutti in sogno: Mildred, Giuliano, il napoletanino, il grande ciuco dal pelo grigio chiaro, il generoso altruistico Silvano, la vecchia gatta soriana, il tormentato, coraggioso Franco.
Questa storia fu raccontata dalla gatta vecchia al grande gattone bianco con le zampe nere ed il pelo ispido dell’Ospedale S. Maria e lui la raccontò a me, prima che il protagonista mi portasse a vivere nel giardino dei gatti, perché ero rimasto orfano.
Vederli, ancora in sogno, è una grande gioia. Sento che essi vivono dentro di me. Forse si vive e si muore sempre due volte: la prima volta quando si muore concretamente; la seconda quando si muore nel ricordo di chi ci ha conosciuto.
Red Cat detto Topino
…………………………………………………………………………………………..
Tutti si chiamavano Micio
di Bruno Fedi
Questa è una storia di un tempo lontano, quando i miei antenati rischiavano ancora di essere investiti da mostri a quattro ruote, o di essere presi al laccio da strani individui che poi li chiudevano in galera a vita, senza che mai si sapesse quale delitto avevano commesso. Come se non bastasse, la prigione era accanto al canile; dunque i prigionieri dovevano sopportare anche la vicinanza dei cani. Di certo era una raffinata forma di tortura contro di noi. Uno dei miei antenati, un giorno, capitò nel giardino di fronte alla casa di un tale, di cui i miei antenati dicevano che era un vero orso e che chiamavano McKerone, perché, in pratica, era il loro cuoco. Era anche poco intelligente, perché, per quanto ci sforzassimo, non riuscivamo a fargli imparare la nostra lingua. lo però lo considero un amico, e ne parlerò come di un amico.
La casa era molto complicata. Aveva una serie di stanze che contenevano ogni sorta di diavolerie: macchine parlanti, o urlanti, o che si accendevano improvvisamente lasciando comparire facce che cominciavano a parlare; oppure macchine che improvvisamente facevano strani rumori, o si muovevano su ruote. Ma c’erano anche morbidi divani e cuscini.
Nonostante quanto si potrebbe immaginare dalla precedente descrizione, non c’era nessun pericolo, o piuttosto un pericolo c’era: qualche volta, nella stanza più rumorosa di tutte, si trovavano, senza ragione apparente e senza averli cacciati, enormi pezzi di carne dai sapori più vari, ma sempre squisiti. Qualche volta erano dentro una macchina freddissima, che di solito era chiusa, o erano addirittura sopra un fuoco. Il pericolo stava nel prenderli, o anche annusarli, perché McKerone non mangiava mai carne, ma se si prendeva quella che si trovava, purtroppo raramente, nella sua cucina, diventava feroce. Non vi dico poi che cosa succedeva se, sedotto dalle comodità della casa, uno di noi segnava il territorio per lasciare un messaggio gentile sia a McKerone che ad eventuali signore di passaggio. McKerone cominciava ad arricciare il naso, poi annusava come se avesse sentito un odore ributtante. Infine andava con aria funerea a prendere un tubo e spruzzava in aria, o sulle pareti della sua tana, un liquido che faceva un puzzo orribile. Il meno che poteva succedere era di esser buttati fuori senza complimenti. Un giorno, il mio amico tornò dalia sua città, che si chiamava Pinsere Terram, con due individui della mia specie, che, se fossero rimasti, sarebbero morti, perché la località era troppo fredda. Erano Robin e Marian. Da allora il numero di abitanti, nella casa ormai divenuta mia, è andato sempre aumentando.
Ma non è il solo guaio. Questo mio amico è un cattivo cuoco, molto irregolare nei pasti e, come se non bastasse, ci ficca in gola certi intrugli disgustosi, quando siamo malati. Oppure ci infila aghi sotto la pelle della schiena. Ma, per quanto sembri strano, dopo ci sentiamo meglio. Ad uno di noi, McKerone fece addirittura una serie di tagli nella pelle e tirò fuori i proiettili da cui era stato colpito. Comunque la vita con lui è istruttiva: non ci sono molte occasioni di caccia o pesca, ma si riflette di più. E’ incredibile, nonostante McKerone faccia le cose che ho detto, quanto sia ignorante. Avreste dovuto vedere la sua faccia il giorno in cui osservando distrattamente uno dei gattini che giocava con una pallina di carta, capì il significato del gioco.
Mentre guardava, egli capì che il gatto immaginava un gioco, fingeva che la pallina fosse, per esempio, un topino. Quindi la gettava in aria, poi la rincorreva, poi la gettava di nuovo. McKerone capì che il gattino immaginava, dunque pensava: era capace di immaginare una cosa, diversa dalla realtà! Dunque era capace di pensiero astratto? Non solo ma era anche capace di evocare immagini diverse dalla realtà. Del resto – pensava McKerone – gli uomini stessi descrivono le astrazioni con immagini naturali; per esempio: bella come la luna, dolce come la primavera… Le stesse scoperte scientifiche e gli stessi esperimenti debbono essere immaginati, prima di essere effettuati.
Dunque gli uomini pensano astrattamente, per immagini, per simboli? Ecco perché il pensiero, anche quello umano, procede per salti, ecco perché anche in un ragionamento, una teoria fisica, un’equazione, alcuni ricercatori rievocano la bellezza, l’armonia. Ecco perché alcuni rifiutano una teoria, non perché illogica, ma perché innaturale, non in armonia con la natura; esteticamente non bella! La presunzione di McKerone ricevette un fiero colpo, dal gattino che giocava con una palla di carta, molto di più di quanto fossero riusciti a fare i suoi amici filosofi e scienziati.
Un’altra volta capì che gli animali sanno contare.
L’ho sentito io stesso meravigliarsi che il cuculo metta il suo uovo in un nido e getti via una delle uova presenti. McKerone, sbalordito, diceva: ma allora gli uccelli contano le uova; si accorgono se ce n’è una in più o in meno! Non sapeva neppure che gli animali distinguono maschi e femmine. Ha avuto il sospetto quando ha visto il nostro comportamento con gli uomini e con le donne. Il comportamento sentimentale, simil-umano, dice lui pomposamente, che teniamo con le donne, lo sbalordisce. Questo presuntuoso non capisce, per esempio, che un signore di una certa età, come me, possa esser disturbato dall’arrivo di un neonato urlante. Dunque non capisce perché io abbia ritenuto opportuno cercare una situazione meno lussuosa, ma anche meno rumorosa, quando lui ha portato a casa dei gattini lattanti. Non capisce che io, alla mia età, non posso essere preso in braccio e trattato come un bambino: ho quasi dieci anni! Soprattutto, McKerone non capisce che io possa venir colpito nel mio amor proprio, provare gelosia e invidia, vedendo la facilità con cui un gattino lagnoso e miagolante viene accolto da lui come ospite di riguardo, nutrito, alloggiato, coccolato.
 Comunque, il mio amico imparò molto dalla storia di Robin e Marian, i due gatti pistoiesi. Per esempio, imparò che nei gruppi organizzati in città, dove non c’è stata l’educazione materna, non c’è l’ordine di beccata, cioè l’ordine di precedenza nel mangiare, come lo chiama Lorenz, anche se, per noi, è ordine di mangiata. McKerone non aveva voluto separare Robin e Marian, perché erano fratelli ed erano piccolissimi. I primi giorni fu necessario nutrirli con latte, iniettato in bocca con una siringa. Marian era una meticcia siamese, bellissima, come molti meticci. Però era bionda e con splendidi occhi celesti. Robin era un soriano molto scuro con un cuore di pelo bianco sul petto, che lo rendeva bellissimo. I due crebbero normalmente nei giardini, ma i guai cominciarono quando furono adolescenti. Per evitare l’incremento demografico, Marian fu sterilizzata. L’intervento fu senza dolore e, del resto, Marian non seppe mai di essere sterile. Ma McKerone, per evitare di accorciarle la vita, non volle toglierle le ovaie. Così Marian era sterile, ma aveva gli ormoni in modo perfettamente normale. Siccome non restava mai incinta, era sempre in amore. Fu un’altra scoperta per McKerone.
Comunque, il mio amico imparò molto dalla storia di Robin e Marian, i due gatti pistoiesi. Per esempio, imparò che nei gruppi organizzati in città, dove non c’è stata l’educazione materna, non c’è l’ordine di beccata, cioè l’ordine di precedenza nel mangiare, come lo chiama Lorenz, anche se, per noi, è ordine di mangiata. McKerone non aveva voluto separare Robin e Marian, perché erano fratelli ed erano piccolissimi. I primi giorni fu necessario nutrirli con latte, iniettato in bocca con una siringa. Marian era una meticcia siamese, bellissima, come molti meticci. Però era bionda e con splendidi occhi celesti. Robin era un soriano molto scuro con un cuore di pelo bianco sul petto, che lo rendeva bellissimo. I due crebbero normalmente nei giardini, ma i guai cominciarono quando furono adolescenti. Per evitare l’incremento demografico, Marian fu sterilizzata. L’intervento fu senza dolore e, del resto, Marian non seppe mai di essere sterile. Ma McKerone, per evitare di accorciarle la vita, non volle toglierle le ovaie. Così Marian era sterile, ma aveva gli ormoni in modo perfettamente normale. Siccome non restava mai incinta, era sempre in amore. Fu un’altra scoperta per McKerone.
Scoprì che i nostri cicli amorosi sono dovuti alle gravidanze e non il contrario, come credono tutti. Senza gravidanze, noi siamo sempre in amore, come la specie a cui appartiene McKerone. Ciò era disastroso per il povero Robin. Il giardino era continuamente pieno di enormi spasimanti di Marian che venivano da grandi distanze, attratti tutto l’anno dal profumo dei feromoni. Marian era la più grande seduttrice del luogo. Il giardino era sempre pieno di gente che litigava con urla terribili, specie durante la notte. Al povero Robin toccava sempre la peggio, perché era troppo giovane. Poi anche Robin s’innamorò di Marian. Ma lei, che aveva avuto ogni sorta di fidanzati, non voleva saperne di lui. Gli preferiva un vecchio signore bianco, con un aspetto spelacchiato. Questo signore aveva anche un orecchio solo, perché l’altro era caduto dopo aver ricevuto una scarica elettrica, una volta che era penetrato in una cabina.
Robin tentò col corteggiamento, tentò con le serenate, tentò coi messaggi odorosi, ma non ci fu verso. Un giorno Robin e Marian erano in giardino a prendere il sole, a qualche metro di distanza l’uno dall’altro. Robin rimuginava qualcosa, perché ad un tratto saltò su e si lanciò, senza preavviso, con un urlo acuto e disperato contro Marian. Marian corse qua e là, poi fuggì attraverso il prato e Robin l’inseguì oltre la strada, fino ad un bosco vicino. Tornò più tardi, solo. Aveva cacciato Marian, che era sempre in amore, perché non era ovariectomizzata e, senza alcuna colpa, non lo amava. Marian non tornò. Vennero altri individui, Robin diventò molto grosso, il Tom Cat del vicinato. Era sempre molto bello e molto buono, se non si considera il trattamento inflitto alla sorella.
Passarono cinque anni. Un giorno d’estate McKerone, che aveva inutilmente cercato Marian, la vide strisciare stremata, ansimante, magrissima, verso la casa.
Robin la vide, certo la riconobbe, ma non disse nulla, né le dette alcun fastidio. La situazione disperata di Marian la rendeva intoccabile anche per lui, che l’aveva inutilmente amata e poi scacciata per gelosia. Marian fu curata e si riprese, ma aveva ormai un po’ di pancia. La mezza età era arrivata anche per lei. Il dottore disse che erano le ovaie, che non si sarebbero dovute lasciare, perché pericolose: formavano cisti. Con il tentativo di far del bene a Marian, McKerone le aveva fatto del male: l’aveva fatta scacciare dal fratello ed adesso che era vecchia e malata, Marian era tornata a casa. Evidentemente sperava di essere accolta e curata.
McKerone pensava che, invece di cisti ovariche, Marian fosse malata di cuore. Comunque fu curata e visse ancora anni, piuttosto bene, senza essere più l’affascinante ammaliatrice di un tempo, ma esteticamente ancora bellissima e molto amata da McKerone. Morì d’inverno, durante una notte freddissima.
McKerone lai trovò irrigidita sotto il porticato dove dormiva, accanto alla sua cuccia.
Sentendosi morire si era trascinata fuori, ma McKerone non l’aveva sentita. Egli si sentì sempre in colpa per questo. Robin, il signore col giustacuore bianco visse ancora un anno. Saliva sulla finestra illuminata, dove McKerone lo accarezzava. Robin e Marian erano riusciti a gattizzare abbastanza McKerone, che aveva imparato molto da loro: l’estro continuo, forse anche per l’abbondante alimentazione, le preferenze personali, la gelosia, il perdono. Gli animali, o almeno tutti i mammiferi, avendo lo stesso encefalo, hanno, come è logico, anche gli stessi sentimenti. E’ assurdo ciò che dicono alcuni, evidentemente illogici ed ignoranti: cioè che gli animali non hanno sentimenti, ma istinti. Avendo le stesse strutture anatomiche nervose, è assurdo pensare che queste strutture esistano, ma non siano funzionanti. Del resto l’etologia, lo studio del comportamento, l’hanno dimostrato. Ma basta osservare due gatti, o due cani, per vedere che essi provano simpatia, antipatia, gelosia. Alcuni si succhiano un dito, come i bambini degli animali umani.
 L’inverno successivo, Robin era in amore; era fuori di casa da alcuni giorni, sotto la pioggia. Robin tornò a casa ammalato di cimurro. McKerone lo mise nella sua cuccia e lo curò. Il giorno dopo Robin non stava meglio. McKerone chiamò uno specialista. La cuccia fu portata in casa al caldo. Robin non beveva. McKerone cominciò a fargli delle ipodermoclisi contenenti vitamine, antibiotici, estratti minerali. Robin peggiorava. Fu cambiato l’antibiotico, aumentata la dose. McKerone andava da Robin ogni due ore. La sera verso le sei, McKerone trovò Robin che respirava malissimo, il respiro accelerava e poi rallentava, poi di nuovo accelerava. Non riconobbe il suo amico e non si comportò con la cortesia tipica della sua specie, come sempre aveva fatto fino ad allora, nonostante fosse così malato.
L’inverno successivo, Robin era in amore; era fuori di casa da alcuni giorni, sotto la pioggia. Robin tornò a casa ammalato di cimurro. McKerone lo mise nella sua cuccia e lo curò. Il giorno dopo Robin non stava meglio. McKerone chiamò uno specialista. La cuccia fu portata in casa al caldo. Robin non beveva. McKerone cominciò a fargli delle ipodermoclisi contenenti vitamine, antibiotici, estratti minerali. Robin peggiorava. Fu cambiato l’antibiotico, aumentata la dose. McKerone andava da Robin ogni due ore. La sera verso le sei, McKerone trovò Robin che respirava malissimo, il respiro accelerava e poi rallentava, poi di nuovo accelerava. Non riconobbe il suo amico e non si comportò con la cortesia tipica della sua specie, come sempre aveva fatto fino ad allora, nonostante fosse così malato.
Ad un tratto sembrò stare meglio. McKerone ebbe l’impressione dì un accenno di fusa. Robin emise un lieve sospiro, poi si rilassò. McKerone sperò, per un momento, che stesse meglio. Poi capì. Robin era morto. McKerone sentiva che non era stato capace di proteggere i suoi amici. Seppellì Robin nel giardino, accanto alla sorella Marian. Due grandi pietre verdi che vengono dal fondo del mare segnano il luogo dove sono sepolti, non lontano da molti altri, feriti in incidenti, senza che McKerone fosse riuscito a salvarli, o morti anch’essi di cimurro, come Gilda, (un’altra ammaliatrice), o come un grande tasso, ucciso da una macchina e raccolto, da McKerone. Oggi, in quel giardino, ci sono tanti di noi sotto e tanti sopra la terra: io stesso, Pinocchio detto il Gattaccio, Lucignolo, Monsignore, Pelosone, Topo e Topino, Pezzato l’Autistico, l’Orbo, che non è orbo per nulla e sua madre.
McKerone ci chiama tutti Micio.
Conforto Gattoso
——————————————————————————————————————–
Ai gatti sepolti e alle stelle lontane
di Bruno Fedi
Introduzione
Il giardino dei gatti esiste realmente ed è la sede di una serie di osservazioni etologiche, cliniche, psicologiche, evoluzionistiche, ma anche il luogo dove sono vissuti animali reali o, qualche volta, immaginari. Le loro imprese sono state talvolta raccontate dai loro stessi compagni.
I racconti sono l’occasione per animali sapienti – talora scienziati, o filosofi, totalmente antropomorfizzati – di esporre le loro idee e le loro ragioni, le loro critiche ai cacciatori, ai carnivori, ai politici senza contatto con la realtà, ai ricercatori senza cuore e spesso senza cervello, ai religiosi poco misericordiosi, a tutti coloro che si comportano con crudeltà, con insensibilità, o anche semplicemente con incoerenza. In poche parole contestano la società nella quale, per misteriose ragioni, per una inspiegabile simpatia, alcune specie di animali entrarono a far parte, in epoche remote.
Sono racconti che dovrebbero far pensare, trattando argomenti seriosi, i ragazzi di tutte le età. Gli altri animali grotteschi, ma anche gli uomini, espongono i loro sentimenti, la nascita del linguaggio, della fantasia, dell’idea stessa di Dio, la loro solitudine di precursori e di “diversi”, nelle storie di Smilodon, di Ariman e dell’asino sapiente, in cui è accennata anche la presa di coscienza animalista, con molta disinvoltura nei confronti della realtà storica e dell’evoluzione.
Queste storie sono dedicate a chi ama gli animali e li osserva; dunque a coloro ai quali la storia di Gatto Lucignolo può interessare. Questo animale era dotato di spirito umoristico, tanto che faceva finta di gettarsi da una finestra e mi sghignazzava chiaramente in faccia quando, preoccupato, mi precipitavo a guardare di sotto, trovando il gatto comodamente seduto su una trave.
Sono debitore a “Lucignolo”, a “Conforto Gattoso”, al povero orso di Acquasparta e a tutti gli altri, di molta comprensione e di un po’ di serenità. La mia opinione, forse utopica, è che tutti siamo loro debitori. Li ricordo con affetto in questi racconti, perché credo che il valore di un vivente, gatto, cane o uomo che sia, non dipenda da ciò che realizza, o da ciò che tenta di fare, ma da ciò che pensa: ciò che pensa “è” la mutazione che fa compiere un passo avanti, nella storia dell’evoluzione comune a tutti. Finché li ricorderemo non saranno morti.
L’autore
Smilodon
Essi erano sempre stati un gruppo speciale, perché non vivevano con tutti gli altri ma da soli, formando un clan familiare chiuso. Smilodon (nome scientifico della tigre dai denti a sciabola, nda) era il più speciale di tutti, perché era l’unico con occhi azzurri, anziché scuri. Nessun altro li aveva avuti mai. I suoi occhi avevano provocato grande meraviglia in suo padre e sua madre e poi in tutti gli altri esseri della sua specie che aveva incontrato.
Egli non ricordava quasi più suo padre e i suoi fratelli; ricordava vagamente e sempre più raramente sua madre, ma talvolta li sognava, rivedendoli sempre con grande gioia; ricordava anche gli insegnamenti ricevuti dai genitori, che erano divenuti, oramai, atti automatici. Da sua madre aveva imparato a cercare e strofinare fra le mani pochi fili di un’erba apparentemente secca; poi soffiava via la pula e rimanevano alcuni semi.
Con questo metodo elementare, ripetendo più volte l’operazione, lui e i suoi fratelli si erano procurati tante volte una manciata di semi, sufficienti per sopravvivere in zone desertiche, aride, sabbiose. Talvolta, con suo padre, fin da quando era piccolissimo, aveva cercato un’erba speciale che sporgeva dalla terra con un solo filamento, che sembrava secco. Appena lo trovavano, essi scavavano ed estraevano una specie di grosso tubero. Anch’esso sembrava secco, ma grattandolo con un pezzo di pietra e spremendo quella specie di segatura, usciva un mezzo sorso d’acqua, indispensabile a non morire di sete.
Il padre e i fratelli maggiori gli avevano insegnato ad acchiappare qualche piccolo animale.
Gli esili segni del passaggio di un coniglio, o di un serpente, sul terreno, non gli sfuggivano, mentre l’improvviso volo degli uccelli gli rivelava l’avvicinarsi di un predatore e gli squittii delle scimmie sugli alberi, o fra le rocce, erano un segnale di vita: se c’erano scimmie c’era anche acqua.
Gli era sempre riuscito difficile accendere il fuoco: egli aveva chiesto più volte cos’era il fuoco, suscitando le risa dei fratelli, che, però, non avevano saputo rispondergli: per loro il fuoco era fuoco e basta. O forse era un Dio.
Per fortuna, una giovane femmina, da lui incontrata un giorno ed a lungo inseguita, finché si era arrestata esausta, era bravissima nell’accendere fuochi. La femmina aveva un’abilità che lo aveva lasciato stupefatto: sapeva accendere e soprattutto conservare il fuoco, senza farlo spegnere mai, entro una zolla di terra. Questo fatto straordinario aveva cambiato profondamente la loro vita. Le notti erano diventate più sicure, avendo sempre il fuoco ed erano anche più calde: c’era quella luce meravigliosa che rendeva la notte più breve, mentre essi stavano a guardare, sognando ad occhi aperti.
Incontrare la femmina era stata una grande fortuna. Quando l’aveva vista, l’aveva subito inseguita, istintivamente, per tutto il giorno, finché l’aveva raggiunta, ma così si era separato dal suo ultimo fratello.
Dopo averla raggiunta ed aver giocato con lei provando un’immensa gioia, si era sentito inquieto, ed era tornato indietro, con la fanciulla che lo seguiva, ma con in cuore l’angoscia di chi è rimasto solo. E veramente non aveva più trovato né suo fratello, né sua madre. Suo padre e gli altri erano già scomparsi da tempo. Quasi tutti erano andati a caccia e non erano più tornati.
Adesso era toccato a lui rimanere solo. Era rimasto molto tempo nella zona dove aveva sempre vissuto ed in cui si vedeva, lontana, una lunga montagna rossastra, finché un grande incendio lo aveva costretto a fuggire, correndo per giorni e giorni, sempre col rischio di essere raggiunto dal fuoco, o calpestato da qualche branco di animali che fuggivano, impazziti per il terrore.
Non aveva mai pensato che esistessero tanti animali e che il mondo fosse così immenso. La pianura e le colline sembravano vuote prima dell’incendio; invece gli animali erano tantissimi.
Così aveva per sempre perduto anche il luogo dove era nato e si era sempre più allontanato, in quella terra sconfinata, seguendo gli animali, oppure fuggendo dai predatori e dalle zone paludose, che non gli erano familiari.
Era diventato un buon cacciatore: aveva appuntito un lungo bastone.
Con quello poteva colpire un animale lontano molte volte la lunghezza del bastone, prima ancora che l’animale si spaventasse e fuggisse. Più tardi, girando la carne arrostita sul fuoco, aveva fatto una scoperta sensazionale: la punta del bastone si induriva e diventava di gran lunga migliore. Ma se teneva il bastone troppo vicino al fuoco, la punta, invece di indurirsi, diventava più fragile, o bruciava.
Qualche volta, fin da quando viveva con la sua famiglia, aveva incontrato, o intravisto, altri come lui. Si erano avvicinati con diffidenza e avevano anche cacciato insieme, ma poi si erano sempre separati. Mai lui e suo padre avevano accettato di andare con altri a vivere in un gruppo numeroso. Adesso temeva che altri come lui tentassero di portargli via la femmina. Da lei erano nati dei cuccioli: egli si era sentito straordinariamente felice ed aveva finalmente visto ciò che lo rendeva così straordinario: molti cuccioli avevano gli occhi azzurri.
Alcuni cuccioli poi erano morti. Non sapeva perché, ma altri erano cresciuti e si erano persi, come era avvenuto a lui stesso, o se ne erano andati, o erano stati uccisi.
Adesso era di nuovo solo con la sua femmina, che, ormai, non era più una fanciulla. Talvolta guardava il cielo: aveva notato che quei due fuochi che passavano abbaglianti lassù, durante il giorno e durante la notte, non nascevano e non tramontavano nello stesso punto: quando i fuochi nascevano tardi e percorrevano un breve tratto di cielo, i giorni erano più freddi. Questo fatto lo aveva indotto a pensare: suo padre stava sempre curvo guardando la terra e gli alberi, seguendo le piste. Egli invece stava molto più a lungo in piedi. Preferiva camminare guardando spesso il cielo, specie il punto dove il fuoco del giorno nasce e quello dove tramonta. Faceva così, per scegliere la direzione dove andare. Aveva orgogliosamente pensato: “E’ stato guardare il cielo ciò che ha permesso di vedere non solo le prede ed i nemici lontani, ma anche tutti quei piccoli fuochi con strani disegni, lassù. Un giorno ci sarà uno come me, che si ricorderà di me, come io di mio padre e capirà che è stato guardare il cielo e non solo le chiome degli alberi, o le impronte sulla terra, ciò che ha dato origine a tutti i sogni”. Un po’ turbato, aveva pensato: “Questa stessa idea mi è venuta guardando il cielo.”
Quei due fuochi nel cielo, così belli, pensava, erano forse il padre e la madre di tutti: erano qualcosa di più grande di tutto e di tutti, erano la sorgente della vita. Sentiva per loro reverenza, timore ed attrazione: aveva capito che il calore, quello che il fuoco del giorno gettava su di lui, dipendeva da quanto era lungo il suo viaggio nel cielo, ma non riusciva a farlo capire alla sua compagna ed ai cuccioli. Questi viaggi, del Dio luminoso nel cielo, non erano sempre uguali: si allungavano, poi si accorciavano e poi si allungavano di nuovo. Egli si chiedeva perché e pensava: “Un giorno qualcuno capirà che cosa sono questi fuochi nel cielo e da dove sono venuti: non è possibile che siano venuti dal nulla e scompaiano nel nulla”.
Queste fantasie occupavano i suoi momenti di riposo e lui tentava di comunicarle alla sua compagna; aveva sempre sognato molto; crescendo era diventato un sognatore ad occhi aperti. Smilodon si spostava sempre nella direzione della luce che tramonta. Gli piaceva quel momento: c’era qualcosa di commovente, che lo faceva fantasticare sul futuro e sentire il dolce ricordo del passato. I suoi sogni riguardavano spesso ciò che sarebbe avvenuto. Collegava i fatti passati, per immaginare il futuro. Con la sua fantasia si muoveva attraverso il tempo, verso il futuro irraggiungibile, mentre lui stesso camminava verso occidente inseguendo la luce, verso il gran fuoco del tramonto, ugualmente irraggiungibile.
Nonostante tutti i pericoli continui, sentiva dentro di sè la smania di andare, specialmente laggiù dove il Dio del giorno spariva nella terra. Egli desiderava fuggire nello spazio, come se fuggisse verso il futuro, prima che tutto finisse per sempre. Smilodon aveva paura. Possibile che anche lui, anche la sua fanciulla sarebbero scomparsi nel nulla? Forse altri uomini come lui, sarebbero venuti e sempre ci sarebbero stati uomini che si sarebbero ricordati di lui, il primo uomo con gli occhi chiari, il primo uomo che, guardando il cielo, aveva imparato a sognare.
Spesso ricordava quando i figli erano stati cuccioli e quando la femmina aveva parlato con loro la prima volta, con grande dolcezza. Con sua meraviglia, essi avevano imparato molto rapidamente a ripetere ciò che diceva la madre: anzi presto avevano parlato più di lui e della sua compagna, che pure era molto più abile di lui nell’esprimersi con parole e talvolta ne inventava di nuove.
La cosa lo aveva riempito di sorpresa ed anche di rabbia, ma poi aveva pensato: i cuccioli di questi cuccioli impareranno molte cose, forse capiranno anche ciò che io non capisco.
Talvolta sognava veramente durante il sonno e rivedeva il padre e la madre, certamente morti da molto tempo, oppure sognava di correre verso la luce del cielo. Qualche volta, nel sonno, incontrava molti strani esseri diversi da lui, eppure simili. Egli sentiva che quegli animali erano lui stesso. Uno di questi animali gli aveva mostrato i due fuochi nel cielo e gli aveva spiegato tutto: solo che risvegliandosi non era stato capace di ricordare la spiegazione. Altre volte pensava che l’animale del sogno non poteva essere come lui: era molto più grande, con pelle molto chiara, senza peli, con strani capelli non arruffati, ma riccioluti e corti. Gli occhi, però,; erano azzurri ed i denti canini erano come i suoi, più lunghi di quelli degli altri. La sua femmina, infatti, quando si erano incontrati, tanto tempo prima, gli aveva fatto capire, sorridendo, che egli somigliava alla tigre con i denti a sciabola, a causa dei grandi canini: era stato per questo che lo aveva chiamato Smilodon.
Talvolta lo angosciava la sensazione del tempo che passava e l’apparente inutilità della vita, sperduto com’era in quella immensa solitudine. Lo strano gigante che aveva più volte sognato, una volta gli disse: “II tempo è una radiazione, che si espande e si comprime. La freccia del tempo va sempre in una sola direzione: verso la morte. L’entropia può andare in una direzione, o in direzione opposta, ma sempre verso la morte. Ma il Dio che è puro amore, non ti farà morire per sempre”. Smilodon sentiva di aver capito tutto. Quando si svegliava, non riusciva a ricordare e non capiva come mai, in sogno, avesse avuto quella meravigliosa sensazione di aver compreso e risolto ogni dubbio.
Quando sognava così, si svegliava sempre felice del fatto che gli amici dei sogni, i giganti, sapessero tutto, non solo sui fuochi del cielo, ma su ogni cosa. Sentiva molto il rimpianto dei suoi genitori e l’incertezza del futuro. Spesso sentiva la solitudine: si domandava se esistessero ancora gli esseri uguali a lui, che un tempo aveva incontrato. Pensava che forse sarebbe stato meglio vivere con loro.
Chissà – pensava – se avrebbe continuato per sempre a cacciare animali, mangiarli e cercare di non essere a sua volta mangiato dai predatori: sentiva dentro di sé la paura dell’ignoto, ma anche l’ansia di vedere sempre che cosa c’era al di là delle colline e delle montagne. Era un curioso e per questo invidiava gli altri animali, per esempio i lupi, che, con un semplice osso, sembravano felici. Per un po’ di tempo, un gruppo di lupi lo aveva seguito da lontano, nella caccia ed aveva mangiato il poco che restava delle prede, dopo che lui e i suoi si erano sfamati. Un giorno, un animale si era accorto di lui troppo tardi e, fuggendo, era finito fra i lupi, che lo avevano sbranato. Allora mangiare i loro resti era toccato a lui. Da allora, quando il cibo era stato abbondante, aveva sempre buttato le ossa sbruciacchiate verso gli occhi impassibili, o interrogativi, nel buio, lontano dal fuoco. Aveva anche avuto un’idea: quando non riusciva a raggiungere le prede, cercava di spaventarle e spingerle verso i lupi, così che lui, o i lupi, avrebbero ucciso più animali ed il cibo non sarebbe mai mancato.
Era rimasto sorpreso di vedere come i lupi avessero capito immediatamente e copiato la sua tecnica: essi erano abilissimi a trovare gli animali ed a spingerli dove lui aspettava, con le sue rozze lance.
Alcuni lupi erano quasi amichevoli. Col tempo avevano preso l’abitudine di avvicinarsi al fuoco, senza alcun atteggiamento minaccioso; questa era una fortuna, perché, da un po’ di tempo, faceva molta più fatica a difendersi dai predatori e ad inseguire le prede; molte gli sfuggivano. Inoltre a lui, i lupi, le linci e perfino gli animali che mangiava, erano simpatici: gli piacevano molto.
Si sentiva amico degli orsi e dei puma. Solo i rettili gli facevano orrore. Sarebbe stato bello, pensava, vivere tutti insieme, senza mangiarsi gli uni con gli altri; ma le bacche, i semi, le radici non bastavano, per quella vita pacifica che sognava.
Talvolta parlava agli animali che aveva ucciso e, verso sera, a qualcuno dei lupi più vicini. Egli diceva a qualcuno dei lupi: “Sei bellissimo, vieni qui da me, sii mio amico, io mi sento amico tuo e vorrei vivere sempre con te, con voi, con tutti gli animali, correndo in un paese bellissimo, dove non esista la paura e la morte.”
Una sera, dopo uno dei suoi soliti tentativi di colloquio, un grosso lupo gli rispose: “L’amicizia che senti per noi è ciò che rimane della nostra antica fratellanza, della nostra comune origine. In quel tempo, che sembra ormai lontanissimo, noi tutti vivevamo insieme ed eravamo tutti assai simili gli uni agli altri. Noi non ci temevamo e non temevamo il buio notturno, non ancora rotto dalla grande luce scoperta dalla tua donna. Non temevamo il buio, perché non c’erano uccisioni. Esse sono cominciate e sono continuate di notte. Ora noi ricordiamo quel tempo e, in memoria di allora, alcuni sentono amicizia per gli altri, ma tutti ormai temiamo e sempre temeremo il buio. Tu sei l’unico che ricordi la nostra antica fratellanza. Forse ci saranno, un giorno, uomini come te che la ricorderanno e, con il loro pensiero, perforeranno le tenebre del tempo fino ad arrivare a noi”. Egli aveva ascoltato tremando. Quando il lupo tacque, saltò il piedi e gridò: “Che significa comune origine, che vuoi dire antica fratellanza, com’è che tu parli come me?”. Ma il lupo sorrideva, mostrando i denti; lui, che non aveva capito nulla, pensò di avere sognato.
Da un po’ di tempo anche la sua femmina era più debole. Egli si era sentito stranamente spaventato: non osava pensare di non trovarla più, tornando dalla caccia.
Avrebbe tanto voluto incontrare di nuovo suo padre, e i suoi fratelli, o la fanciulla com’era tanto tempo prima ma anche incontrare altri che sognassero e pensassero come lui.
Allora aveva finalmente capito ciò che aveva spinto suo padre e sua madre a vivere in un gruppo isolato: la loro famiglia. Si era reso conto che la cosa che aveva desiderato di più, nella sua vita, era sapere il perché delle cose, ma anche vivere con la sua femmina ed i suoi cuccioli. I suoi sogni, i suoi pensieri, la sua fanciulla ed i suoi cuccioli erano stati l’unica realtà; più reali della lancia che aveva perfezionato, del fuoco che la sua fanciulla aveva imparato a conservare. Sentiva che altri avrebbero intuito, o forse veramente sentito i suoi pensieri, più a lungo di quanto avrebbero conservato la lancia a punta indurita dal fuoco; sentiva che guardando il cielo, sognando ed immaginando, aveva fatto qualcosa di grande, anche se non era stato sufficiente a liberarlo dalla paura, dalla morte, dalla solitudine ed a dargli la felicità, se non per brevi attimi.
Egli sentiva che tutto era nato dal sentimento, dall’amore che aveva creato i rapporti fra lui, la sua famiglia, la sua fanciulla, i cuccioli. Dai sentimenti era nata la curiosità. Dal guardare il gran Dio fiammeggiante ed i tramonti erano nati la lancia a punta indurita, la collaborazione con i lupi e la stessa idea di Dio.
Bruno Fedi