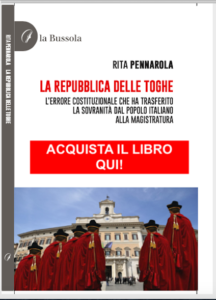-Torna in un libro il capolavoro di Ettore Scola –
Esce in questi giorni da Gremese il libro di Paolo Speranza “C’eravamo tanto amati”. Una monografia che, nel cinquantenario dall’uscita del film, ne ricostruisce la genesi, ne ripercorre la storia e le storie, accompagna il lettore scena per scena grazie a un vasto e gustoso corredo di testimonianze, aneddoti, curiosità. Per gentile concessione dell’autore ne pubblichiamo alcuni stralci.
«Noi questa sera abbiamo visto un film…stupendo!», esclama uno dei tre protagonisti di C’eravamo tanto amati, Nicola, nel concitato dibattito al cineforum di Nocera Inferiore su Ladri di biciclette.
Sebbene non comparabile al capolavoro di De Sica e Zavattini, e dallo stesso Ettore Scola non riconosciuto esplicitamente come il proprio film preferito, anche per C’eravamo tanto amatil’aggettivo “stupendo” si rivela meritato e calzante, per il livello di qualità artistica riconosciuto da pubblico e critica in tutto il mondo ad un’opera cinematografica che ha narrato mirabilmente non solo trent’anni di storia italiana ma soprattutto le emozioni (e le tensioni) profonde suscitate nell’animo umano dai sentimenti eterni ed universali dell’amore, dell’amicizia, dell’aspirazione ad un mondo migliore.
TRE AMICI NELLA GRANDE STORIA
Nella sceneggiatura l’originario soggetto metacinematografico (Ucciderò Vittorio De Sica) senza dubbio originale e ironico ma piuttosto angusto, segnato da una irrisolta dicotomia tra l’omaggio al grande cinema italiano e la parodia dell’intellighenzia di estrema sinistra, fu ben presto diluito in un trattamento molto più ampio e ambizioso, in cui alla memoria del Neorealismo si affiancava l’altra pagina gloriosa della storia italiana recente: la Resistenza (che peraltro, per dirla con Luchino Visconti, è la vera “madre” del rinnovato cinema italiano nel dopoguerra).
«Da questo primo spunto – ricorda il regista nel libro Il cinema e io, nella lunga conversazione con Antonio Bertini – la sceneggiatura si è allargata ad altri personaggi e Nicola è solo uno dei tre che, con propositi meno assassini, vive anche lui tutte le delusioni di una stagione di grandi speranze». Del resto, aggiunge Scola: «Mi ha sempre appassionato il confronto tra la storia degli individui e quella ufficiale dei grandi eventi, delle guerre tra le nazioni. Eventi lontani che irrompono dentro le nostre case, nei nostri sentimenti, nei rapporti di amicizia, di amore».
 È la stessa suggestione che ispirerà altri capitoli importanti della filmografia di Scola, da Una giornata particolare (nella cornice della visita di Hitler a Roma) a Mario, Maria e Mario, dove il contesto politico-sociale che sconvolge le relazioni umane e affettive dei protagonisti è la sofferta transizione dal Pci al Pds.
È la stessa suggestione che ispirerà altri capitoli importanti della filmografia di Scola, da Una giornata particolare (nella cornice della visita di Hitler a Roma) a Mario, Maria e Mario, dove il contesto politico-sociale che sconvolge le relazioni umane e affettive dei protagonisti è la sofferta transizione dal Pci al Pds.
Tornando a C’eravamo tanto amati, non appare oggi secondaria la circostanza che alcuni attori erano accomunati dalla partecipazione attiva alla Resistenza (Nino Manfredi, partigiano a Roma; la famiglia di Giovanna Ralli, comunista) o dalle persecuzioni contro gli ebrei, che coinvolsero la famiglia di Gassman e videro impegnata in nobili gesti di solidarietà Elena Fabrizi. Lo stesso Camillo Marino che ispira il personaggio di Nicola aveva militato come partigiano tra Avellino e Salerno.
Soprattutto, la presenza nel cast di Aldo Fabrizi suggellava un’ideale e nobile continuità con Roma città aperta, capolavoro del Neorealismo e film-simbolo per eccellenza della lotta per la libertà del popolo italiano contro l’orrore nazista.
TRE VITE DIFFICILI
La rilevanza del tema politico non fa tuttavia di C’eravamo tanto amati un titolo riconducibile al filone del cinema “resistenziale”, che alcuni film importanti aveva prodotto nell’immediato dopoguerra e – dopo oltre un decennio di oblio – aveva conosciuto la sua stagione più fertile e di maggior successo popolare all’inizio degli anni Sessanta, con film di qualità apprezzati in tutto il mondo come Il generale Della Rovere di Rossellini, La lunga notte del ’43 di Florestano Vancini, Il Gobbo di Carlo Lizzani, usciti nel 1960, le due opere di Nanni Loy Un giorno da leoni (1961) e Le Quattro Giornate di Napoli (1962) e, nel ’61, il film di Dino Risi Una vita difficile, l’unico di questo importante sottogenere cinematografico ad avere un’eco evidente nel successivo film di Scola.
In C’eravamo tanto amati gli autori portano sul grande schermo una Resistenza etica e idealizzata, più che di azione militare: alla sequenza della guerriglia partigiana contro una colonna tedesca vengono dedicati meno di due minuti nella parte iniziale, e nel corso del film qualche veloce flashback, sempre in bianco e nero, rievocato nella coscienza tormentata di uno dei protagonisti, Gianni, né vediamo immagini di sangue e di morte. La lotta di Liberazione, in questo film, è una vicenda più lirica che epica, vissuta sull’onda di generose utopie giovanili e, nel corso degli anni, elaborata con i toni elegiaci della nostalgia e del rimpianto, che nell’animo di Nicola e soprattutto di Gianni finiscono per cedere il posto ai sensi di colpa e ai rimorsi per le scelte di vita incoerenti e, nel caso di Gianni, persino opposte rispetto ai sogni di un tempo.
Il contrasto stridente tra l’ideale e il reale, tra l’utile e il giusto, tra una rivoluzione impossibile e il trasformismo accattivante e pervasivo è il tema di fondo del film, che si riverbera, fino a consumarla nel caso di Gianni, nella vita e nelle scelte politiche dei tre protagonisti. Ma soltanto per l’avvocato di successo, l’unico (presunto) vincente dei tre, quel contrasto interiore si rivelerà disperato e senza uscita. Per Nicola, e in misura maggiore in Antonio, “il ricordo di quei giorni”, che riecheggia nella canzone del gruppo partigiano in cui hanno militato, resterà sempre un punto di riferimento, un’ancora di salvataggio e anche di legittimo orgoglio, politico e personale: come a voler affermare che, più che il bilancio esistenziale e il livello di benessere materiale raggiunto, nella battaglia della vita contano di più lo spirito e gli obiettivi per i quali si è lottato.
Il sogno di libertà e di giustizia vissuto nei giorni della Resistenza è come un fiume carsico che periodicamente viene sommerso dalle contraddizioni dei suoi militanti, ma nei momenti cruciali riemerge dal subconscio con un impeto ancora più forte: come nella vicenda di Silvio Magnozzi, il partigiano di Una vita difficile, che nella travagliata transizione alla democrazia cerca in ogni modo di restare coerente ai suoi ideali, poi cade e infine si riscatta – anche agli occhi della donna che ha sempre amato – con un clamoroso gesto liberatorio. In C’eravamo tanto amati quel personaggio interpretato da Alberto Sordi rivive in qualche misura nelle vicissitudini e nei tormenti di altri partigiani, suoi coetanei e compagni di fede politica, ma la scelta di Scola, Age e Scarpelli di diluire la vita difficile degli ex combattenti per la libertà in tre protagonisti, di pari rilievo, conferisce a questo film una visione d’insieme più ampia e l’occasione per un’autoanalisi collettiva di un’intera generazione e dell’Italia più democratica e progressista.
Scopri di più da La voce Delle Voci
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.