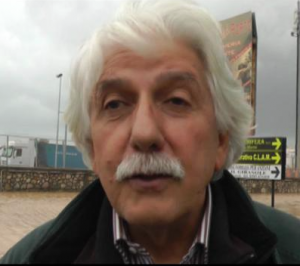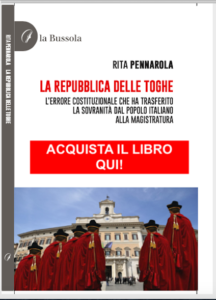Campi Flegrei, continua senza tregua lo sciame sismico, al ritmo di oltre un centinaio di scosse al giorno. E cresce l’allarme tra la popolazione, che passa una notte sì e l’altra pure fuori casa.
Nessuno, però, guarda all’altra faccia del drammatico problema, avvertito e segnalato solo da qualche ricercatore indipendente, pochissime mosche bianche come il geologo Riccardo Caniparoli, che abbiamo intervistato alcuni giorni fa.
Ossia il pericolo dei “gas e vapori letali” che si stanno accumulando nel ventre di quell’area, proprio come in una gigantesca pentola a pressione che rischia da un momento all’altro (parliamo comunque dei prossimi mesi) di “scoppiare”, con l’espulsione nel raggio di almeno un chilometro di fanghi bollenti & gas mortali.
I ricercatori dell’‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia’ (INGV), comunque, sono al lavoro per monitorare in modo continuo quanto succede, soprattutto per tenere sotto stretto controllo i due fenomeni più preoccupanti: ossia il sollevamento della terra, circa un centimetro al mese, come solo ai tempi del bradisisma di oltre 40 anni fa, nel 1983 (ma allora a un certo punto si fermò); e l’avvicinamento costante dei punti ‘critici’ alla superficie, marina o terrestre, passati da 4, poi a 3 fino a 2 chilometri nel giro di alcuni mesi.
Nel momento in cui questi parametri non si fermano e continuano nella loro drammatica escalation, allora c’è ben poco da fare: se non evacuare l’area nel raggio, appunto, di un chilometro, un chilometro e mezzo (la Conca di Agnano, l’area Pisciarelli delle ‘fumarole’ e la zona della celebre Solfatara a Pozzuoli).
Ma partiamo dai recentissimi studi elaborati dall’INGV e pubblicati sia sulla rivista specializzata ‘Journal of Vulcanology and Geothermal Research’ che sulla prestigiosa ‘Nature’.
La ricerca si intitola “Chemical and isotopic characterization of groundwater and termal waters from the Campi Flegrei Caldera / Southern Italy”, ed è stata condotta dall’equipe dell’Osservatorio Vesuviano che fa capo all’INGV in collaborazione con quelle del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo, del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università Federico II di Napoli e del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Milano-Bicocca.
 Passiamo in rapida carrellata i passaggi salienti del significativo studio, una bussola per orientarsi in un mare di problemi e di interrogativi più che inquietanti.
Passiamo in rapida carrellata i passaggi salienti del significativo studio, una bussola per orientarsi in un mare di problemi e di interrogativi più che inquietanti.
Spiega Stefano Caliro, responsabile INGV di ‘geochimica dei fludi’ e per il monitoraggio dei vulcani campani: “Il lavoro rappresenta il primo studio esaustivo sulla geochimica della falda flegrea dal 2005, data d’inizio dell’attuale fase bradisismica, e permette di conoscere i complessi processi che riguardano le differenti caratterizzazioni delle acque, fra cui l’aggiunta di gas vulcanico-idrotermali e i loro processi di degassamento, contribuendo alla definizione del modello geochimico del sistema”.
Aggiunge Giovanni Chiodini, dirigente di ricerca associato presso l’INGV a Bologna: “I processi geochimici identificati sono strettamente connessi, ma ognuno domina in regioni specifiche del sistema idrotermale, causando quindi la grande variabilità nella composizione delle acque sotterranee all’interno della caldera. Nei Campi Flegrei coesistono, infatti, acque fredde di origine meteorica, acque bicarbonate termali originate dalle interazioni con i gas nelle aree periferiche del sistema, acque clorurate derivate da soluzioni saline ad alte temperature e, infine, acque sotterranee dell’area Solfatara-Pisciarelli dove gioca un ruolo determinante la condensazione di vapore ricco di zolfo”.
Osserva poi Alessandro Aiuppa, docente all’Università di Palermo e componente della ‘Commissione Grandi Rischi’: “L’indagine ha avuto lo scopo di comprendere meglio i processi chimici che influenzano la composizione delle acque sotterranee. Attraverso l’analisi di 114 campioni raccolti in una minuziosa misurazione tra il 2013 e il 2014, abbiamo sviluppato un modello geochimico che permette di descrivere l’evoluzione dell’interazione di acque meteoriche con soluzioni saline idrotermali e gas vulcanico durante il suo percorso sotterraneo”.
Conclude il direttore dell’INGV, Mario De Vito: “I risultati di questa ricerca permettono di progettare e realizzare una rete multi parametrica permanente di monitoraggio delle acque nella caldera, attiva dal 2018 ed in continua evoluzione. Ciò rappresenta uno strumento essenziale per rilevare modifiche nel sistema e riconoscere eventuali segnali circa la ripresa dell’attività vulcanica”.
In soldoni, dallo studio emerge una preoccupazione di base per l’aumento, nel corso degli ultimi anni, delle quantità di acido solfidrico/zolfo magmatico (in linguaggio chimico, l’indicatore è H2S), aumentate di ben 5 volte rispetto al passato (anche ai tempi del bradisisma ’83).
L’altro indicatore – ottimo per misurare la temperatura o la ‘febbre’ della caldera – che vale come un Sos è la quantità di anidride carbonica emessa dalle famose fumarole, ormai note in tutto il mondo (ma ben presenti, tanto per fare due esempi di fenomeni geyser, nel Parco di Yellowstone, negli Usa, ed in Islanda). Ed anche in questo caso è stata registrata una sensibile, più che preoccupante impennata nei valori: da un media passata di 3.000 tonnellate al giorno, oggi a ben 5.000, quasi il doppio!
Commenta ‘il Corriere del Mezzogiorno’, costola partenopea del Corsera: “La comunità scientifica non è concorde nel valutare il livello di pericolosità dell’attuale situazione. Mentre per i responsabili dell’INGV e dell’Osservatorio le preoccupazioni esistono ma non riguardano l’immediato (e soprattutto escludono che vi siano precursori di un’eruzione a breve termine), non la pensano così altri esperti dello stesso INGV, anche autori di importanti ricerche sui Campi Flegrei, i quali insistono affinché si proceda all’immediato adeguamento sismico delle abitazioni o anche all’evacuazione di una parte della popolazione, almeno nell’area Solfatara-Pisciarelli-Agnano”.
Sorgono spontanei alcuni interrogativi da novanta.
C’è una spaccatura ‘scientifica’ (e forse anche ‘politica’) all’interno dell’INGV?
Si fronteggiano un’ala allarmista e un’ala attendista?
O cosa?
Poi. Come mai, su tutta la vicenda, non si sente una parola della Commissione Grandi Rischi che è l’anello strategico della Protezione Civile?
Come mai gli stessi vertici della Protezione Civile – al di là delle visite rituali in zona e dei comunicati di prassi – sulla drammatica sostanza dei fatti restano totalmente zitti e muti? Ben compreso, ovviamente, il ministro Nello Musumeci?
E soprattutto: come mai, ancora una volta, la vera emergenza dei GAS e VAPORI LETALI resta sempre in ombra, nascosta come una sorta di innominabile entità?
Perché sempre, solo e comunque si parla di TERREMOTO, evacuazioni per un possibile SISMA e via di questo passo?
Come abbiamo cercato di fare nei due pezzi precedenti di apertura (l’intervista a Caniparoli e l’inchiesta successiva), proviamo a fornire due chiavi interpretative sul motivo che, forse, fa porre sempre in pole position il fantasma del terremoto (rammentando bene quello devastante del 1980 che flagellò l’Irpinia e la Basilicata), glissando in clamoroso – e a nostro avviso colpevole – sull’altra ‘pistola fumante’.
Abbiamo già scritto di un business che procede da tempo, quello dei fondi pubblici per le ristrutturazioni degli edifici in funzione antisismica. Un pozzo di San Patrizio, in tempi di crisi economica nera.
E adesso proprio in questi giorni, quatta quatta, sta per essere ufficializzata (e quindi diventare operativa) la “POLIZZA CATASTROFALE”, prevista dalla lege di Bilancio 2024 che introduce l’obbligo per “tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da catastrofi e calamità”, come alluvioni, terremoti, frane, inondazioni, esondazioni e via sfracellando. A quanto pare, entro fine febbraio sarà approvato il decreto attuativo, contenente le regole applicative. E poi, dal 31 marzo 2025, di conseguenza scatta l’obbligo della polizza assicurativa catastrofale. Le imprese che non si adeguano, non potranno più usufruire di alcun finanziamento pubblico, comprese le garanzie finora concesse dal Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese.
Capita l’aria che tira, gas e vapori compresi?
Scopri di più da La voce Delle Voci
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.